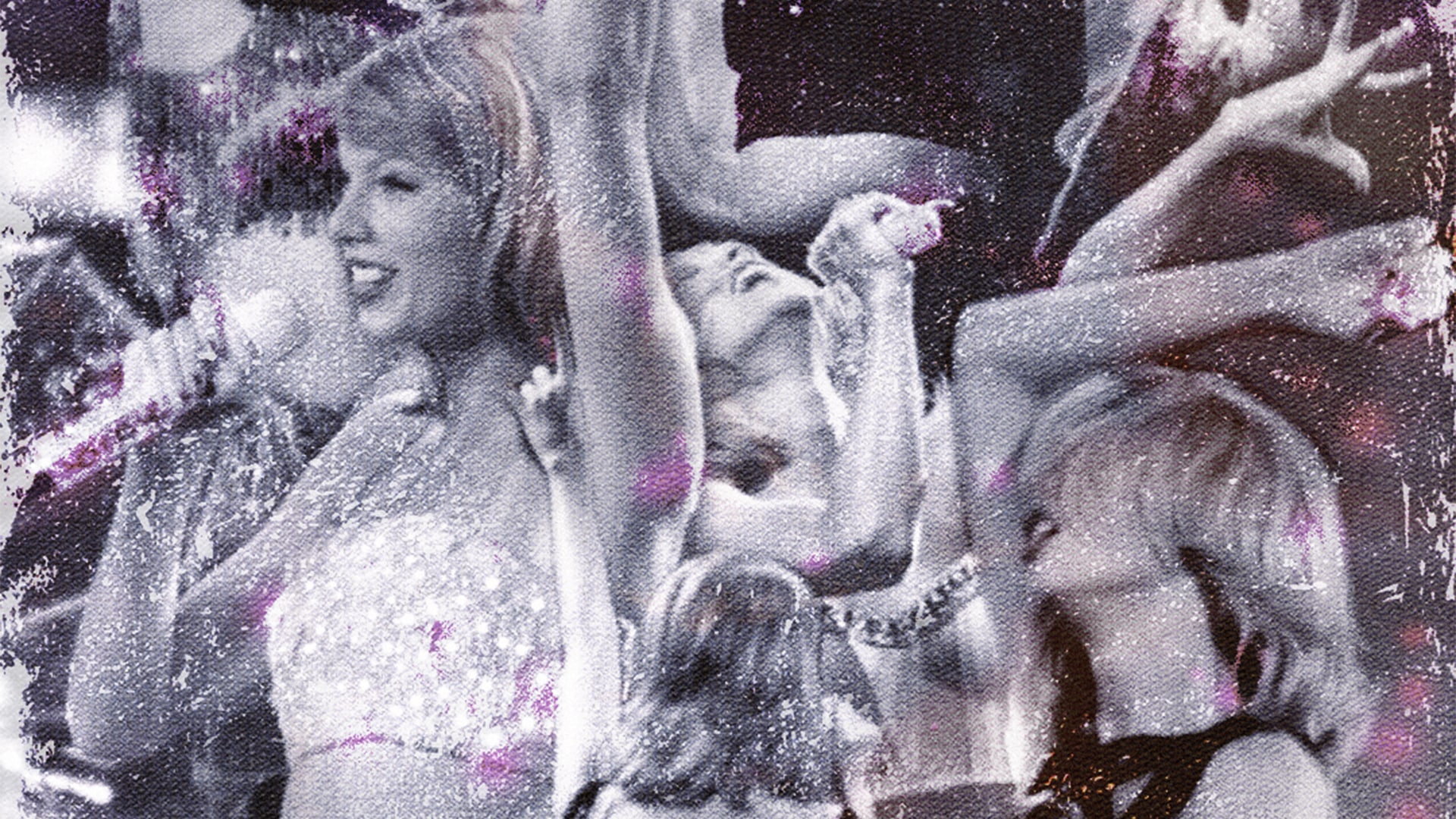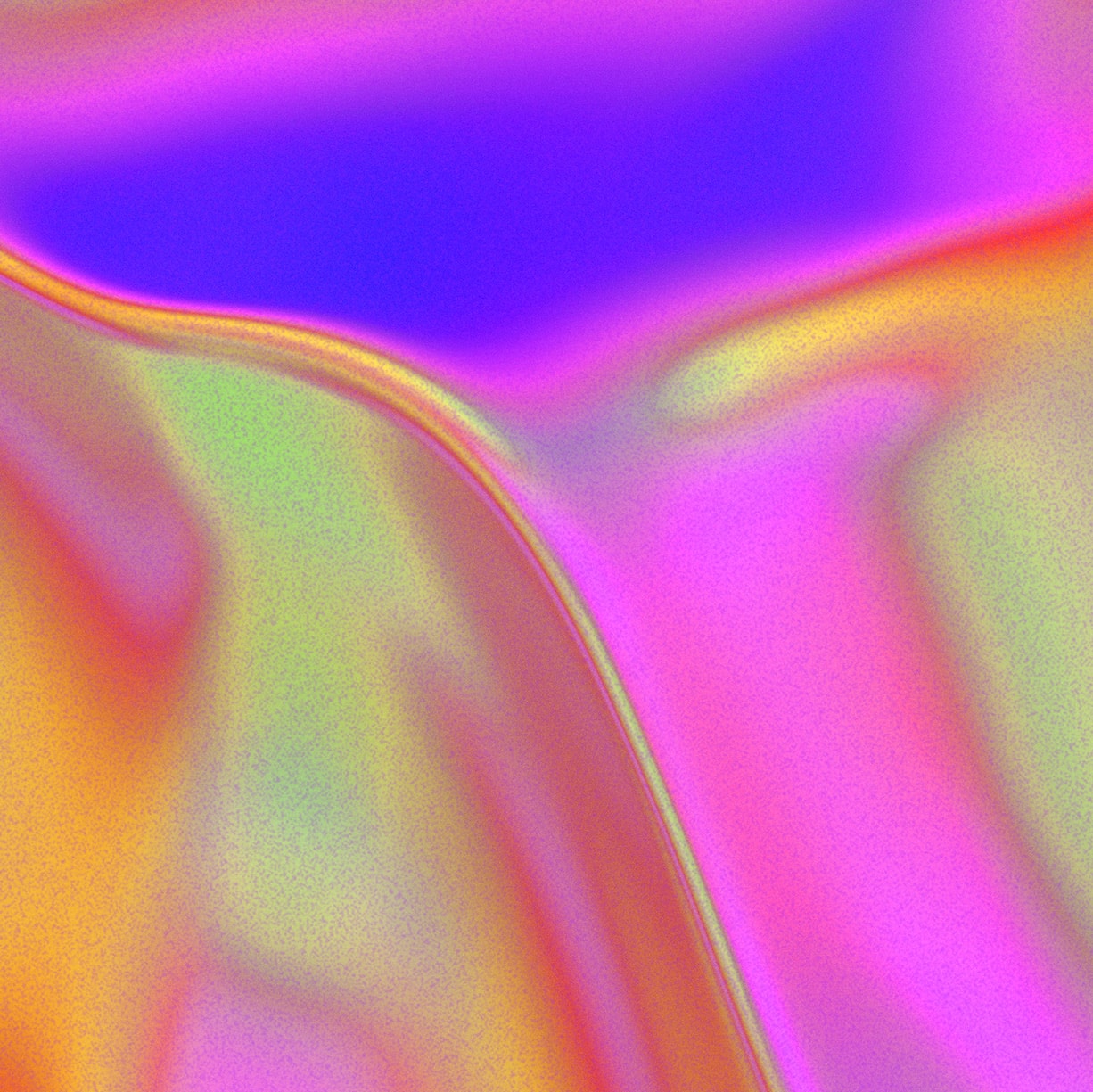L’afrofuturismo è l’incontro tra culture23 min read
MUSICA • AFROFUTURISMO

La tradizione musicale africana è viva, reale, vibrante. Non è una cartolina sbiadita, non un annoiato comunicato stampa intriso di stereotipi e un linguaggio da secolo scorso. La musica africana è persone, strumenti, luoghi specifici, oggetti e ideali che sfuggono alle generalizzazioni, che devono essere raccontati nella loro complessità – possibilmente dai loro protagonisti. La variabile diacronica e quella diatopica la caratterizzano in modo unico.
Da una parte lo scorrere del tempo è piegato a proprio piacimento, tanto in materia di pura grammatica musicale che nella comunicazione tra diverse generazioni. Con la stessa attitudine la storia della diaspora africana, i suoi incessanti movimenti attraverso lo spazio, hanno contribuito alla nascita dei generi musicali più importanti del diciannovesimo e ventesimo secolo. Influenzando di rimando la stessa musica contemporanea del continente africano, infondendola di un’attitudine porosa, collaborativa.


Raffaele Costantino da anni prova a misurarsi con questo delicato intrigo. Voce storica di Rai Radio 2, per cui conduce Musical Box, è da tempo collaboratore instancabile dei principali festival e iniziative a tema musicale presenti in Italia e all’estero. Nel tempo il suo lavoro si è sforzato di espandere il gusto italiano, aiutandolo ad abbracciare sempre più la black music contemporanea, con un’attenzione particolare alla musica proveniente direttamente o indirettamente dal continente africano. Provando a rimanere alla larga dalle semplificazioni, con uno spirito di ricerca propositivo a fare da stella polare.
Khalab è il suo alias artistico, un producer/sciamano afrofuturista (così viene spesso definito all’estero) con all’attivo due album ufficiali: Khalab & Baba del 2015 (con il percussionista Baba Sissoko) uscito per la newyokese Whonderweel Recordings e Black Noise 2084 del 2018 per la londinese On The Corner Records. La sua musica è un mix di elettronica stratificata, suoni africani originali, bassi potenti e flirt jazzistici. Dicevamo della collaborazione e dell’incontro, fondamentali per la musica africana contemporanea così come per la carriera di Khalab, che si è sempre appoggiato a numerosi musicisti per le sue creazioni. È proprio da questa spinta comune che nasce il suo ultimo lavoro, M’berra: un disco nato dal viaggio di Raffaele in un campo profughi nel sud-est della Mauritania, nel 2017; dalla collaborazione con quello che per l’occasione è stato denominato “M’berra Ensemble”. Un viaggio reso possibile dall’ONG italiana Intersos e il cui prodotto artistico è stato raccolto dall’etichetta Real World Records di Peter Gabriel.
«Anni fa durante una riunione con Intersos, per cui mi occupo di fare consulenza musicale, mi raccontarono che c’era questo campo in Mauritania al confine con il Mali. Dentro erano ospitati moltissimi tuareg, rifugiati dalla guerra civile in Mali. Stavano da così tanto tempo in questo campo (una ventina d’anni) che dentro si era creata una vera e propria scena musicale. Anche perché ospita cinquantamila persone, è più popoloso della maggior parte dei piccoli comuni italiani».
L’Africa ospita sette dei dieci campi profughi più grandi e popolosi del mondo, occupando stabilmente il podio. I primi quattro posti sono tutti del Kenya, con i campi di Kakuma, Hagadera, Dagahaley e Ifo – principalmente a causa delle guerre civili in Sud Sudan e Somalia. Formatisi tutti nei primi anni novanta, oggi messi insieme ospitano quasi quattrocentomila persone.
Pensando al concetto di un campo profughi si potrebbe ipotizzare un luogo esclusivamente temporaneo e di passaggio, dalla vita breve. In realtà la maggior parte di questi campi hanno diversi decenni di vita alle spalle e all’interno gli abitanti hanno iniziato ad auto organizzarsi da tempo, ad esempio generando locali scene artistiche, come nel caso di Mbera. Qui è una decina d’anni che la crisi del Sahel riempie il campo per lo più di rifugiati maliani – ma anche provenienti da altri stati, spesso di etnia tuareg. Campi che versano spesso in condizioni più che complicate e che sono quasi inaccessibili. «L’unico modo di andarci era con una missione ufficiale. Non avevo un’idea precisa di quello che poi avrei tirato fuori dall’esperienza, non sapendo a cosa andavo incontro. All’inizio pensavo esclusivamente a qualcosa di stampo giornalistico, di reportage. Quando sono arrivato e ho capito com’era la situazione invece abbiamo iniziato a registrare musica».
Come inizia la collaborazione tra gli abitanti di un campo profughi della Mauritania quasi irraggiungibile e un producer italiano piombato lì all’improvviso?

«Al mio arrivo hanno organizzato una sorta di festival, di “showcase”, per farmi vedere tutte le band del campo. L’ensemble l’ho creato io, loro erano tutti musicisti che facevano parte di diverse band sempre all’interno del campo e che già si mescolavano continuamente; ognuno conosce benissimo lo stile dell’altro. La composizione poi era mista, uomini e donne. Ad un certo punto ci hanno proprio tenuto tutti ad invitarmi ciascuno nelle proprie tende, per farmi ascoltare la loro musica più in intimità. Ad esempio mi ha colpito molto questa signora che suonava un violino maliano tradizionale. Uno strumento pazzesco con una ritmica impossibile, un’intonazione indecifrabile e delle melodie sbilenche – incredibile».
Il Mali è un paese famoso per la cultura degli strumenti a corda. «Quando parli del Mali, parli del luogo dove è nato tutto. Tutte le altre culture musicali che fanno parte della vasta regione del Sahel si ispirano a quella strumentazione lì. Anche perché in questi luoghi è in un certo senso la strumentazione stessa che fa poi la tradizione musicale. Gli strumenti vengono costruiti a seconda delle esigenze, in particolar modo parlando dei tuareg, si devono poter trasportare facilmente». Qualche anno fa la musica tuareg ha vissuto un momento di grande popolarità, che continua oggi con minore intensità. Quasi all’improvviso gruppi come i Tinariwen, Les Filles De Illighadad, gli Etran Finatawa o artisti come Mdou Moctar e Bombino sono diventati “pop”, presenza fissa nei festival di mezzo mondo (brandizzati come “bluesmen del deserto”). È difficile non riscontrare l’influenza delle loro sonorità ipnotiche su formazioni che oggi suonano un certo tipo di musica strumentale, ad esempio gli americani Khruangbin. Ma anche su quella fetta di elettronica dall’orecchio aperto ai suoni del mondo – in Energy, l’ultimo disco degli inglesi Disclosure, uno dei singoli è proprio il brano featuring gli Etran Finatawa.
In un certo senso non c’è tanta differenza tra un accampamento tuareg nel deserto del Sahara e un club della periferia londinese.
La ripetizione che si trova negli arpeggi delle chitarre tuareg e nelle voci evocative che emergono da quel magma sonoro, incanta tanto quanto le pulsazioni ritmiche di una fetta di club culture. Sono due rituali: quella sensazione di calore, di ascesi musicale personale e collettiva, è un qualità che appartiene ad entrambe le culture; così come l’uso della ripetizione, dal punto di vista tecnico. Da una parte strumenti tradizionali e chitarre elettriche, dall’altra sample distorti e lavorati, usati come chiavi di volta per la costruzione dell’architettura di brani interi. Raffaele conferma: «Per me la musica è trance. Per questo mi piace la musica dei tuareg, loro fanno un pezzo con una solo linea melodica o pulsazione ritmica senza variazioni per dieci minuti, a me quella roba manda in trance, mi fa impazzire. Anche per questo quando collaboro con jazzisti (abituati ad evoluzioni costanti, spesso restii alla ripetizione) come Tommaso Cappellato, che suona nel disco, campiono e metto in loop passaggi specifici».

Tutte queste caratteristiche descrivono bene la musica di M’berra. I synth di Khalab e gli strumenti dei musicisti si incontrano a metà strada, componendo un eccitante racconto di fantasia. «Il disco di vero non ha niente, non trovi quello che è successo veramente. Non è un documentario è fiction, è arte. Mi sono inventato un mondo parallelo come avevo fatto con Black Noise, in cui immaginai un mondo afrocentrico nel 2084. Qui l’idea invece è stata di andare a prendere spunto da storie e raccontarle romanzate. La forma di ciascun progetto per me deve essere nuova ogni volta, altrimenti non c’è il gusto della sfida».
A volte durante l’ascolto siamo così immersi “nell’ambiente” che ci viene da girare la testa e guardarci intorno. I fruscii, le voci, i piccoli rumori di oggetti che si scontrano e cadono sembrano essere nella nostra stanza. Quando poi le batterie e i suoni di Khalab irrompono sulla scena, quelle forme “reali” sono stravolte, trasportate in contesti lontanissimi – mantenendo comunque la loro identità. Per questo viviamo una piacevole sensazione di straniamento. Pur venendo trasportati in un mondo immaginario popolato da forme e suoni, spiriti che si parlano non verbalmente, riusciamo sempre a capire dove finisce uno e dove inizia l’altro. Un vero e proprio incontro tra culture.

«Io mi ero portato synth, campionatori etc. C’era questo scambio continuo in cui loro strabiliavano me e io strabiliavo loro. Quando sono tornato a Roma, ho applicato il solito processo che faccio con tutti i musicisti: li ho usati come se fossero dei dischi da cui campionare. Poi magari ad un certo punto sentivo che mi mancava un raccordo melodico e quindi ho chiamato Adriano Viterbini, che è l’unico chitarrista “tuareg” che abbiamo in Europa».
Adriano Viterbini negli anni si è costruito una credibilità internazionale come pochi altri musicisti italiani: dagli esordi grunge-blues con i Bud Spencer Blues Explosion, passando alla carriera solista fatta di una ricerca meticolosa del puro linguaggio blues, per arrivare all’afrobeat-punk degli I Hate My Village e alle collaborazioni proprio con artisti maliani e tuareg: Rokia Traoré e il già citato Bombino. La sua chitarra emerge spesso durante i brani, un terzo agente ben distinto e dal ruolo preziosissimo che come un grande attore caratterista tiene insieme il tutto, infondendogli ancor più legittimità senza rubare la scena. È lo stesso Adriano che mi racconta il processo «abbiamo fatto un paio di giorni di jam session sui campionamenti e su ritmiche improvvisate in studio. Ci siamo divertiti a registrare chitarre che potessero far da collante, per disegnare ancora meglio il viaggio che aveva in testa Raffaele. Ho cercato di entrare nella testa dell’artista per capire di che cosa avesse bisogno; un po’ di elettricità e chitarra suonata in studio poteva fare bene da contrasto. Una specie di hi-fi e lo-fi insieme, è affascinante».
Il timbro di Adriano sulla chitarra è riconoscibilissimo. Chi ha suonato uno strumento qualunque, sa quanto è difficile arrivare a sintetizzare una cifra stilistica personale, immediatamente riconoscibile all’ascolto. Per Adriano il progressivo avvicinamento alla musica africana inizia da lontano «ho avuto la fortuna di avere un papà che per lavoro faceva spesso missioni all’estero e gli capitò anche di andare in Niger, a Niamey. Mi ricordo che portò a casa (parlo di inizi anni 2000) una cassetta con delle registrazioni di alcuni musicisti locali, non particolarmente virtuosi, ma ricordo che comunque mi colpì molto, era diversa da tutto quello che ascoltavo allora». Scoprire, studiare e poi confrontarsi direttamente con i musicisti africani ha significato in realtà indagare tanto, ben al di là della mera tecnica musicale. «Conoscere anche quel linguaggio mi ha aiutato a trovare la mia voce e quindi a mischiare tante cose insieme, dialogare con più musicisti, ma allo stesso tempo di esser capace di trovare sempre il mio spazio. Quando ho suonato con Rokia Traorè ho avuto il privilegio di poter condividere il palco con un altro grande musicista, Mamah Diabatè. Lui è un maestro dell’n’goni, una sorta di chitarra tradizionale maliana. In qualche modo ho cercato di risuonare quello strumento ma con la chitarra. Quindi capire le accordature, i fraseggi. Li ho coniugati con la mia fantasia e mi sono ritrovato ad avere tra le mani una specie di algoritmo. Ogni volta che lo suono è come se ritrovassi me stesso»

Ritrovare e riscoprire se stessi grazie all’incontro artistico, al viaggio e il confronto culturale.
Fa male parlarne oggi, data la situazione in cui ci troviamo. Ma quello che afferma Adriano spontaneamente, e che lo stesso Raffaele ha in qualche modo reso il leitmotiv della sua carriera, è di un’importanza tale che merita di essere sottolineata oggi ancora di più. Basta riflettere brevemente su tre vocaboli fondamentali: partire, viaggiare e tornare. In latino, “partire” può derivare tanto da pars/partis (parte, frazione) quanto da parere (partorire). Nell’atto del partire è quindi contenuta tanto una morte quanto una nascita. “Viaggio” proviene dal provenzale, ma ancor prima dal solito latino, nello specifico viaticum “gli alimenti necessari per compiere la via”. Viaggiare quindi non è solo uno spostamento, ma soprattutto ciò che ha alimentato quell’esperienza. L’inglese “travel” invece può essere associato a “travaglio”, di nuovo un simbolo di nascita, ma anche di dolore. Infine c’è “tornare”: dal latino tornus, il tornio, qualcosa che gira su se stesso. Partire per tornare insomma, ma diversi. Tre parole che descrivono diverse fasi in cui la costante è il confronto, l’alternanza tra uno strappo doloroso e una dolce riconciliazione. Un po’ quello che capita a chi partecipa ai riti di trance collettiva (torniamo al parallelismo di prima) in cui la musica è sempre protagonista: dalla taranta al vudù, fino al movimento dei rave anni novanta – sul tema è appena uscito il bellissimo libro Il dio che danza di Paolo Pecere. O anche l’esperienza dei musicisti che suonando e componendo viaggiano sulle ali dell’ispirazione, sperimentando una sorte di elevazione dal mondo che li circonda ma rimanendovi comunque attaccati per un pelo, giusto il necessario per ritrovare la strada di casa.
Nel caso della musica infatti l’assenza delle parole fa sì che il risultato del viaggio come mezzo per far scontrare la nostra essenza con quella degli altri diventi ancora più sfumato, ineffabile. Questa spinta è una tensione costante presente in tutti gli artisti, una ricerca che deve sfogarsi anche se non si può viaggiare fisicamente. A testimone di ciò c’è l’approccio iniziale dei musicisti del campo all’arrivo di Raffaele «mi trattavano come se fossi stato un giornalista: “facciamogli vedere quanto siamo bravi e chi siamo, così dato che noi siamo chiusi qui dentro lui può raccontarlo al mondo”. Quando abbiamo iniziato a suonare insieme quindi io avevo capito da subito che la mia missione sarebbe stata quella di divulgare loro stessi, la loro musica e cultura. È questo ciò a cui tenevano». Qui sfioriamo un’altra tematica complessa: l’appropriazione culturale. Quand’è che la buona fede si trasforma in cattiva, come ci si deve approcciare all’uso di materiali estranei alla propria cultura, quali sono le “linee” da non superare. Raffaele, che sul confronto e la rielaborazione di diverse tradizioni ci ha costruito una carriera, in questo è lapidario. «In Italia di queste tematiche non c’è consapevolezza e spesso non ci si rende conto che si tratta di un tema molto più hipster di quanto si pensi. Per una cultura come quella tuareg ad esempio è l’esatto contrario: “ti prego prendi la mia cultura e portala in giro”. Risiede nella concezione stessa dell’essere nomadi, portare in giro la propria cultura in ogni modo, l’incontro con l’altro. Essendo bloccati lì nel campo se lo fa qualcun altro sono felici. Infatti quando la BBC mi ha chiamato per un’intervista sul progetto gli ho passato i loro numeri di telefono, gli ho detto di parlare direttamente con loro».
Continuiamo su questa linea: «nella mia musica i protagonisti sono sempre i musicisti. Quando ho fatto musica partendo dagli archivi del Royal Museum, mi sono fatto aiutare dai musicisti neri inglesi che stanno portando avanti queste tematiche. Per sottolineare l’idea della continuità tra la musica e il colonialismo, per sottolineare la rilevanza di quei temi per la cultura contemporanea. Allo stesso tempo non è una questione di “mission”, a me come gusto personale piace proprio quella roba lì. Sono convinto però che per essere credibile posso farla solo coinvolgendo loro. Per me in questi termini essere gran “paraculi” vuol dire campionare da YouTube senza cognizione di causa, oppure pubblicare il disco “africano” perché quell’anno va di moda così e poi sei mesi dopo invece il disco “giapponese” perché il gusto si è spostato lì. Ci vuole coerenza». Uscire per un’etichetta come la Real World Recordings (da sempre, suo malgrado, associata al concetto obsoleto di “world music”) nel 2021 assume anche questo significato e diventa simbolico dell’evoluzione ed intersezione tra tematiche diverse – forse trattate in modo più consapevole rispetto al passato? «Alla fine degli anni ottanta Peter Gabriel ha detto: “guardate che il mondo reale è questo”. Lo disse per gli eurocentrici che pensano che tutto ciò che non si fa in Europa non sia musica. O sia musica esclusivamente da etichettare come etnica, quindi valida da studiare solo dal punto di vista etnologico. Infatti l’etichetta l’ha chiamata Real World. Quando è uscita, a me si è aperto un mondo». Quanto questa spinta di Gabriel (fatta sua da Costantino) sia stata effettivamente colta in questi ultimi decenni o piuttosto sia stata manipolata dal mercato per meglio etichettare alcune di queste forme di espressione proprio in forma di cartoline esotiche più facilmente vendibili agli ascoltatori annoiati è un argomento troppo ampio da sviscerare qui, ma che mostra segni incoraggianti.
Lo sforzo è cosciente e calcolato. «Ora sto finendo di registrare un audio-documentario sull’esperienza, perché ovviamente il disco musicalmente parlando non è musica originale dei tuareg, così come non è al 100% la ‘mia’ musica. Ascoltando il documentario si sentiranno vere hit rock e desert blues, la vera vita del campo. Ma quella era la roba loro, che io non volevo toccare. A me interessava la contaminazione»
Ad un certo punto una voce decisa e agitata emerge tra il magma sonoro dei brani: «durante li festival che hanno organizzato al mio arrivo, il griot del campo ha fatto un discorso in cui parlava dell’importanza dell’attenzione mondiale, politica e dell’opinione pubblica, rispetto ai loro temi. L’esser rifugiati, privati della libertà, messi da parte, quasi dimenticati. Allo stesso tempo si preoccupava di dire ai bambini, ai politici e tutti gli altri accorsi per l’evento – di restare all’ombra. Perchè poi uno se ne dimentica, ma lì c’erano più di cinquanta gradi. Se stavi cinque minuti sotto al sole ti facevi male. Insomma convivevano questa atmosfera festosa e di gioia, (che ho ripreso nella composizione del brano) inframmezzata da questi discorsi gravi ed importanti ma con il costante monito di restare all’ombra – reste a l’ombre!». La saggezza del griot e il suo messaggio rivolto al mondo mi sembrano riassumere bene tutto il progetto.