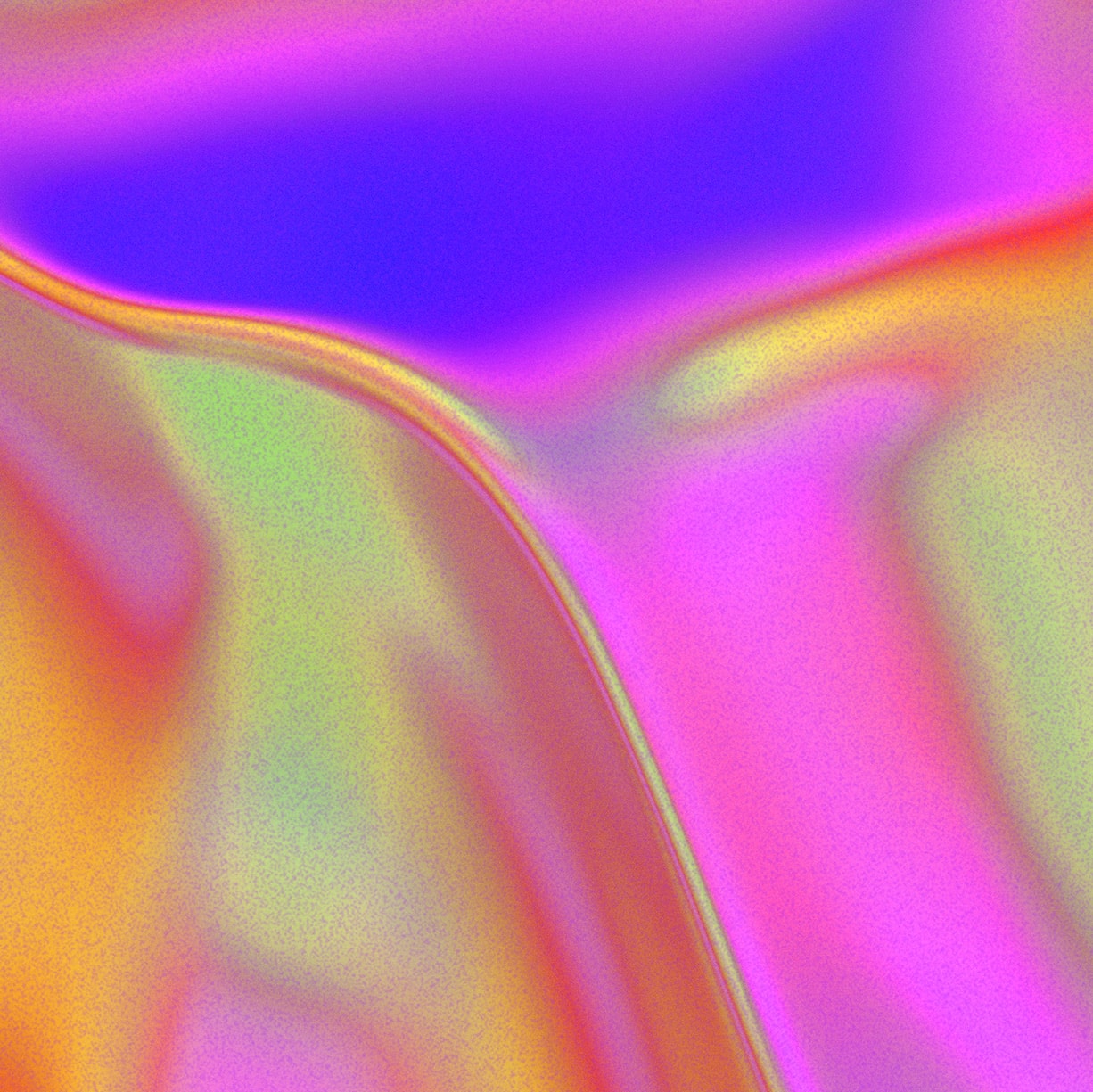#ILoveMyJob7 min read
#ILoveMyJob
Performative workaholism e hustle culture, burnout, quitting fantasies e procrastinazione vendicativa
Questo articolo è estratto da Dylarama, la newsletter settimanale a cura di Siamomine su tecnologia, scienza, comunicazione, lavoro creativo e culturale.
Iscriviti qui per ricevere le prossime edizioni.
La cultura tossica dell'amore per il proprio lavoro e il performative workaholism
C’è questo articolo pubblicato su In These Times che, da qualche tempo a questa parte, continua a farci discutere e riflettere. Against Loving Your Job, contro l’amore per il proprio lavoro, suona un po’ come un’esortazione provocatoria ad abbandonare il mito della ricerca di un impiego in grado di farci sentire bene con noi stessi e con quello che facciamo, ma non si tratta solo di questo.
L’articolo è molto bello perché mette in luce il rapporto tra lavoro e amore e come, nel corso dei decenni, l’ambiente lavorativo capitalistico si sia progressivamente appropriato del tempo per gli affetti, nel tentativo di sostituire la ricerca di connessioni appaganti con quella di una produttività in grado di compensarci con gratificazioni illusorie: «Capitalism must control our affections, our sexuality, our bodies in order to keep us separated from one another. The greatest trick it has been able to pull is to convince us that work is our greatest love».
Un approfondimento sul New Yorker ripercorre la nascita di questo mito, che può essere sintetizzato con l’idea di meaningful job o con il famigerato motto: «Do what you love and you’ll never work a day in your life». Il discorso è molto complesso, ma – oltre a coinvolgere la lotta per il tempo libero e lo spazio privato nell’era capitalista – ha molto a che fare anche con la progressiva alienazione che caratterizza la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici oggi, a cui non appartiene più né il frutto del proprio lavoro, né il senso di autodeterminazione sulla propria storia (personale e collettiva).
Un’altra manifestazione tossica dell’esortazione ad amare il proprio lavoro è quella che questo articolo sul New York Times definisce performative workaholism, ovvero l’esigenza di esibire costantemente il fatto che si lavora tantissimo (e che si è felici di farlo). In poche parole, la hustle culture (o hustle-mania) si manifesta soprattutto tra giovani lavoratori e lavoratrici nel settore tecnologico ed è un atteggiamento particolarmente incentivato dai piani alti perché contribuisce ad attuare uno dei più ambiziosi sogni capitalisti: più ci identifichiamo con il lavoro che facciamo, più la cultura lavorativa entra nel nostro privato rendendo sempre più opachi i confini tra produzione e (sempre lui) tempo libero. Quindi sì, insomma, postare foto su Instagram con l’hashtag #ILoveMyJob è un affare un po’ più serio di quel che crediamo.
Amare il proprio lavoro: tra burnout e quitting fantasies
Come conclude giustamente l’articolo, una delle conseguenze naturali di questo fenomeno di devozione tossica nei confronti del proprio lavoro è, inevitabilmente, il burnout. Se ve lo siete perso, un approfondimento sul nostro magazine racconta proprio la generazione burnout, ovvero come i millennials soffrano sempre di più di un particolare tipo di stanchezza e di stress legato alle proprie condizioni di lavoro, al tempo stesso precarie ed estremamente esigenti in termini di tempo, energie e ambizione.

Un fermo immagine da "The Trainee" l'opera dell'artista finlandese Pilvi Takala
The trainee è la performance dell’artista finlandese Pilvi Takala che, per un mese, ha frequentato gli uffici della multinazionale Deloitte fingendosi una stagista del reparto marketing. Durante la sua permanenza, l’artista ha trascorso la maggior parte delle sue giornate in ufficio fissando il vuoto, o, addirittura sostando in ascensore per tutta la durata dell’orario lavorativo. L’opera di Takala mette in luce come alcune forme di ozio o brain work – come navigare sui social network in ufficio – siano molto più accettate delle espressioni di inazione e improduttività, che sono invece considerate vere e proprie minacce all’ordine dell’ambiente di lavoro.
Chiudiamo con un articolo su The Cut che approfondisce il burnout come motivazione per lasciare il proprio lavoro (o alimentare pittoresche quitting fantasies) e, per ultimo, con il concetto di Revenge Bedtime Procrastrination, che descrive la decisione di sacrificare il sonno per “riappropriarsi” del tempo tempo libero sottratto dal lavoro. Se per farlo, però, decidete di guardare Netflix invece che leggere un buon libro, beh, un altro punto per il capitalismo.