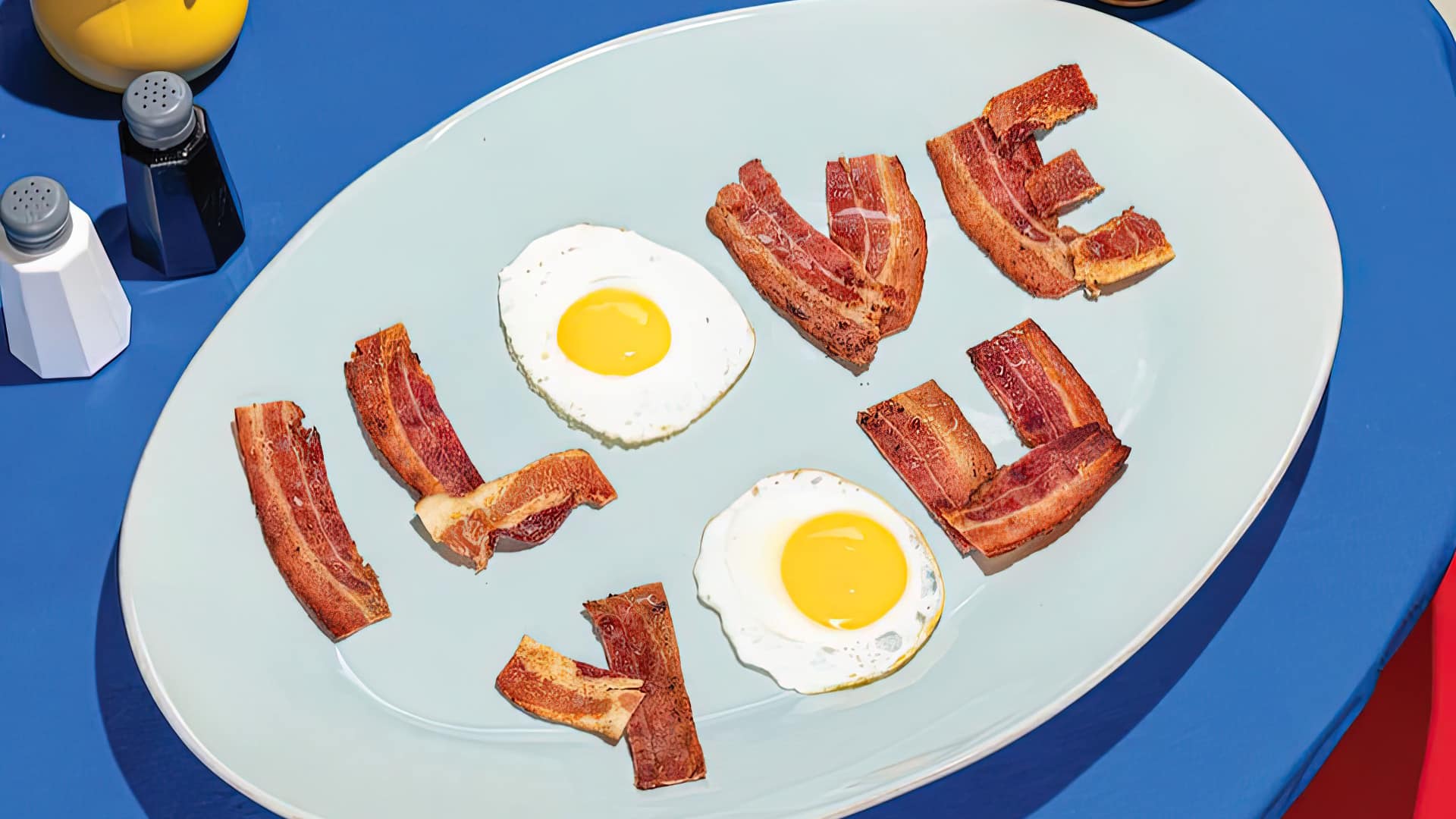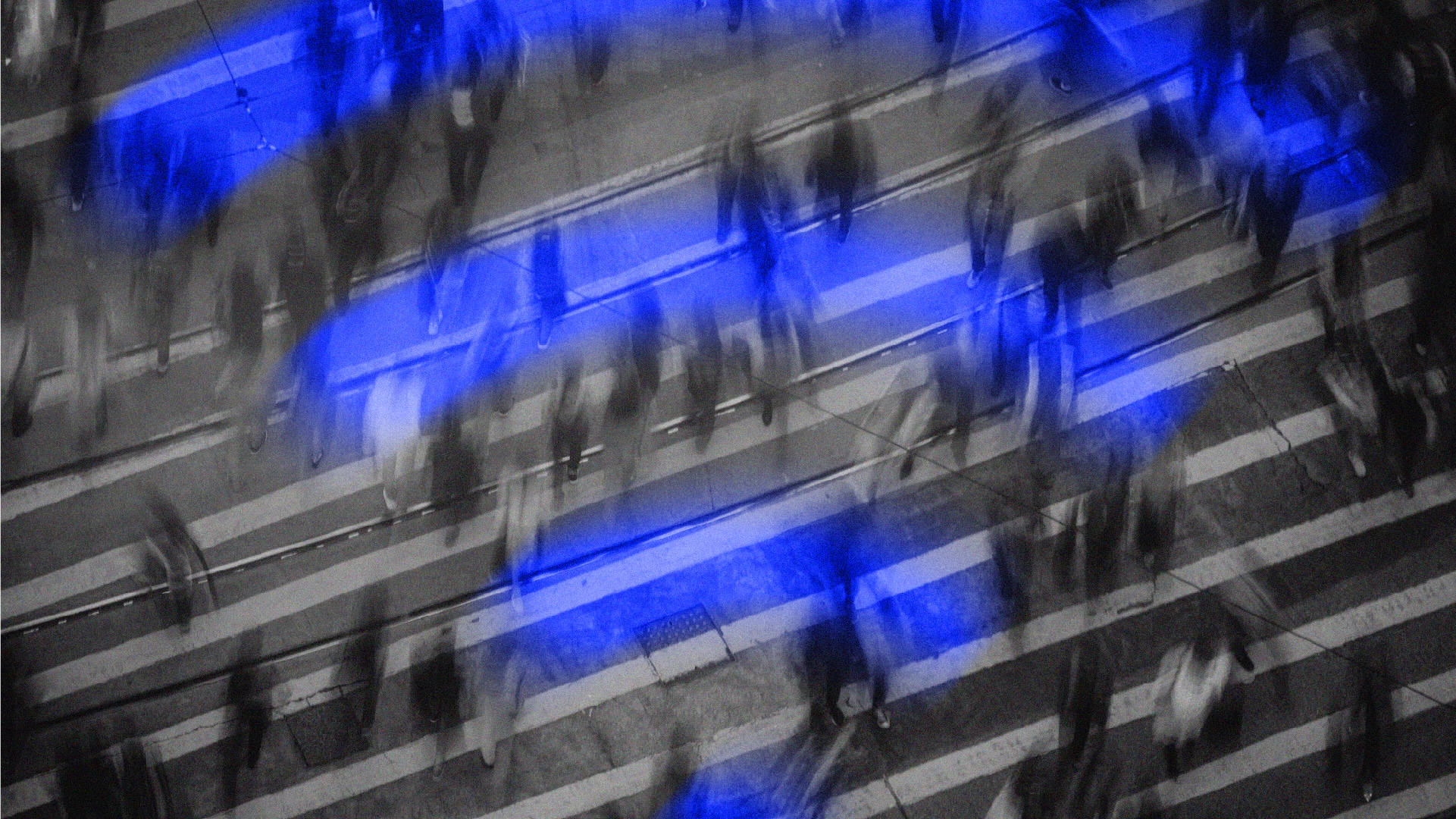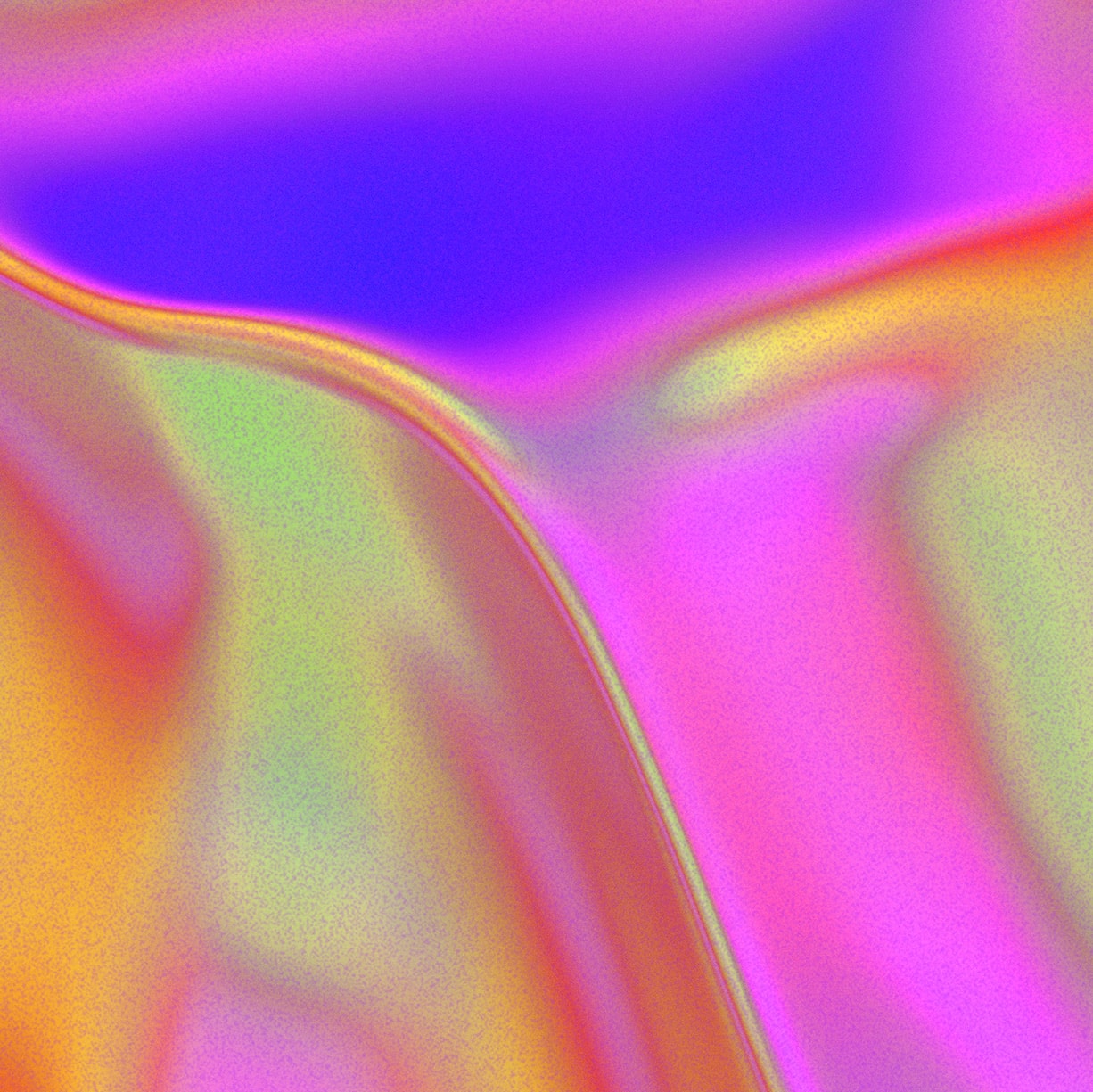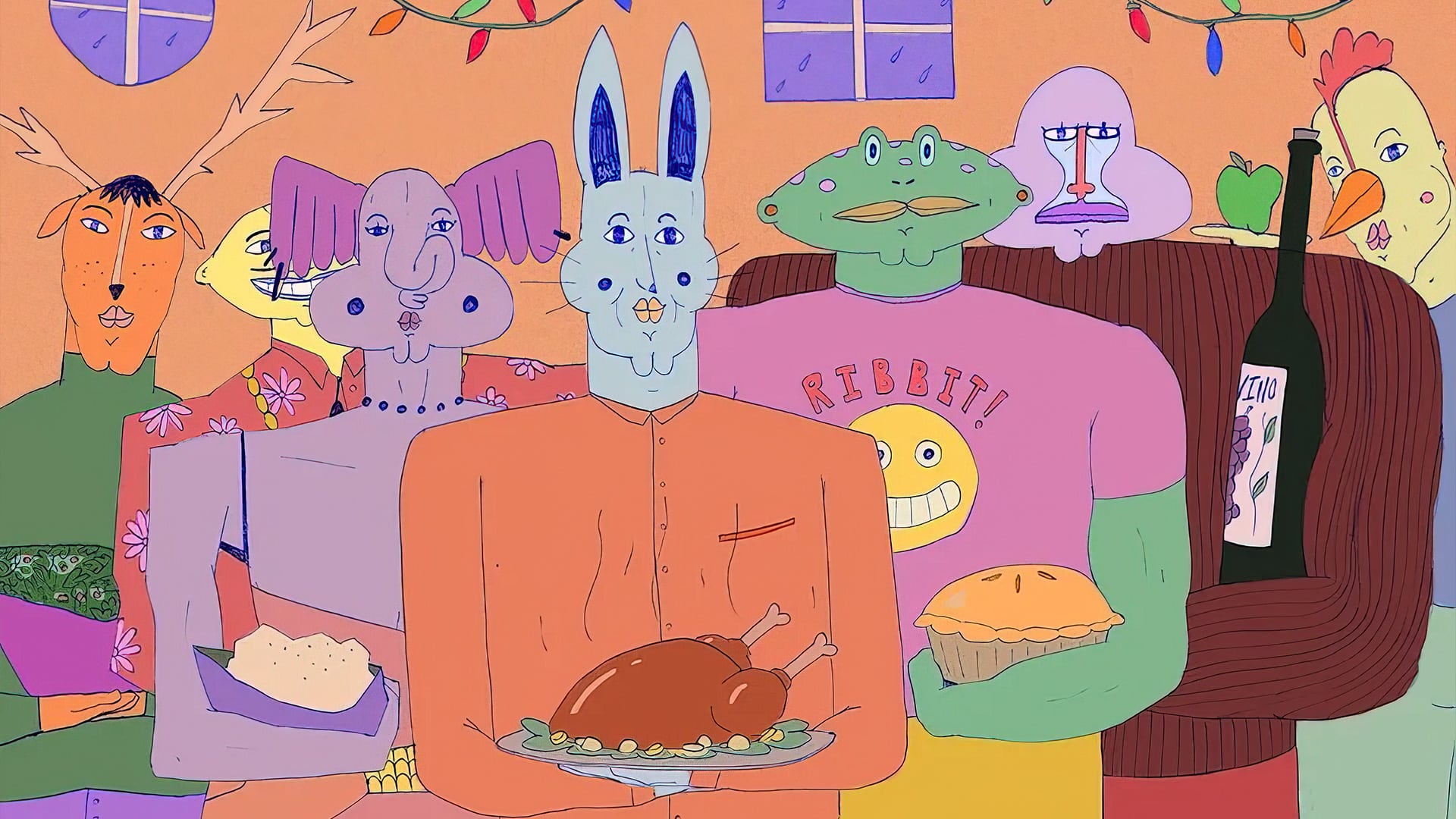
Generazione delivery24 min read
Generazione delivery
Ordinare cibo d’asporto tramite uno smartphone è diventata un’abitudine consolidata nel giro di pochi anni. Ma quale sarà il futuro di queste piattaforme?
Quante cene avete ordinato tramite un’app ultimamente? Il fatto è che quando si tratta di ricordare i nostri comportamenti quotidiani, in particolare quelli legati al cibo, facciamo presto a far risalire alla notte dei tempi usi di recente acquisizione. Lo vediamo in maniera lampante con le ricette cosiddette tradizionali: “la carbonara si è sempre fatta così”, quando invece la carbonara è nata non prima degli anni ’50, ed è stata codificata decenni dopo. Vale anche per altro: oggi ci sembra impensabile, ma c’è stata un’epoca in cui se non avevamo voglia di cucinare né di andare a mangiare fuori, la sola cosa che potevamo fare era scendere comunque di casa per raggiungere la più vicina pizzeria da asporto, o al massimo telefonare a una di quelle che aveva il servizio consegna a domicilio.
Che le cose siano radicalmente cambiate nel giro di poco tempo, è una banalità dirlo: eppure a guardare i numeri si resta impressionati. Nel 2011, dieci anni fa, negli Stati Uniti appena il 10% degli ordini per takeout o delivery era fatto online, secondo una ricerca di mercato di Technomic. Solo sette anni dopo – come racconta un articolo del dicembre 2019, praticamente alla vigilia della pandemia, quando già si parlava di boom senza sapere lo tsunami che si sarebbe scatenato di lì a poco – i consumatori ordinavano pasti online per 10 miliardi di dollari, rendendo il mercato del delivery di una grandezza pari alla quinta più grande catena di ristoranti americana. Cosa era successo in così breve tempo? La rivoluzione digitale era diventata rivoluzione alimentare.
La storia delle consegne di cibo ordinato via internet in verità ha quasi trent’anni: ma è solo da poco che si può davvero considerare un fenomeno di peso. C’è voluto il progresso tecnologico – la sicurezza dei pagamenti online, la semplicità delle app su smartphone – ma c’è voluto anche e soprattutto un cambio di mentalità. PizzaHut lanciava PizzaNet negli anni ’90: era il primo sito per fare gli ordini sul web, in un momento in cui di siti internet in generale ce n’erano ancora pochini. Del 1995 è WorldWideWaiter il primo vero servizio gestito da una terza parte: il cliente poteva scegliere tra 60 diversi ristoranti, bazzecole per oggi, ma avevano visto il futuro.
Futuro che è arrivato solo più di dieci anni dopo, quando all’improvviso sono fiorite le startup: Postmates è nata nel 2011; nel 2013 DoorDash ha iniziato le consegne a Palo Alto, California; l’anno dopo Uber ha lanciato il suo servizio di delivery. Investitori e fondi si sono subito lanciati in questa corsa all’oro; i ristoranti, come raccontano alcuni testimoni, hanno fatto invece fatica ad adattarsi, «fino al 2017 la maggior parte dei gestori di catene doveva ancora essere convinta della convenienza del sistema».
In Italia ci abbiamo messo un po’ di più, ma manco tanto: è il bello, o il brutto, della globalizzazione digitale. Ricorda Filippo Chiricozzi, tra i fondatori di Moovenda, food delivery operativo dal 2015: «All’epoca era una scommessa, siamo partiti come una piattaforma di consegna di qualsiasi cosa, e poi ci siamo spostati sulla ristorazione. A inizio di quell’anno il modello era noto solo per Just Eat, non esisteva un trend se non per piccoli player, a Roma e Milano, che avevano avviato un servizio di consegna con i propri fattorini, niente di tecnologico, tutto gestito via telefonica. Durante il 2015 c’è stato il boom, sono nati Deliveroo, Glovo, Foodora e tutte le grandi company».
Sostiene Melissa Wilson, a capo della summenzionata Technomic, che la svolta si è avuta quando, nel 2017, McDonald’s ha stretto una partnership con Uber Eats: fino a quel momento le piattaforme di delivery avevano rappresentato un canale soprattutto per i ristoranti indipendenti. E comunque molti gestori della catena di fast food sul momento – solo cinque anni fa – si lamentarono per le commissioni troppo alte da pagare al servizio. Il cambiamento di mentalità che si diceva prima, è stato quello dei ristoratori, ma anche e soprattutto dei clienti: non solo e non tanto rispetto alla fiducia verso i pagamenti online – altro ambito che ha avuto un balzo in avanti impressionante, ma comunque ancora oggi le app prevedono l’opzione “paga alla consegna” – ma proprio come abitudini di acquisto. Una volta normalizzata la possibilità di comprare un libro o un paio di cuffie online, perché non farlo anche con il sushi? È quello che è stato battezzato “effetto Amazon”.
Poi, lo sappiamo, è arrivata la pandemia. Che all’inzio, ingenuamente, alcuni hanno definito una livella: davanti al virus, come davanti alla morte, siamo tutti uguali. Sciocchezze: c’è una bella differenza tra farsi un lockdown in una villa con giardino, o in un seminterrato, per dire. La pandemia è stata un acceleratore: un acceleratore di tempo, perché «in pochi mesi è successo quello che ci aspettavamo succedesse in dieci anni», come dice a UsaToday Alex Canter, CEO di Ordermark. E un amplificatore di disuguaglianze: ha proprio dato con una mano quello che toglieva con l’altra, visto che mentre i ristoranti erano chiusi al pubblico, le piattaforme prosperavano. Le statistiche già a fine 2020 parlavano chiaro.
Il sistema sembrerebbe convenire a tutti: i clienti che ricevono la cena comodamente a casa, i ristoranti che ampliano la clientela senza dover allargare il locale né dotarsi di fattorini (né andare totalmente in perdita in caso di lockdown), le startup che si sono inventate un servizio che prima non c’era e ne raccolgono i profitti. In più, queste nuove aziende creano nuovi posti di lavoro, e un sacco di giovani/precari/immigrati possono arrotondare o arrangiarsi facendo i rider. Il mondo ideale. O no? In verità questa win-win-win situation è tale solo in teoria. In pratica, per ogni parte ci sono delle perplessità o dei lati oscuri.
Nel 2011, dieci anni fa, negli Stati Uniti appena il 10% degli ordini per takeout o delivery era fatto online. Appena sette anni dopo i consumatori ordinavano pasti online per 10 miliardi di dollari, rendendo il mercato del delivery di una grandezza pari alla quinta più grande catena di ristoranti americana. La pandemia poi, come sappiamo, è arrivata come uno tsunami, durante il quale le piattaforme di consegna a domicilio hanno prosperato.
I clienti sembrano i più felici di tutti. Ma hanno i motivi per esserlo? Certo, vuoi mettere la comodità. Però bisogna anche tenere conto dei tempi: tempi di attesa, e tempi di trasporto, che per quanto possano funzionare i contenitori termici, comportano sempre il rischio che la cena arrivi freddina, o appena tiepida. Non è un caso che tra i generi più gettonati ci sia sempre il sushi.
Comunque, la convenienza c’è, soprattutto nel risparmio di quello che sembra attualmente – nell’economia dell’informazione e dell’attenzione – il bene più prezioso: il tempo. «Si poteva immaginare un tale successo? Sì», commenta Chiricozzi: «Il cibo è un bene primario, la poca disponibilità di tempo ha portato tutti a sfruttare i servizi». Più che di effetto Amazon, si dovrebbe parlare di effetto Netflix: un menu amplissimo da cui scegliere, per tutti i gusti e le età, e soprattutto la soddisfazione immediata di un desiderio.
Che poi ci sia anche un effettivo risparmio economico – cosa che di solito accade quando si porta a casa rispetto a quando ci si accomoda nel locale – è tutto da vedere. Un pezzo del New York Times ha fatto un’interessante e approfondita analisi comparativa dei costi delle maggiori piattaforme. Scoprendo, oltre a notevoli differenze tra l’una e l’altra app, tra l’uno e l’altro ristorante, che alcuni ristoranti aumentano i prezzi dei piatti ordinati per il delivery, per recuperare almeno in parte la percentuale che l’app trattiene. E la maggior parte delle app addebitano una commissione di consegna, un percentuale per il servizio e altre spese extra in un’unica riga sul conto, rendendo difficile quantificare l’aumento e le sue ragioni.
Bisogna, infine, come si dice, pensare alla salute. Che dall’aumento delle volte che ordiniamo la cena fuori non ne esce bene. È una constatazione che si basa non solo sull’intuito, ma su veri e propri studi scientifici: negli ultimi 30 anni, sono aumentate le dimensioni delle porzioni di fast food, le calorie e i livelli di sodio. Sono tutti fattori che incidono sull’obesità, sulle malattie cardiovascolari, sui precursori del cancro. Un attimo, si dirà, ma cosa c’entra il junk food con le piattaforme? In teoria con il delivery si può ordinare qualsiasi cosa, anche un’insalata scondita. È un fatto però, supportato dalle statistiche fornite dalle stesse app, che i cibi più richiesti non appartengano precisamente alla categoria degli alimenti salutisti: «cheeseburger, patatine fritte, pizze, nachos, cheesecake, costolette di maiale, pollo, waffle… le opzioni ad alto contenuto calorico sono alcune delle opzioni più popolari», dice lo studio.
I lavoratori del delivery, in particolare gli addetti alle consegne, sono dal lato opposto, l’anello debole della catena. Eppure un anello indispensabile. Il modello di business delle piattaforme prevede che i rider siano lavoratori autonomi, che si muovano con mezzi propri e si organizzino per conto proprio, e che siano pagati a chiamata ovvero a consegna. In sostanza questo si traduce in una posizione insostenibile: senza contratto, senza tutele, senza orari, sfruttati al massimo e pagati il minimo. Ma le cose stanno per cambiare, pare. Anzi sono già cambiate.
Se per le startup del delivery il 2020 è stato l’anno del boom, il 2021 è stato l’anno dei tribunali, in tutto il mondo. Il primo caso storico si è verificato a febbraio nel Regno Unito, in un settore parallelo, quello dei taxi privati: 25 guidatori hanno fatto causa a Uber; la Corte Suprema britannica ha emesso una sentenza in favore dei lavoratori riconoscendo loro diritti come il salario minimo e le ferie pagate. Altre decisioni giudiziali sono seguite, in tutta Europa. E dopo le sentenze, sono venute le leggi. A maggio 2021 la Spagna ha approvato una legge che classifica i lavoratori della gig economy come dipendenti. E una norma molto simile è stata emanata in Portogallo a ottobre 2021.
In Italia la svolta storica è avvenuta a marzo 2021: dopo varie sentenze che hanno stretto sempre più all’angolo le piattaforme, a muoversi non è stato il legislatore ma i privati. La piattaforma JustEat, unica tra i colossi del settore, ha concluso un accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, secondo il quale i rapporti di lavoro con i rider sono considerati come subordinati, e vengono regolati dal contratto collettivo nazionale della logistica. C’è da dire che società più piccole, come la tedesca Gorillas, o parzialmente la stessa Moovenda, hanno offerto ai rider contratti di lavoro o di collaborazione fin dall’inizio.
Insomma, dove non arrivano gli obblighi di legge, arriva la convenienza: è per esempio un sito di investimenti a dire che le piattaforme che riconoscono dei diritti ai lavoratori certo perdono soldi, o meglio guadagnano di meno, ma nel lungo periodo le aziende che non lo faranno ne perderanno ancora di più, dato che il pubblico sta diventando sensibile alle condizioni dei rider e quindi tenderà sempre più a privilegiare le startup “buone”.
C’è del rischio però in questo lasciar fare al mercato, come sempre. Si può andare avanti con le contrattazioni private, o meglio ancora con le concessioni delle singole aziende? Jim Stanford, economista e direttore dello statunitense Center for Future Work, afferma che le decisioni unilaterali delle aziende che assegnano ai fattorini una paga oraria non sono esattamente un progresso: «Stiamo parlando di salario minimo da oltre 100 anni, non so se mi spiego», ha detto. La concorrenza tra piattaforme porterà maggiori introiti nelle casse di quelle che sfruttano i lavoratori, e prima che possa farsi sentire la voce del pubblico pagante, le aziende che hanno concesso diritti rischiano di essere spazzate via dalla competizione. È per questo che il Transport Workers Union (TWU), il sindacato Usa del settore trasporti, chiede l’intervento del governo federale per uniformare le condizioni di gioco.
Anche l’Unione Europea si sta muovendo: a fine 2021 ha fatto un primo passo verso la costruzione di un pacchetto normativo che prevede fra le altre cose l’assunzione per i rider. Nel frattempo anche l’immagine di JustEat come azienda virtuosa scricchiola, o forse sono i lavoratori che una volta che alzano la testa poi non la riabbassano facilmente: la startup è stata accusata di condotta antisindacale, perché va bene fare i contratti ma poi bisogna anche applicarli. Varie volte i lavoratori di JustEat sono scesi in piazza, anche per protestare contro il fatto che, dipendenti o meno, il costo del carburante è sempre accollato ai lavoratori, e con i terrificanti aumenti dei prezzi dell’energia avvenuti negli ultimi mesi questo si traduce in aumenti terrificanti del costo del carburante.
Il futuro potrebbe essere molto diverso, dicono economisti esperti del settore a Wired; se cambiano i rapporti lavorativi potrebbe cambiare in toto il modello di business. Ma è comunque un futuro lontano: gli Stati e le istituzioni UE potrebbero passare anni a dibattere sul tema, ed è improbabile che le regole diventino legge almeno fino al 2024. Ciò crea spazio per feroci campagne di lobbying da entrambe le parti, ma soprattutto da parte delle piattaforme, che potrebbero ripetere l’exploit del 2020 in California, quando i cittadini votarono per non considerare i rider come dipendenti.
La nascita delle ghost kitchen è stata possibile solo grazie al boom delle piattaforme, ed è 100% funzionale al sistema: ne è prova l’enorme successo del modello tra gli investitori professionali, che stanno puntando milioni sulle “cucine fantasma”.
Altro attore fondamentale: i ristoranti. Anche loro dovrebbero avere grossi vantaggi, in teoria. Spiega Filippo Chiricozzi: «Una piattaforma di delivery è un servizio per il ristoratore, perché guadagna in percentuale sull’introito del ristorante. Il margine è il minor costo che il ristoratore sostiene rispetto al servizio in casa: io piattaforma do potenzialmente infiniti posti in più al tuo locale, togliendoti però i relativi costi».
L’estrema perversione di questa pratica, è quella di aggiungere un ristorante in piattaforma senza il consenso, senza nessuna adesione. Più volte il caso è stato riportato negli Stati Uniti: è una presenza figurativa, ovviamente, nel senso che l’utente vede il ristorante nell’elenco ma se poi prova a comprare, l’ordine non è possibile; in questo modo però il cliente, non a conoscenza del trucco, attribuisce il problema al ristorante, il quale si vede costretto a entrare in scuderia suo malgrado.
Oltre alle commissioni, ci sono altre leve, altre clausole capestro che i ristoranti subiscono: come ad esempio l’obbligo a tenere in menu determinati piatti, e/o a toglierne altri. Ma ancora più a monte, i piccoli ristoratori vengono convinti in maniera pressante, quasi costretti, ad aderire alla piattaforma. L’arma del ricatto è quella classica, che molti gestori denunciano aver subito da parte di aggressivi rappresentanti: rimarrai il solo nella zona a non essere presente, non ti conviene.
Ma il discorso centrale è quello delle commissioni: che si aggirano tra il 15% e il 30%. I grandi hanno il potere contrattuale di negoziare: nel 2019 McDonald’s ha cambiato l’accordo con Uber Eats, abbassando la percentuale dovuta alla piattaforma e soprattutto rescindendo la clausola di esclusiva; infatti oggi McDonald’s si trova su tutte le piattaforme o quasi. Per i piccoli, gli indipendenti, i locali non di catena, essere presenti su più di una piattaforma non è invece una scelta strategica, ma di sopravvivenza: potere contrattuale non ne hanno, le condizioni proposte dalle aziende del delivery vanno accettate e punto.
L’impatto sulla vita e l’organizzazione della ristorazione è enorme, e coinvolge più aspetti. Per esempio, già nel 2016 la catena americana Chipotle si dotava di una seconda linea di produzione, dedicata esclusivamente al delivery online.
Altra categoria che ci è andata solo a perdere, in questa rapida e radicale rivoluzione, è quella dei posti che il delivery lo facevano già prima, per conto loro: catene o singoli locali che erano organizzati coi propri fattorini, tipicamente in Italia le pizzerie, in America molto diffusi anche i cinesi. Durante la pandemia, alcuni ristoranti per sopravvivere alle chiusure forzate, e contemporaneamente non sottostare alle proibitive condizioni delle piattaforme, hanno provato a organizzarsi in autonomia per ordini e consegne: ma sono state soluzioni di nicchia, temporanee, un modello che si è dimostrato poco sostenibile o comunque marginale.
In ogni caso, oggi anche il ristorante in generale potrebbe essere inutile nell’economia ridisegnata dal delivery: la nascita delle ghost kitchen – posti dove si cucina solo per le consegne, senza un locale che serve cibo in loco – è stata possibile solo grazie al boom delle piattaforme, ed è 100% funzionale al sistema: ne è prova l’enorme successo del modello tra gli investitori professionali, che stanno puntando milioni sulle “cucine fantasma”.
Ma se pensate che questo sia il massimo a cui si poteva arrivare, dovete ricredervi: recentissimo è il fenomeno dei ristoranti virtuali. Si tratta di brand che esistono solo online, consistono in poco più di un marchio e un menu. Per il resto, non si appoggiano neanche a dark kitchen, ma a locali già esistenti, che però forniscono il cibo alla piattaforma non a proprio nome, ma con quello del virtual brand; e non fanno i propri piatti, ma quelli inventati e imposti dal marchio. Uno dei primi è stato un brand americano che si appoggia a un numero enorme di pizzerie (il vantaggio è proprio questo, che teoricamente chiunque può fornire cibo a un ristorante virtuale), e che ha il nome volutamente anonimo e generico di @pizza. Ma adesso il trend è un grande crescita. Tutto questo, ovviamente, all’oscuro del cliente, che non ha nessun modo per sapere se si sta servendo da un ristorante virtuale o reale.
Chi ha una visione positiva delle cose, vede spazi non solo per i colossi: «Come in ogni mercato dove c’è un generalismo, una consegna mass market, c’è spazio per una declinazione specifica, quindi per aziende che facciano questo servizio di qualità alta, sia in termini di servizio (rapido e coerente con il ristorante: se ti do il piatto di uno stellato non te lo posso portare incasinato come una pizza ma con tutti i crismi) sia di specializzazioni o servizi che puntano a qualità, magari con tempi più lenti». Vedi casi come quello, in Italia, di Cosaporto.
Quale futuro per il delivery? Chiricozzi: «Vedremo come impatterà l’introduzione di sistemi intelligenti: robot su strada, droni… Ridurre i tempi, ottimizzando le rotte e renderle soprattutto più sicure, non con motorini e zaini che nel tempo fanno perdere al cibo la qualità. Quello che manca in questo momento è il piatto che arriva al cliente in condizioni adeguate alle sue aspettative».
Certo, sottotraccia c’è sempre un pensiero competitivo, di darwinismo sociale applicato alla food economy: chi non ce la fa, non merita di sopravvivere, alla fine resteranno i pochi, i migliori. Ma siamo sicuri che vogliamo davvero un mondo gastronomico in cui alla fine restano in pochi? E soprattutto: siamo sicuri che saranno i migliori? Applicare la teoria di Darwin a qualcosa di diverso dalla biologia è stato sempre fonte di grossi equivoci, se non di orrori; ma anche volendo, tocca ricordare che il padre dell’evoluzionismo parlava di “sopravvivenza del più adatto”. Che è cosa ben diversa da migliore.
Sennò, per convincerci a uscire di casa ci vorranno sempre più gli effetti speciali, come suggeriva un pezzo del Financial Times che per altri versi fa un po’ di tenerezza, come tutto quello che è stato scritto prima del febbraio 2020. Ci vuole l’equivalente delle grandi produzioni, quelli che una volta si chiamavano kolossal, o dei cinecomics, per rendere l’esperienza-ristorante effettivamente unica e necessaria. Ecco perché molti ristoranti e soprattutto molti chef puntano sulla spettacolarizzazione, su immagini di grande impatto visivo – non è solo che siamo nella cultura dell’immagine, del #foodporn, di Instagram e TikTok. Ecco perché il marketing punta sulla narrazione, sul “ti faccio sentire i sapori dell’infanzia”; o viceversa sullo strabiliante, sul mai visto. Ma anche qui, in quanti possono permettersi di farlo?
In tutto questo, l’unico attore che dovrebbe avere solo vantaggi, è quello delle startup che hanno dato il via alla rivoluzione: le piattaforme. Ma siamo proprio sicuri che sia così? E soprattutto, che questo sia non solo il migliore dei mondi possibili, ma anche l’unico?
Qualche tempo fa, la newsletter On Tech del New York Times se uscì con un titolo tranchant: il food delivery è pensiero magico. L’atto di fede alla base, ragionava Shira Ovide, è che tutto sia fluido, tutto vada liscio come in un processo informatico. Invece la realtà è fatta di uomini e cose, non di pixel: ci saranno sempre intoppi, problemi, imprevisti, per non parlare delle inefficienze che ricadono sulla collettività (traffico, inquinamento…). Citava anche lo scrittore di tecnologia Ranjan Roy il quale sostiene che le app di delivery siano «una perversione dell’efficienza del libero mercato». La giornalista americana concludeva dicendo: chissà cosa ci stiamo perdendo. «Forse, come suggerito da Roy, i servizi di food delivery sostenibili assomigliano più a Domino’s Pizza o ad altri ristoranti che consegnano il proprio cibo; a cucine industriali che sfornano pasti solo a domicilio; o qualcos’altro che nessuno può immaginare perché invece abbiamo app di consegna di cibo che non possono sopravvivere».
Perché il punto è proprio quello: il modello non sembra sostenibile, neanche per le startup stesse. All’inizio, c’è stata la selezione naturale, come spiega Chiricozzi, economista oltre che startupparo: «Come in tutti i mercati in forte espansione e di grande successo, quando ci sono tante aziende che nascono in poco tempo, alla lunga alcuni muoiono, molti altri vengono acquisiti, e rimangono poche aziende. Le quali all’inizio se hanno tanta cassa comprano i piccoli e i medi, poi quando crescono in maniera esponenziale l’obiettivo che hanno è semplicemente falciare via dal mercato gli altri. È una dinamica classica».
Attualmente, i colossi sul mercato sono davvero pochi, se parliamo dei generalisti ed escludiamo piccole realtà locali o settoriali. Ciononostante, sono tutti o quasi tutti in perdita. Tanto che alcuni analisti si stanno iniziando a chiedere: non è che quella del delivery è una bolla che sta per scoppiare? Filippo Chiricozzi non la vede così: «Se parliamo di startup, anche grosse, nate da meno di 10 anni, il conto in rosso non è strano, è la norma. Per me non è una bolla: alcune piattaforme si consolideranno, altre forse spariranno ma il mercato rimarrà, perché è un servizio a valore aggiunto ormai percepito positivamente. E anzi, si amplierà con servizi sempre più di nicchia: per esempio sui drink».