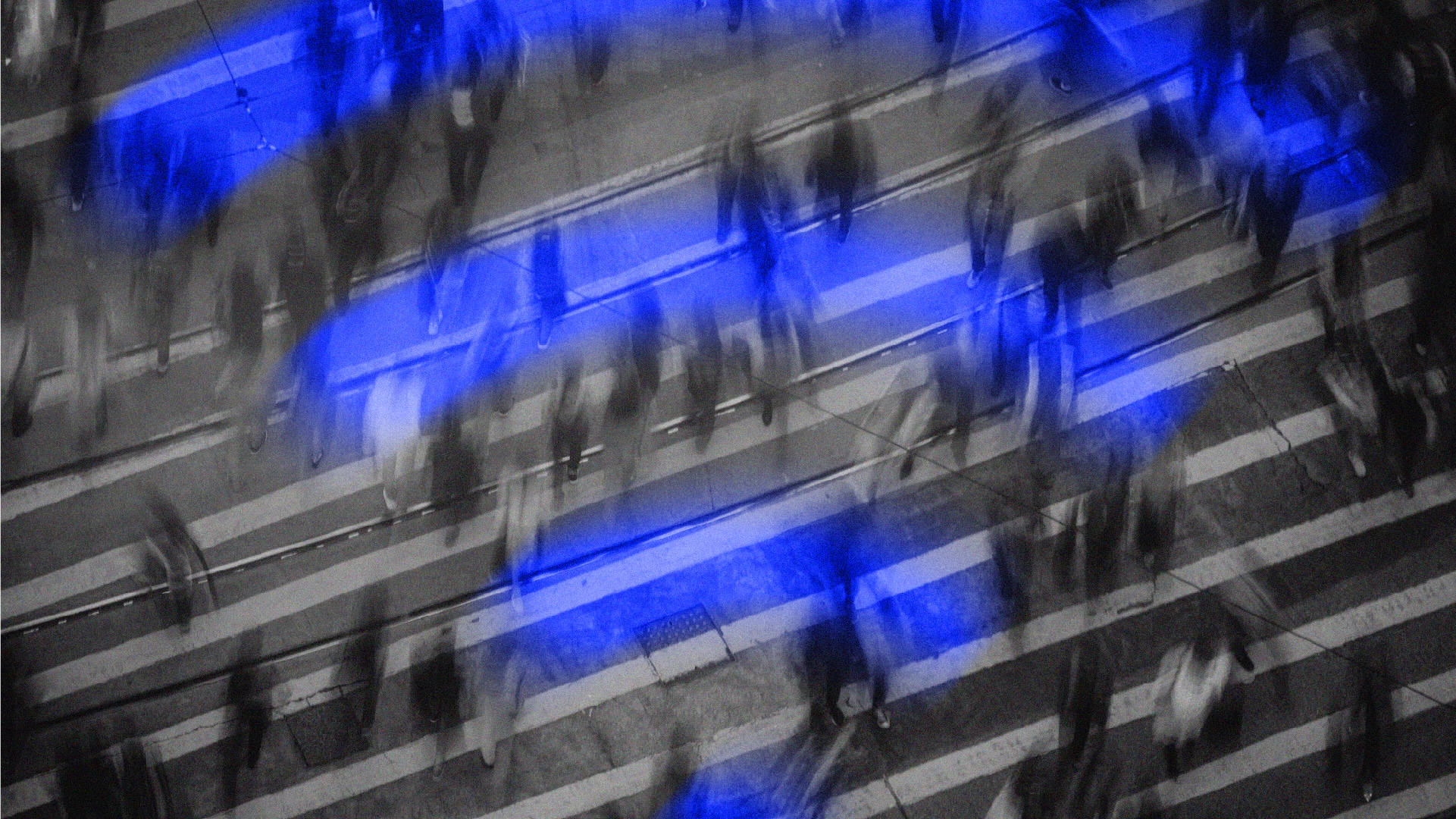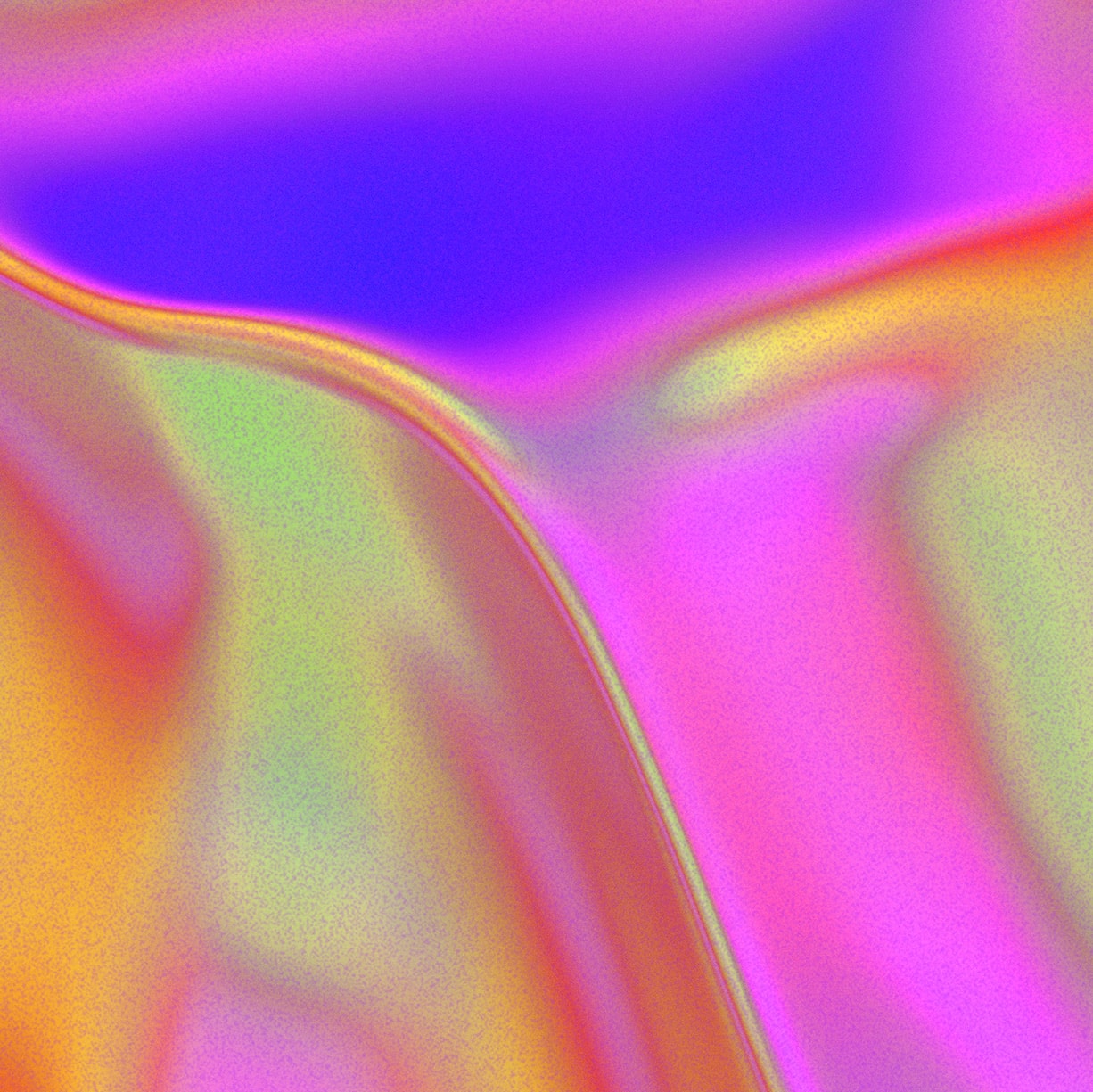Come parliamo di salute mentale sui social14 min read
Come parliamo di salute mentale sui social
I social sono un utile spazio di discussione sulla salute mentale, ma cosa succede quando diventano il luogo dell’autodiagnosi?
Quando apro la pagina “esplora” del mio profilo Instagram, insieme alle foto di libri con le tazze di caffè e un gran numero di video di ricette di pasta fresca compaiono post consigliati come “La migliore routine per prenderti cura della tua salute mentale” oppure “segni che identificano una persona ansiosa ad alto funzionamento.” L’algoritmo di Meta, oltre ad aver indovinato che mi piace fare le tagliatelle, ha anche capito che ho difficoltà a gestire la mia ansia. Lo spazio digitale in cui ci muoviamo è fatto di stimoli continui che spingono e informano riflessioni su noi stessi e sulla nostra identità. Si è discusso molto di come i social influenzino la nostra salute mentale – la richiesta di attenzione continua, le notifiche infinite, lo scrolling e la nostra tragica incapacità di concentrarci. Alcuni studiosi hanno anche legato l’uso eccessivo dei social a un aumento di ansia, panico e depressione.
I social possono diventare anche uno spazio di discussione attiva sulla salute mentale e un ambiente imprescindibile nel discorso pubblico su questo tema. Negli ultimi anni, su Instagram e TikTok in particolare è cresciuta la popolarità di contenuti riguardanti la sfera psicologica, psichiatrica o le discussioni sulla neurodivergenza. A produrre questi contenuti sono professionisti, psicologi o psichiatri, ricercatori o membri della comunità scientifica, oppure persone comuni che usufruiscono di servizi di salute mentale – quelle che in gergo tecnico si chiamano utenti.
Uno dei nodi critici del parlare di salute mentale sui social network è ovviamente la disinformazione. Ma questo aspetto tocca così tante altre sfere – le false notizie mediche sulle piattaforme circolano da anni – che per soffermarcisi in modo serio bisogna scoperchiare un vaso di pandora che copre tematiche quali la moderazione dei contenuti e il rapporto tra piattaforme, scienza e organismi regolatori. Lasciando da parte i contenuti scientificamente falsi, resta comunque un’abbondanza di messaggi sul tema. Come approcciarsi, quindi, ai social come scenario di riflessione sulla salute mentale? Una delle questioni recentemente più dibattute è quella dell’autodiagnosi: si possono usare dei contenuti reperiti su internet o come base per formulare una diagnosi o trarre conclusioni sul proprio stato di salute o su propri, possibili, tratti neurodivergenti? Questa domanda chiama in causa la responsabilità dei professionisti di mental health e la capacità degli utenti di discernere informazioni di qualità – ma anche aspetti più complessi, come l’accesso alla diagnosi, bias medici e lo stigma che alcuni disturbi portano ancora con sé.
«Molte persone si rivolgono ai social media per ottenere informazioni sulla salute, ma nonostante sia una pratica comune tra i giovani adulti, l’aspetto negativo è che l’autodiagnosi può essere estremamente pericolosa e una minaccia per la salute»
Sui rischi di autodiagnosi di disturbi mentali tramite i social molti professionisti hanno messo in guardia gli utenti. La dottoressa Catherine Carney, psichiatra presso una struttura di riabilitazione nel Regno Unito, avverte: “Molte persone si rivolgono ai social media per ottenere informazioni sulla salute, ma nonostante sia una pratica comune tra i giovani adulti, l’aspetto negativo è che l’autodiagnosi può essere estremamente pericolosa e una minaccia per la salute.” Le persone possono incorrere in informazioni scorrette, oppure si trovano a dare un significato non accurato a una serie di sintomi. Avete presente quei video di TikTok in cui viene spiegato perché potresti avere l’ADHD? Degli assunti errati a monte possono causare problemi, diagnosi errate in futuro o trattamenti non efficaci. La dottoressa Debora Mauri è una psicologa che utilizza giornalmente i social, specialmente Instagram, per comunicare. “I social network si possono considerare a tutti gli effetti degli ambienti dove si crea salute e possono rappresentare un canale di comunicazione per la salute stessa.” mi spiega “Per questo motivo, noi come professionisti della salute mentale non possiamo non considerare questo aspetto – dobbiamo essere sui social in modo responsabile”. I social hanno, per design, una natura bidirezionale. “La comunicazione bidirezionale rende il destinatario un soggetto attivo e consapevole rispetto alle questioni che riguardano la sua salute. E questo è un bene”
Il punto sta proprio nell’orizzontalità delle piattaforme e nell’abbondanza di informazioni sul tema. Laddove è possibile scambiarsi byte su byte di contenuti su uno specifico disturbo, sia essa l’ansia generalizzata, il narcisismo o il disturbo borderline di personalità, si innescano processi di auto-identificazione e auto-etichettamento. Uno dei rischi è la banalizzazione di percorsi diagnostici complessi. “Elaborare autodiagnosi è un atteggiamento che porta con sé dei rischi, indipendentemente dal fatto che sia corretta o scorretta. Uno di questi è l’effetto conferma: ci si potrebbe convincere a tal punto della diagnosi ipotizzata da manifestare comportamenti ed atteggiamenti sempre più congruenti con l’ipotesi iniziale, arrivando ad alimentare un problema che prima aveva un’intensità minore o creandone uno nuovo” continua la dottoressa Mauri.
Esistono poi condizioni che, per loro natura, sono più stigmatizzate di altre. Federica Carbone, attivista e fondatrice del progetto Emergenza Borderline, aggiunge: “Le autoanalisi e le autodiagnosi tendono a essere molto influenzate da alcuni bias individuali. Può esserci un bias di conferma e ci si sofferma sulle cose che già si conoscono o che si immagina di sé stessi. C’è però un problema quando si pensa a diagnosi come i disturbi di personalità o quelli schizo affettivi: che non vengono restituite. Costringendo di fatto l’utenza a cercare risposte altrove. Innanzitutto, perché è ancora molto diffusa la convinzione che non si possa guarire, anche tra i professionisti. E poi ci sono molti pregiudizi, nell’immaginario comune alcune condizioni rendono un soggetto pericoloso, sia per sé che per la società.”
Rispetto a queste diagnosi esiste anche il rischio che vengano usate come etichette stigmatizzanti non verso sé stessi ma verso altri. “Diagnosticare altre persone a partire da post sui social può essere molto pericoloso” continua Carbone. “Ad esempio, abbondano i test per riconoscere il narcisismo patologico in partner o in altre persone. Questo tipo di contenuti alimenta uno stigma, una discriminazione sanista verso alcuni tipi di disturbo, che non fa altro che peggiorare la condizione delle persone che li vivono”
P.E: Moskovitz ha parlato di buzzfeedification della salute mentale, ovvero di riduzione di diagnosi complesse a liste di sintomi o etichette che sclerotizzano e semplificano i discorsi sulla salute mentale e sulle diagnosi. I rischi esistono e non sono da sottovalutare, ma non rappresentano le uniche lenti attraverso cui analizzare un processo di autodiagnosi.

La presenza sui social non riguarda solo membri della comunità clinica, ma anche utenti comuni, persone che soffrono o hanno sofferto di una condizione di salute mentale o neurodivergenti e che nei social media trovano uno spazio di espressione. Il rapporto tra utenza e professionisti è un nodo cruciale. “Molti dei contenuti che vediamo sui social non sono prodotti da psicologi” spiega la dottoressa Eleonora Marocchini, psicolinguista e divulgatrice esperta di neurodiversità. “Ma da persone comuni che condividono esperienze personali. Questo porta ovviamente con sé alcuni rischi: manca un controllo dei contenuti pubblicati, un post su Instagram non è un paper peer-reviewed. È possibile poi che un utente si riconosca in una serie di caratteristiche e che sia quindi spinto a pensare di condividere una diagnosi solo per alcuni tratti in comune. Io mi occupo di spettro autistico, un caso emblematico in questo senso: esistono persone autistiche verbali o non verbali, alcune con disabilità intellettive, altre con un alto potenziale cognitivo. Non tutte le persone che condividono una diagnosi riportano le medesime caratteristiche”.
C’è però un altro aspetto da considerare. “Se una persona si autodiagnostica un disturbo”, continua la dottoressa Marocchini, “significa che avverte una sofferenza o un malessere. Già di per sé, quindi, che qualcuno cerchi aiuto dopo una diagnosi effettuata grazie a Internet, giusta o sbagliata che sia, può considerarsi un effetto positivo”.
La natura dei social media è più orizzontale rispetto a un contesto clinico, in cui la diagnosi o la terapia vengono effettuate one-to-one, in una relazione tra un professionista e un utente. Il contesto della relazione tra pari, che può sfociare nel mutuo aiuto e nella creazione di comunità, che si viene a creare nelle comunità social dedicate alla salute mentale può essere fondamentale nell’alleviare la sofferenza psicologica. Gli utenti, il cui punto di vista è spesso cancellato o sminuito negli iter diagnostici ufficiali, arrivano a sentirsi parte di un contesto dove invece la loro esperienza – e le loro conoscenze rispetto a sé stessi – sono valorizzate.
Moskovitz ha parlato di buzzfeedification della salute mentale, ovvero di riduzione di diagnosi complesse a liste di sintomi o etichette che sclerotizzano e semplificano i discorsi sulla salute mentale e sulle diagnosi.
“Nel caso dell’autismo”, continua a spiegare la dottoressa Marocchini, “ci sono tanti professionisti che continuano a considerarla una condizione unicamente o prevalentemente maschile. Le diagnosi femminili, d’altro canto, crescono sempre di più, tant’è che si inizia a parlare di fenotipo femminile nell’autismo – alcuni lo chiamano anche fenotipo mascherato, dal momento che non sono solo le donne a manifestarlo. In questo caso i bias di genere fanno sì che non sempre il professionista abbia ragione: la competenza di un paziente rispetto alla sua esperienza, scaturita da un’autoriflessione, deve essere valorizzata”.
“Sentirsi una diagnosi ha una sua importanza” illustra ancora Federica Carbone, “Per tanto tempo la terapia è stata una questione asimmetrica, tra esperto e paziente. Il movimento antipsichitriatico ha introdotto l’idea che una persona conosca sé stessa meglio di qualunque professionista. Il professionista, d’altro canto, è esperto della condizione che si sta trattando insieme. Anche grazie alla diffusione dei discorsi sulla salute mentale sui social si è arrivati a dare voce a comunità che prima non l’avevano, e questo ha, ovviamente, anche un peso politico”.
Nonostante esista un sistema sanitario nazionale, in Italia la salute mentale non è accessibile in modo uniforme sul territorio e non è alla portata di tutte le fasce di reddito. Il costo della sanità privata è molto alto, e anche nel caso un paziente venga preso in carico dal sistema pubblico, un percorso, tra diagnosi e terapia, può durare anni. Non solo: non tutte le strutture sono attrezzate per diagnosi specifiche. Se una persona ha la fortuna di vivere vicino a un centro specializzato su particolari disturbi o neurodivergenze, avrà molta meno difficoltà ad ottenere una diagnosi ufficiale – uno strumento che poi apre alla possibilità di ricevere cura, sussidi e supporto pubblico. Date queste premesse, il mutuo aiuto gioca un ruolo fondamentale. “In contesti dove il sistema sanitario nazionale non funziona o non esiste, come negli Stati Uniti” continua Federica Carbone. “Esiste la figura del peer specialist, l’esperto di supporto tra pari. Le persone che vivono una stessa condizione si associano e si danno una mano, compiono azioni di advocacy”.
Come per l’autismo, poi, per tantissime condizioni di salute mentale esiste un bias di genere. Il disturbo borderline è tradizionalmente associato alla natura femminile, quello narcisista a quella maschile. A causa di pregiudizi, non solo da parte dell’utenza ma anche degli esperti, per molte persone risulta difficile ottenere una diagnosi.
“La diagnosi può essere uno strumento importante (per l’accesso al sostegno, ai diritti e ai sussidi) e sarebbe sempre meglio cercare il supporto di un professionista” conclude Eleonora Marocchini. “Ma una buona informazione sui social può avere il suo ruolo, sia da parte di psicologi e psichiatri che da ricercatori e scienziati. Quasi cento persone che mi seguono, nell’ultimo anno e mezzo, hanno formulato un’autodiagnosi di autismo. Nella stragrande maggioranza dei casi la diagnosi è stata confermata.” Se c’è un valore nel processo di auto-identificazione non è solo relativo all’ambiente dei social network. L’autoconsapevolezza è un primo passo per affrontare un processo di recovery. E i contenuti social, con tutti gli ovvi problemi che si portano dietro, sono uno strumento nella creazione di questa consapevolezza. Potrebbe essere ora di normalizzarli come parte integrante di questo percorso.