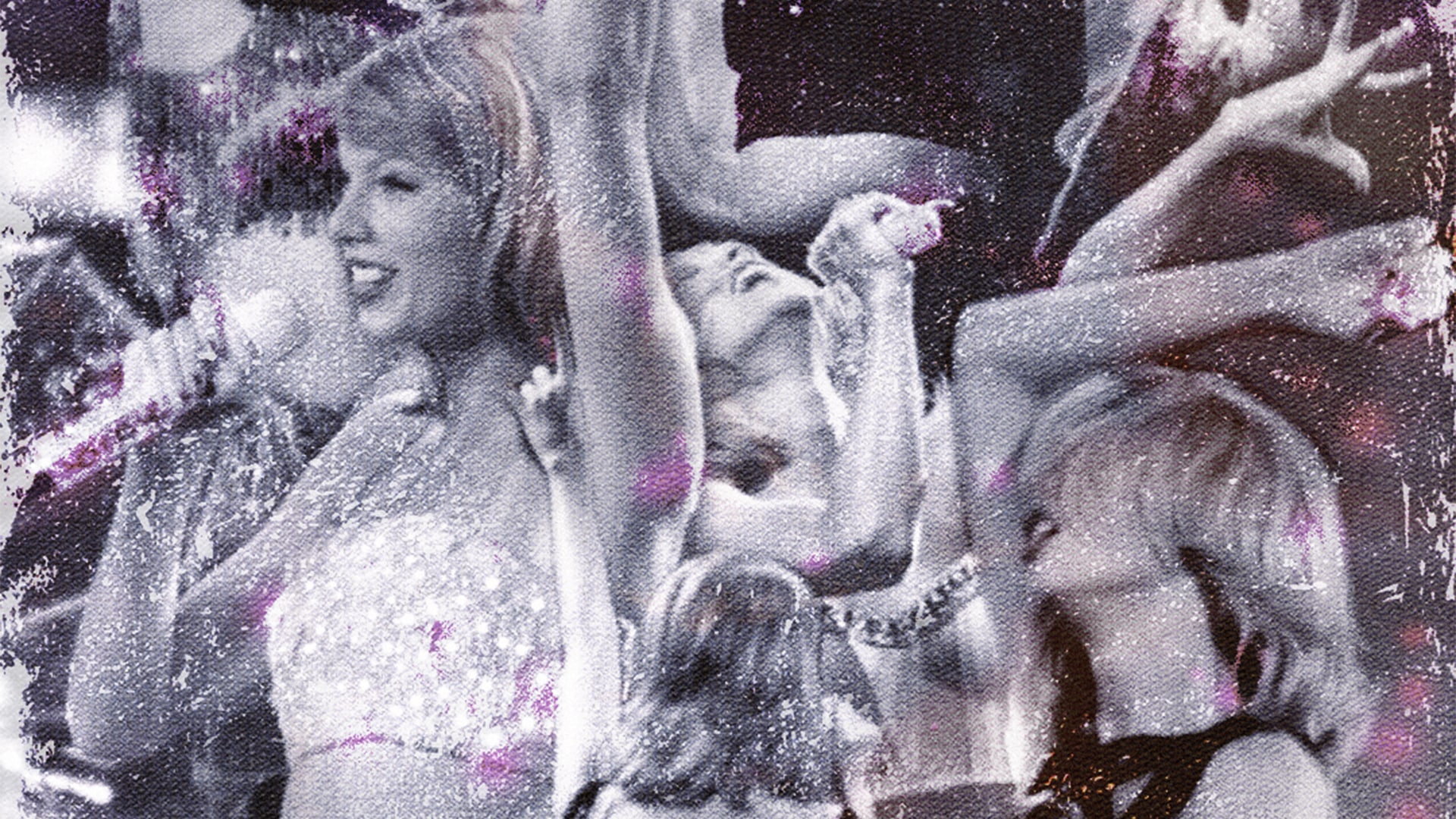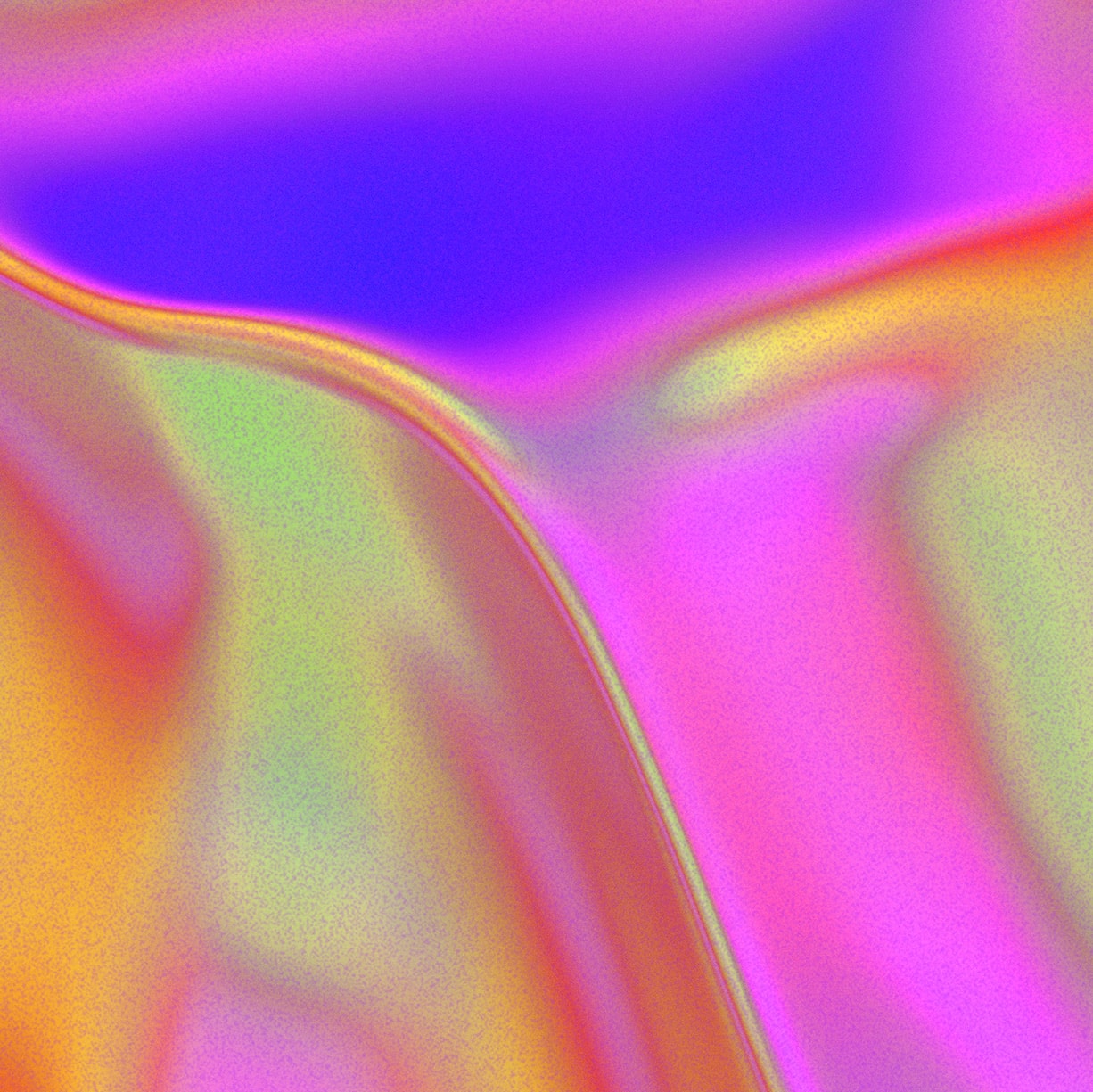La fine del paesaggio11 min read
Paesaggi urbani, paesaggi rurali, paesaggi dell’abbandono, paesaggi della bellezza. Paesaggi virtuali, paesaggi globali, paesaggi locali. Paesaggi della lentezza, ma anche spirituali o letterari.
Nel linguaggio comune, «paesaggio» è uno di quei termini-ombrello utilizzato per dire qualunque cosa: associato a un riferimento che lo caratterizza, è adatto a nominare un luogo, un tema, un immaginario. Paesaggio è tutto e niente. E in effetti è così. Ma è davvero cosi?
Negli ultimi venti anni, a livello comunitario e non, intorno al paesaggio si è aperto un grande dibattito. Nel 2000 è stata promulgata la Convenzione Europea del Paesaggio, strumento di soft law comunitaria volta a costruire il quadro legislativo e valoriale per l’individuazione, la tutela e la gestione dei paesaggi.
Nei primi articoli del documento si dice che il paesaggio è un «elemento essenziale di benessere individuale» e che la «qualità di vita delle popolazioni dipende anche dal godere di un paesaggio di qualità».
Questa qualità viene connessa alla sostenibilità dei metodi di sfruttamento delle risorse: si dice cioè che la qualità di un paesaggio dipende da politiche di sviluppo sostenibile che garantiscano equilibrio tra economia e salute dell’ambiente. Il paesaggio viene quindi inteso come risorsa ambientale ed economica che dev’essere governata e tutelata come tale. A questo si aggiunge che al paesaggio si riconosce una specifica e inedita natura relazionale.

Dal progetto “Pensieri della Sera” di Antonio Di Cecco – Contrasti Urbani
Per buona parte della modernità, il paesaggio è stato un genere pittorico: una veduta spesso di un soggetto rurale, spesso rappresentata da una posizione sopraelevata, se non addirittura zenitale; spesso commissionata da proprietari terrieri e latifondisti per celebrare l’estensione, la bellezza, la produttività dei propri possedimenti. Se nel corso del tempo i soggetti e le modalità di rappresentazione sono cambiati, tra Otto e Novecento, con l’avvento della fotografia, la produzione di paesaggi pittorici ha iniziato a esaurirsi. In quel momento, l’idea di paesaggio si è svincolata dal mezzo pittorico e ha cominciato a essere utilizzata in modo più ampio per indicare la rappresentazione di un territorio. Definizione difficile, legata alla possibilità di individuare perimetri e forme, tracciare l’identità formale e concettuale di un luogo. In questo senso interviene la CEP affermando che il paesaggio si definisce in modo contestuale: che è una porzione di territorio «per come viene percepito dalle comunità». Non è il territorio in sé, ma l’immaginario che lo attraversa e identifica: immaginario e forme materiali che evolvono a seconda degli usi del territorio che a loro volta dipendono dai modelli e dai rapporti di produzione.
Allora, se è vero che il paesaggio non è tanto – né solo – una vista dall’alto, «gli sguardi lanciati sulla superficie terrestre», negli anni che seguono alla CEP si iniziano a riconoscere i diversi regimi di percezione tramite i quali si accede al e si costruisce il paesaggio. Pur dominando la dimensione visiva, emerge l’idea che i paesaggi siano anche olfattivi, uditivi, gustativi, fisici, tattili. Emergono i walkscapes, i soundscapes, i waterscapes. E di qui i paesaggi della lentezza, delle mobilità differenti e dolci. Paesaggi che variano a seconda dell’accesso che li produce: passaggio importante in un’epoca in cui la mobilità ha stravolto e ridisegnato il nostro essere nel mondo.

Sebbene “paesaggio” sia un termine utilizzato spesso come contenitore vuoto – utilizzato in copertina sulle guide turistiche, nelle pubblicità o associato a concetti di relax, svago, fuga dallo stress – il paesaggio è innanzitutto il contesto territoriale in cui agiamo, che determina ed è determinato dalla qualità delle nostre pratiche quotidiane.
In questo senso, se possiamo sicuramente dire che negli ultimi anni è stato fatto tanto per costruire un frame legislativo e teorico volto a tutelare i paesaggi e farli evolvere in armonia con i sistemi insediativi e produttivi, dobbiamo chiederci: in che momento storico siamo, nel nostro rapporto con il paesaggio?
Ci sono alcune risposte positive e molte risposte negative a questa domanda. Il paesaggio, nel nostro quotidiano, è spesso ridotto a suggestivo sfondo del desktop, è un immaginario esotico che si tenta di racchiudere in una playlist di musica ambient su Spotify da mandare in sottofondo mentre il lavoro martella sul sistema nervoso, è l’ambientazione ironica delle riunioni in videochiamata. Ma aldilà della sua funzione di sfondo – fisico o virtuale – il paesaggio esiste e continua a resistere proprio lì, ai margini dell’urbanocentrismo nel quale siamo immersi. Questo non significa che se la passi bene, ma che sicuramente ci sono molte occasioni per tessere un nuovo legame, che sia artistico, tecnologico, antropologico. Da questo punto di vista l’architettura del paesaggio, il design e l’arte digitale hanno certamente letto il paesaggio come una dimensione da tutelare e con la quale instaurare nuovi e virtuosi rapporti.
Il paesaggio è innanzitutto il contesto territoriale in cui agiamo, che determina ed è determinato dalla qualità delle nostre pratiche quotidiane.
Ne L’arte della fuga (Iperborea, 2017) lo scrittore, biologo e entomologo svedese Fredrik Sjöberg racconta l’ossessionata ricerca per ricomporre la storia della vita di Gunnar Widforss, un artista totalmente sconosciuto in Europa, emigrato negli Stati Uniti e divenuto famoso per i paesaggi che rappresentava con i suoi acquerelli. La ricerca di Sjöberg si fa presto esplorazione degli stessi luoghi ritratti da Widforss, nonché metafora per descrivere un disperato tentativo di riportare in auge un rapporto intimo e profondo, reverenziale, paritario, ormai andato perduto, tra umanità e paesaggio. In questa stessa direzione si pone Countryside, The Future, un’esposizione in corso fino ad agosto 2020 al Guggenheim Museum di New York a cura dell’architetto e urbanista olandese Rem Koolhaas nella quale si ridiscute il rapporto tra agricoltura, big-data, tecnologia, ecologia e società umana. Ma i discorsi sulla resilienza del paesaggio, dell’apporto che possono dare le nuove tecnologie sul monitoraggio e la tutela di habitat, biodiversità o anche della pura estetica del paesaggio, proliferano e lasciano immaginare future occasioni di dibattito.
Se da una parte il paesaggio è l’oggetto di attività estrattive, assediato dal consumo di suolo e piegato agli interessi espansivi di una società tardocapitalista, è anche vero che esistono delle nuove modalità con le quali il paesaggio attecchisce nel nostro immaginario: una di queste sono i videogame, una dimensione in cui il paesaggio, paradossalmente, ha un ruolo centrale e primario.
Se quindi prendono sempre più piede e diventano sempre più interessanti le modalità di costruire e interagire con paesaggi virtuali e digitali, tutt’altra cosa accade a livello fisico. Perché se il paesaggio è la rappresentazione del territorio, il territorio è materialmente costruito da Programmi di Sviluppo Rurale, dai Piani Territoriali Paesistici Regionali, dalle tutele dei Parchi. I paesaggi li fanno le politiche agricole e industriali, le opere idrauliche, gli inurbamenti e gli abbandoni, ancora prima e molto di più che le rigenerazioni e i recuperi. Le cattedrali nel deserto, le grandi opere interrotte, diventano addirittura un vero e proprio stile architettonico, secondo Incompiuto – La nascita di uno stile (Humboldt, 2018) un catalogo che raccoglie oltre seicento opere mai concluse in Italia. Questo si aggiunge all’impatto determinante che hanno alcuni modelli produttivi che si relazionano ai territori in modo invasivo, causando radicali trasformazioni paesaggistiche al costo di ingenti perdite di biodiversità e danni ecosistemici. Un recente esempio eclatante è il colossale progetto «Nocciola Italia» lanciato dal gruppo Ferrero nel 2018, che punta a incrementare di un terzo la superficie italiana coltivata a nocciole, per aumentare le superfici coltivate di circa 20.000 ettari, passando dagli attuali 70.000 ad almeno 90.000, non di certo senza conseguenze.

Dal progetto “Pensieri della Sera” di Antonio Di Cecco – Contrasti Urbani
Nel 2013, mentre la città era assediata da tassi altissimi di inquinamento, davanti a uno dei siti panoramici di Hong Kong compariva un pannello con lo skyline della città: uno sfondo di 6 metri per 3 per permettere ai turisti di farsi un selfie con cielo terso e colori brillanti.
È un’immagine emblematica, un po’ più forte, ma non molto diversa, dalle file che – un tempo? – si facevano non tanto per vedere la Gioconda, ma per farsi un selfie con la Gioconda. Un’immagine che rimanda a tutti i filtri e le mediazioni che interponiamo tra noi e l’esperienza dello spazio, tra noi e la percezione del paesaggio. Da TripAdvisor a GoogleMaps, dalle top travel destinations del New York Times al feed Instagram e al concetto stesso di #nofilter, riceviamo continue e penetranti rappresentazioni di luoghi, codificate per target e intessute di significati. Sappiamo dov’è cosa, cosa c’è dove. Qual è il migliore ristorante di zona, come saranno la vista e l’esperienza. Non è tutto né solo questo il modo attraverso cui ci rapportiamo ai luoghi ordinari e straordinari, ma è indubitabile che tutti quegli strumenti che offrono informazioni, accessibilità e governabilità, finiscono per essere dei filtri tra noi e il mondo. Filtri che semplificano la nostra esperienza, la rendono prevedibile e ci sottraggono alcune possibilità connaturate all’esperienza fisica e concettuale dello spaesamento, dell’osservazione, dell’esplorazione.
Alcuni hanno detto che nella postmodernità viviamo la morte del paesaggio, la fine dei luoghi, la moltiplicazione dei non-luoghi. I luoghi, i territori, i paesaggi non finiscono: si ammalano, si banalizzano, vengono espropriati, comprati, deturpati, abbandonati, ma continuano a essere e a poter essere compresi, letti, attraversati. Quello che viviamo non è la fine del paesaggio, ma l’impoverimento della nostra capacità di leggerlo, intesa come capacità di vedere nelle forme dello spazio la storia dei luoghi, negli usi della terra i modelli e rapporti di produzione; nelle statue e nei monumenti celebrativi la dialettica tra egemoni e subalterni.
Non è la fine del mondo, ma della nostra capacità di comprenderlo: guardando, ascoltando, mangiando un alimento o percorrendo una strada, comprendere i ritmi biologici, i meccanismi produttivi, l’impatto degli insediamenti, la qualità della nostra presenza.
Paesaggio lo fanno i marmi e le geometrie fasciste nelle nostre città; così come le statue che celebrano personaggi storici controversi; ma paesaggio lo fa anche l’arte di strada, l’abusivismo condonato, gli sfratti, l’abbandono. Il paesaggio contiene la povertà e la marginalità: spesso le nasconde, ma le contiene. Paesaggio è dappertutto perché è il nostro modo di abitare il mondo e l’immagine che ne deriva: ma è tutto questo a condizione che ci sia uno sguardo – un orecchio, un passo, un tatto – a saperlo raccogliere. Un esercizio quotidiano e che quotidianamente cambia: l’esercizio di leggere, continuamente, il mondo in cui siamo e che ogni giorno contribuiamo a fare e disfare.
ContrastiUrbani è uno studio di fotografia di Antonio di Cecco, con sede a L’Aquila. Sviluppa progetti sui processi di modificazione dei luoghi e sul rapporto tra uomo, ambiente e tempo, oltre a occuparsi di fotografia di architettura e di paesaggio.