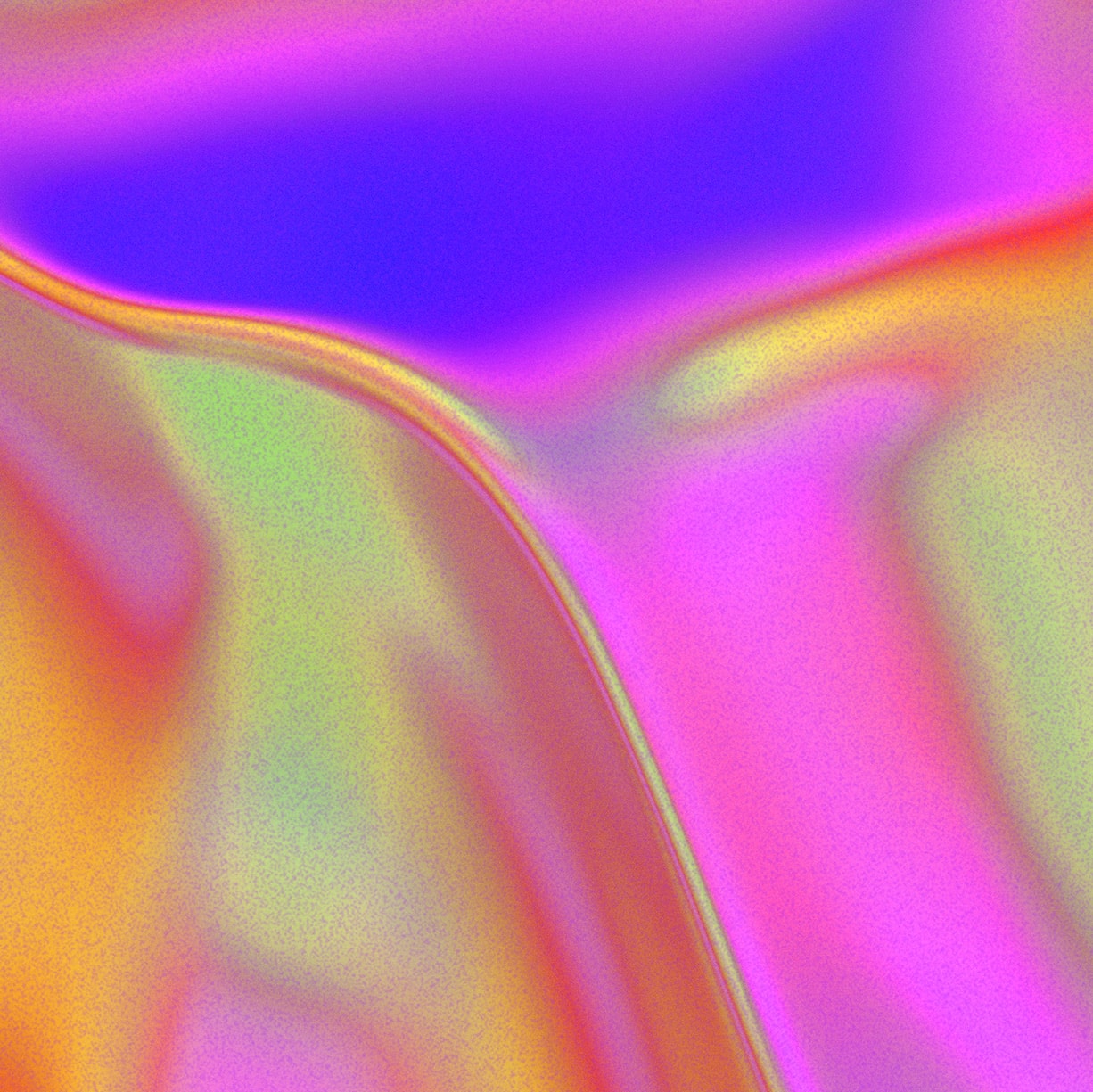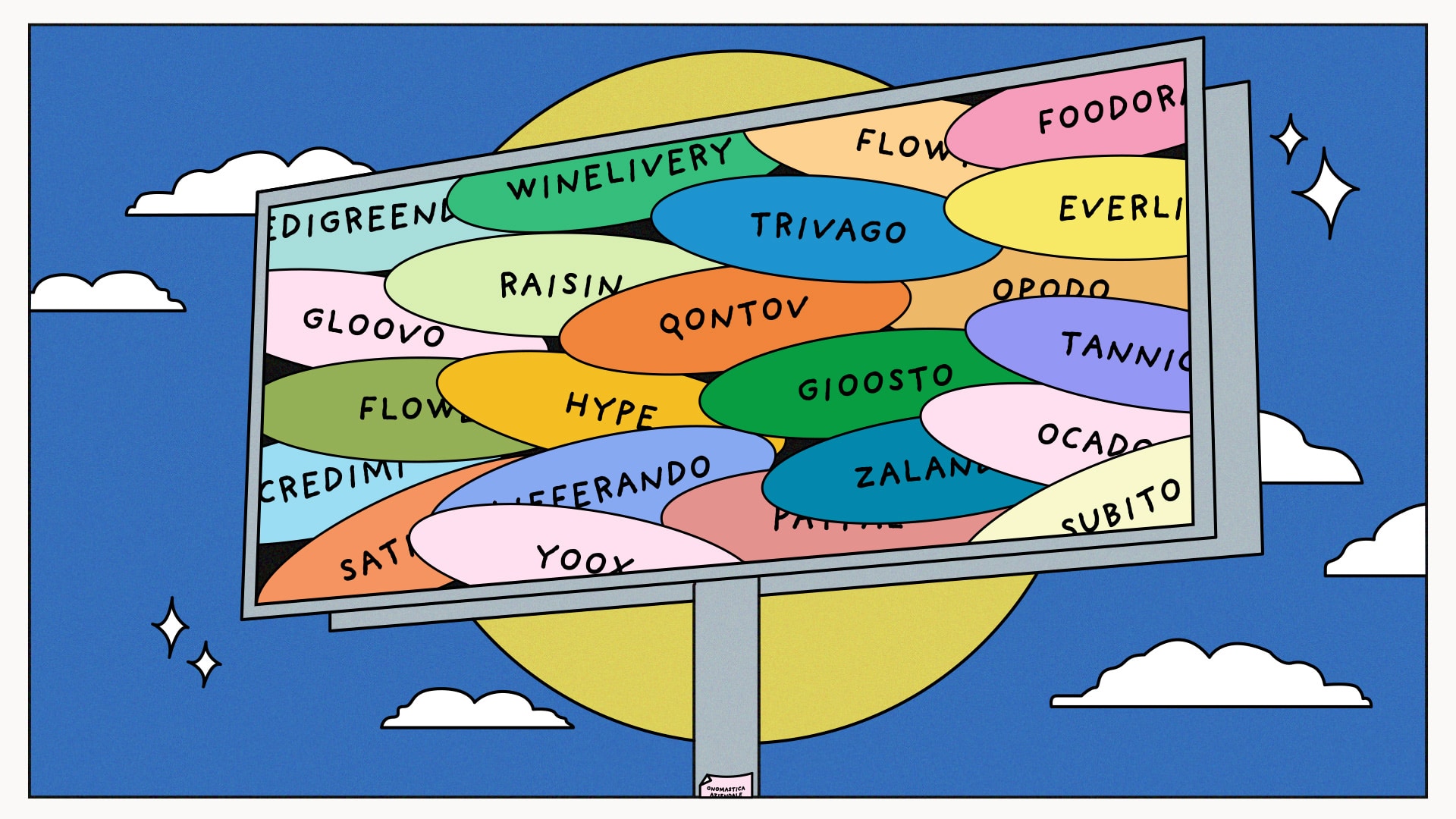
Onomastica aziendale12 min read
Onomastica aziendale12 min read
Una conversazione tra addetti ai lavori sull'arte del branding e del naming.
Qualcuno posta su Twitter la foto di una grande cartellone pubblicitario: “Pedigreender – l’app di incontri per gli amici a quattro zampe”. Lo ignoro: non solo perché non ho amici a quattro zampe da far incontrare, ma anche perché penso sia un meme, uno scherzo della rete piuttosto che della realtà. Poi scopro che servizio e app esistono per davvero. Mi stupisce che qualcuno abbia deciso di chiamare qualcosa di proprio, auspicabilmente nuovo e originale, con una parola occupata già da qualcuno o da qualcos’altro. Mi sorprende l’audacia (o l’ignoranza) con cui l’app ha presunto di identificare il proprio consumatore ideale, escludendo la possibilità che lo stesso vi identificasse le sfumature più o meno umoristiche ivi connesse.
Trovandomi spesso per lavoro o indole personale a dover analizzare e decostruire i linguaggi visivi e letterari con scopi critici o di marketing—vuoi perché mi viene chiesto di creare materiali promozionali per film di nicchia, vuoi perché sono chiamata ad esprimere un’opinione sul modo in cui presentare un prodotto culturale tangibile in un contesto digitale—mi ha sempre affascinato la qualità sintetica ed immediata della pubblicità. Il branding, e più specificamente il naming e cioè l’arte di battezzare marchi, aziende e prodotti, è pratica antica, una presenza che, sin dalla rivoluzione industriale fino all’epoca digitale, è diventata mano a mano più influente ed esplicita. La sofisticazione dei servizi permessa quando non incoraggiata dall’industria del tech spinge verso una segmentazione dell’offerta e della richiesta nonché delle aziende responsabili di soddisfare (o inventare) nuove (o antiquate) aree di mercato. Fin qui, nulla di nuovo. Ma mentre ci abituiamo ad orientarci all’interno di queste costellazioni sempre più essenziali all’equilibrio economico della società, alcune stelle brillano più di altre. La loro longevità si misura in primo luogo con l’efficacia dei nomi dategli, che spuntano e si illuminano come una specie di segnaletica del futuro—eppure in alcuni casi già flebilmente verso lo spegnimento.
«Ikea, per prenderne uno, suona come un nome ostico a un orecchio italiano, ma qui quella “durezza” è stata traslata come rigore e ordine per un certo tipo di stile o proposta—e questa è la bravura del brand nella comunicazione locale: trasmettere sia la sensazione di brand che la promessa del prodotto»
Guardandomi intorno non vedo solo Pedigreender, ma anche: Zalando, Lieferando, Ocado, Opodo, Trivago, Gloovo; Winelivery, Raisin, Tannico, Subito; Gioosto, Yoox, Foodora; Credimi, Satispay, Everli, Flowe… mi fermo di fronte a queste insegne luminose, intravedendo analogie e discordanze ortografiche, sonore e semantiche che raccontano storie linguistiche diverse. Com’è che, insomma, il branding coglie diversa ispirazione dalle varie lingue? Secondo quali processi il naming instaura rapporti incestuosi con linguaggi diversi? Presumendo di non essere l’unica a porsi queste domande, ho deciso di interrogarmi con due esperte, Sofia Piomboni—co-founder e art director di Mine Studio, e Tania Loschi—copywriter veterana e co-autrice insieme a Chiara Galeazzi di Réclame, il podcast dedicato alla pubblicità, nel tentativo di identificare se non una tassonomia specifica almeno lo spirito con cui si sta muovendo l’onomastica aziendale negli ultimi dieci-quindici anni, nel digitale.
Con Sofia cominciamo ad esempio a notare diversi brand stranieri che si appropriano del suffisso -ando e della conclusione in vocale, trasmettendo così una musicalità mediterranea. Ci sono Zalando e Lieferando (il Just Eat tedesco, da “liefern” che significa “consegnare”), ma anche Ocado, una supermercato online inglese, e Opodo e Trivago, due compagnie pan-europee attive nel settore dei viaggi. Ci immaginiamo una possibile teoria: la “gerundivizzazione” di un termine non tramite il diffuso suffisso inglese “-ing” bensì quello spagnolo o italiano, non reca solo una sonorità più familiare e amichevole di quella anglofona, ma comunica intrinsecamente anche l’azione esercitata dai servizi che impiegano questi nomi, e ciò la consegna a domicilio o il “self-service” turistico. Sofia sottolinea inoltre come buona parte dei marchi citati si rivolgono a un target medio-basso e offrano prodotti più o meno alla portata di tutti. Il fatto che si cerchi di allontanarsi dalla “spigolosità” di nomi anglosassoni propri del settore digitale in cui questi marchi operano suggerisce forse che l’utilizzo di sfumature per così dire “romanze” avvenga per rendere i brand più simpatici, più abbordabili anche economicamente? E che quindi ci sia una specie di collegamento tra lo statuto economico culturale che viene dato globalmente a una certa lingua e la lingua stessa. Nella comunicazione pubblicitaria esiste una gerarchia di prestigio tra le varie lingue?

Tania Loschi ci aiuta a riconsiderare questa speculazione identificando nell’impiego o storpiatura delle lingue romanze non un’associazione qualitativa o peggiorativa ma una connessione con le aree merceologiche in cui storicamente questo o quel paese eccelle. «Pur essendo nel digitale si parla di settori completamente diversi. Il focus non è il contenitore bensì il contenuto». Gli specimen presi in analisi trattano infatti di abbigliamento, cibo e turismo, tre settori con cui l’Italia campa esportando eccellenza e notorietà. «Se ci pensi, Zara ha dovuto dare alla sua linea ‘alta’ il nome Massimo Dutti, cioè il nome di una persona che non esiste, per cercare di ricalcare il registro verbale della moda». Se penso solo alla Germania, il cosiddetto “foreign branding” ha dato alla luce mostri come Riccardo Cartillone o Bruno Banani. «Per ora e finora il tech non ha avuto modo di comunicare all’italiana perché è un mercato che è nato in America e chi per primo l’ha presidiato in maniera eccellente e universale ha dettato le regole. Esattamente come noi abbiamo l’abbigliamento o il cibo, loro hanno il tech. Sono linee guida non dette: quando ci arriva un brief di moda, sappiamo già che esistono delle regole di comunicazione proprie del settore, diverse dal mercato del beverage, del lusso, del food, dell’automotive… Ogni mercato si porta dietro la propria tradizione linguistica—dove nasce, eredita anche la sua voce».
Quello che poi conta è anche l’immaginario, prosegue Sofia, «è cruciale. Prendi Apple: se gli autori del branding non avessero avuto chiaro cosa volevano creare intorno a un nome che vuol dire già “mela”, non sarebbero riusciti a farlo diventare così importante. È un processo che io vedo nell’applicazione di qualsiasi cosa. Ad esempio, la durezza di un nome dev’essere rispettato dall’immaginario visivo, così come dalla comunicazione che ne viene fatta. Ikea, per prenderne uno, suona come un nome ostico a un orecchio italiano, ma qui quella “durezza” è stata traslata come rigore e ordine per un certo tipo di stile o proposta—e questa è la bravura del brand nella comunicazione locale: trasmettere sia la sensazione di brand che la promessa del prodotto». Capita però che “l’autoconsapevolezza” di un marchio non rispecchi esattamente ciò che originariamente ambiva a comunicare. Pensiamo ad esempio a Gioosto e Yoox: entrambi negozi online, il primo vende e consegna prodotti solidali, il secondo capi di lusso. Non potrebbero essere più diversi, tanto più che Yoox è stato recentemente al centro di proteste e scioperi per il maltrattamento dei suoi lavoratori, soprattutto durante la crisi coronavirus. Eppure nascono entrambi come rivenditori online e cosa c’è di più riconoscibilmente online della doppia “o” di Google? L’appropriazione rimane poi criticabile. Gioosto (cioè “giusto”, mi fa notare Tania), rivela di puntare a un consumatore consapevole e digitalmente alfabetizzato, che non solo è abituato a pronunciare la doppia oo all’inglese, ma ha anche a cuore il lavoro di chi produce beni di consumo: una sovrapposizione presumibilmente corretta. Yoox, invece, rivela forse solo una nascita (nel 2000) agli albori della bolla dell’e-commerce. «Nel momento in cui un brand forte detta un trend, poi improvvisamente tutti gli altri vanno dietro». Questa verità, che Tania maneggia con dimestichezza mentre a me pare novità assoluta, per un secondo mi risulta incredibilmente affascinante. La comunicazione pubblicitaria non solo inventa le mode… ma ne è anche afflitta! Consideriamo un’app come Satispay, che «è super-figlia di uno dei trend, quello lanciato da Spotify. Solo che ci hanno aggiunto la parte di pagamento e un prefisso che è ‘sati’—il satis che richiama la soddisfazione. Hanno guadagnato in musicalità e insieme cercato di allontanarsi da PayPal invertendo i pesi sia a livello visivo con le lettere, sia a livello semantico. Se PayPal ti parla prima del servizio—il pagamento—e poi tocca la parte emotiva—il “pal”, il compare, amico in inglese—Satispay anticipa l’aspetto emotivo e poi mostra quello funzionale del pagamento. Secondo me hanno fatto una furbata con questo naming perché sarebbe stato assurdo allontanarsi dal player che tutti conosciamo da anni. Poi offrono un servizio molto innovativo, per cui almeno nel nome dovevano cercare di essere il più familiare possibili. Non devono spaventare, devono rassicurare…»
«Se ci pensi, Zara ha dovuto dare alla sua linea 'alta' il nome Massimo Dutti, cioè il nome di una persona che non esiste, per cercare di ricalcare il registro verbale della moda»
Complessi, articolati e originali come spesso sono, i brand scaturiscono da processi creativi non dissimili da quelli artistici. Fatico dunque a valutarli con uno spirito diverso da quello critico-estetico, e quando incontro un brand che scimmiotta un altro, non mi fido. La replica mi puzza di frode, la pigrizia concettuale di difettosità. Bisogna arrendersi ai trend? Non bisognerebbe cercare di romperli per crearne altri che dettino tendenza? «Un conto è un trend che fa un effetto di ‘copia della copia’: se nel nome imiti, figurati nel prodotto che qualità puoi avere. Ragionamento sacrosanto ma molto sottile. Lo fai tu ma ovviamente non lo fanno tutti: per molti la copia della copia è come la prima» mi richiama all’attenti Tania. Non solo siamo lontani da una scienza esatta—per cui i risultati di generatori automatici di naming o loghi raramente passano alla storia—ma anche dalla poesia, diciamo, propria di un’opera d’arte. È una partita che si gioca molto più terra-terra, in un’arena dove è necessario trovare l’incastro perfetto tra innovazione e riconoscimento. E anche, letteralmente, tra contenitore e contenuto. «Dipende sempre dal settore: in alcuni non puoi permetterti di essere la copia della copia, vedi la moda o l’automotive. Il discorso che facevo su Satispay è molto diverso perché il mercato finanziario e tutto ciò che ha che fare con banche e soldi deve avere come prima regola l’essere rassicurante. Nel momento in cui lo sbarramento è rappresentato da questo, ad esempio, è corretto rimanere nel seminato. Un altro trend è quello delle banche digitali che stanno spuntando come funghi in questo momento: N26, Flowe, Hype, My Genius. Sfruttano tutti un nome molto corto che non lascia spazio a fraintendimenti, e si permettono—eccetto N26—di essere fantasiosi proprio perché dietro hanno gruppi finanziari consolidati come Mediolanum, Unicredit, Monte dei Paschi, Fineco. Casualmente l’unica che ha un nome più istituzionale, o che non poteva permettersi un estro creativo, è N26, che non ha un gruppo alle spalle ed è totalmente indipendente. Pensa a Qonto: nessuno si sarebbe mai sognato di storpiare il nome di un banca».
E invece… Alla fine il quadro che ne esce è molto meno pregiudicato di quanto pensassi rispetto a lingue internazionalmente più marginali come l’italiano. Paradossalmente il linguaggio pubblicitario è esterofilo in modo ecumenico, quanto e più dell’italiano. In un mondo così confuso e dominato da un mercato globale, mi piace constatare che valgono e sopravvivono ancora delle sfumature linguistiche locali. Che importanza ha se poi vengono storpiate, per venderci cose che non sapevamo ancora di volere? Prisencolinensinainciusol, come direbbe Adriana Celentano.