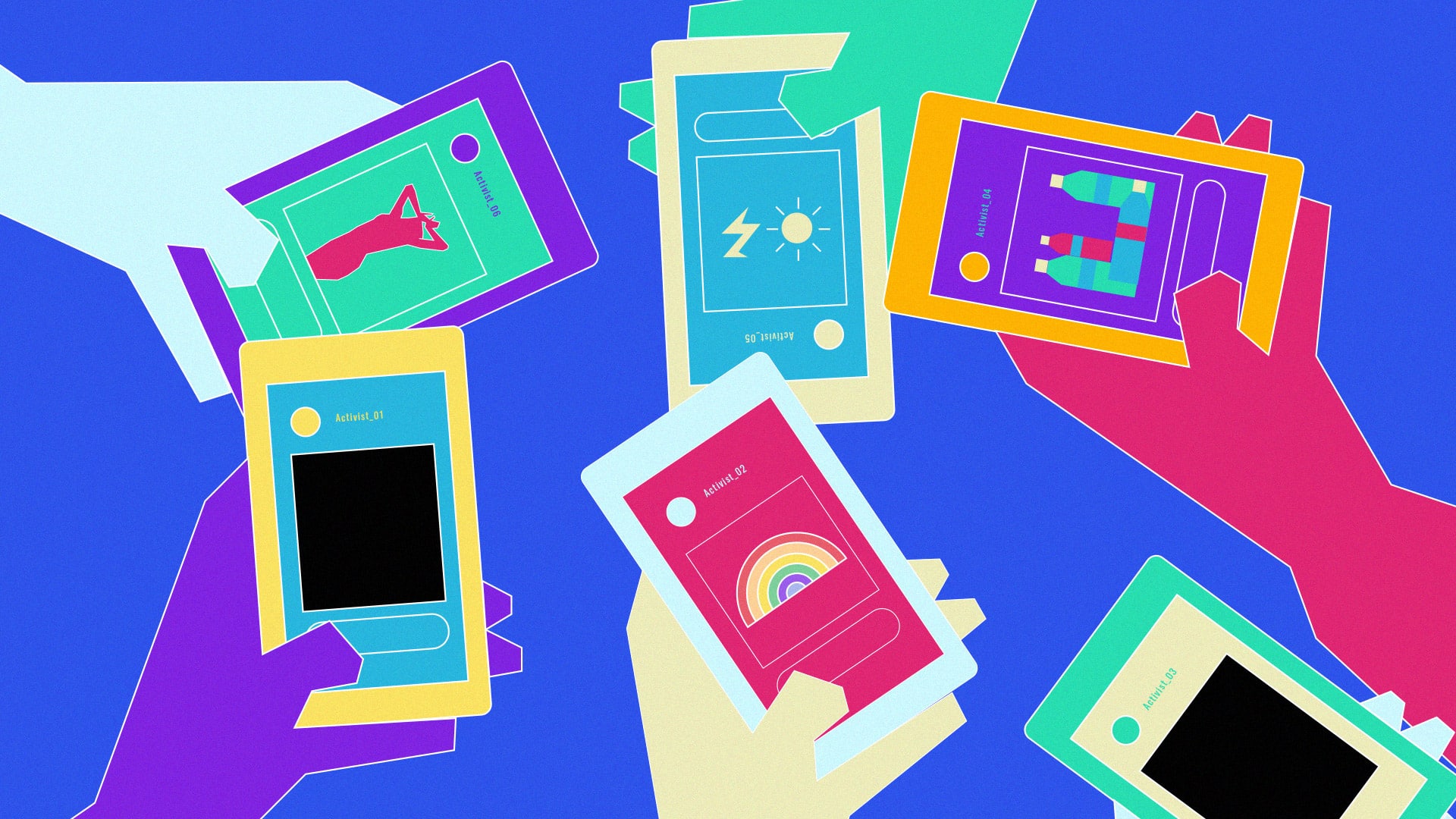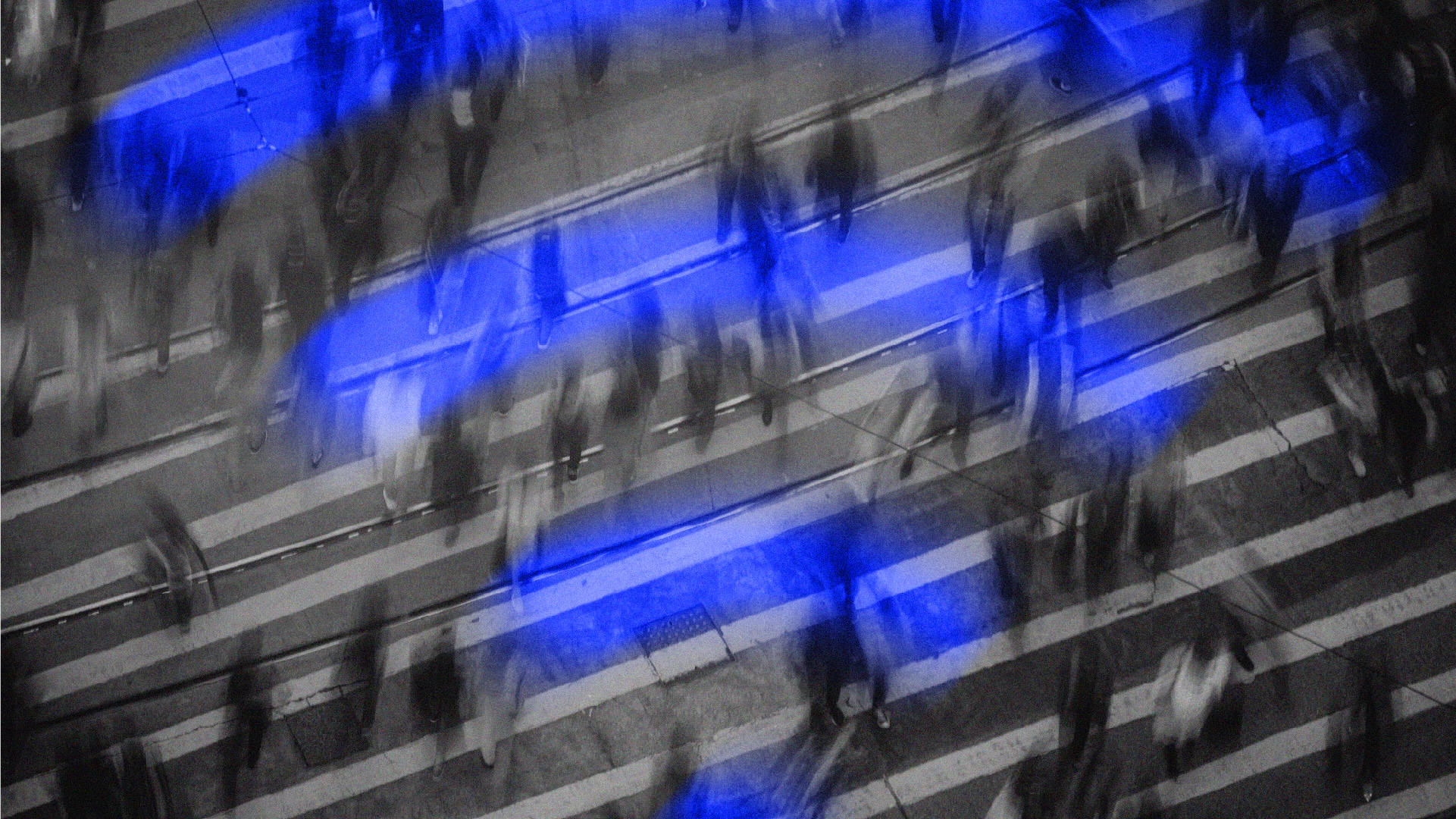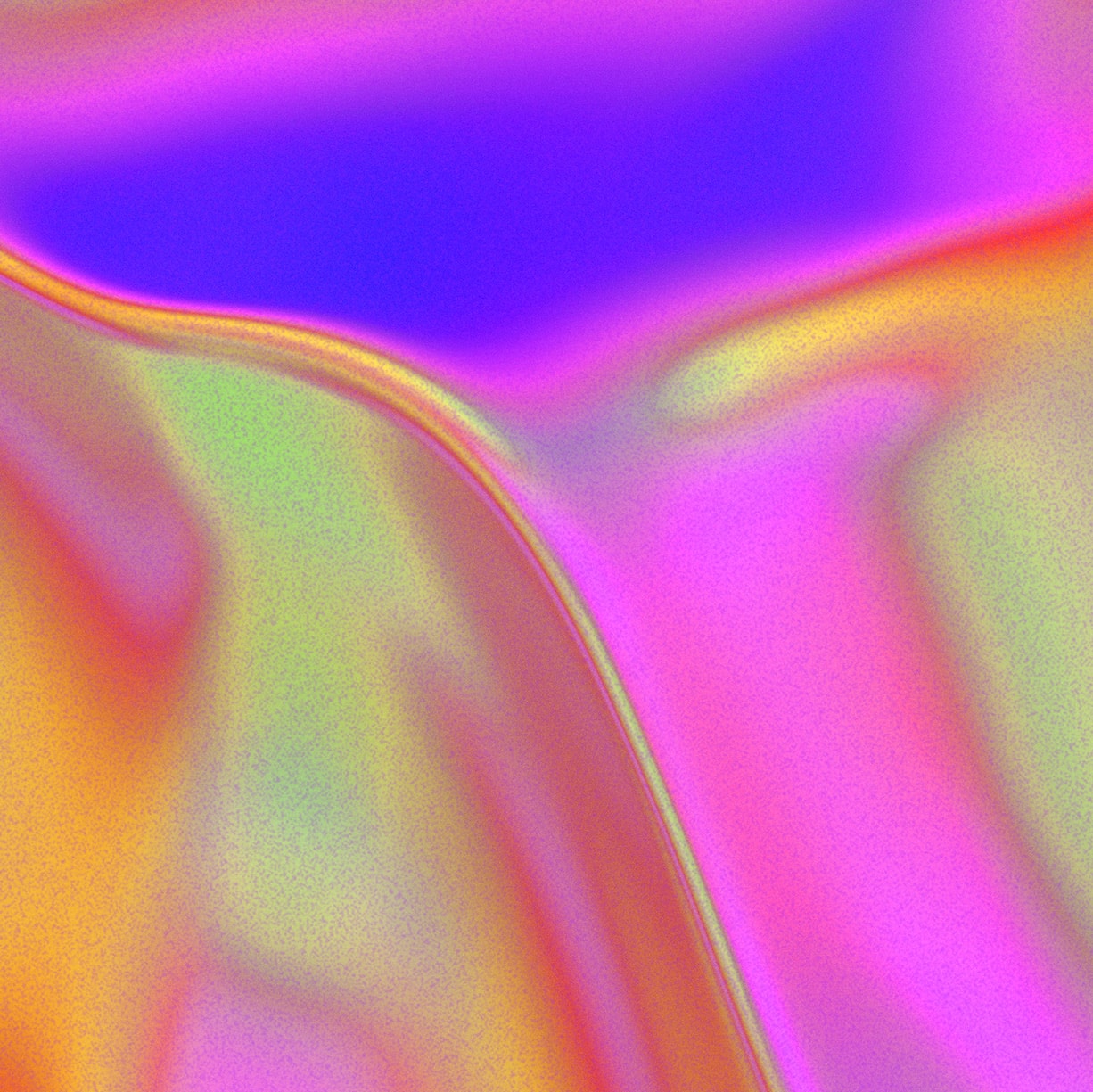Qui dove tutto è performance12 min read
Qui dove tutto è performance
Sui social media la competitività per catturare l’attenzione degli utenti non è mai stata così agguerrita.
«E senza dubbio il nostro tempo […] preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essere. Ciò che per esso è sacro non è che l’illusione, ma ciò che è profano è la verità».
Così scriveva Ludwig Feuerbach nel 1874 anticipando profeticamente la deriva post-modernista: la società della performance.
Come spiegano Maura Gancitano e Andrea Colamedici nel libro La società della Performance, nel nostro tempo tutto è divorato e reso «commercializzabile – cioè qualcosa attorno al quale è possibile creare un mercato, fare marketing, hype e che, soprattutto, scardina il meccanismo centrale dello spettacolo, ossia la presenza da una parte degli attori e dall’altra degli spettatori. Oggi non esiste più il diaframma che separava la platea dal palco: oggi esistono solo performer».
Ciò è reso possibile dell’evoluzione tecnologica inserita nella vita di tutti i giorni: basta avere un social network per essere un progetto creativo, un brand, qualcosa da alimentare perché rimanga appetibile e destinato a esistere.
«Se non sei online e non condividi ogni aspetto della tua esistenza – anche il più insignificante – non esisti, il tuo progetto muore, e dunque muori anche tu. È sempre più facile, infatti, sovrapporre la propria identità personale al proprio profilo pubblico, la persona al numero dei suoi follower, ed è sempre più difficile ricordarsi che si tratta solo di un avatar, di un simulacro, di un’imitazione. Non è più l’avatar a dover somigliare alla persona, ma la persona a dover essere all’altezza del proprio avatar. È l’identità reale a essere funzionale all’identità virtuale».
Nella società della performance la separazione fra reale e virtuale cessa di avere confini. Quello che accade ha maggior rilievo, solo se pubblicato, condiviso e possibilmente spettacolarizzato.
Quando mi è stato chiesto se fossi realmente andata in un posto dato che non avevo pubblicato nulla, mi è apparso chiaro quanto il mio profilo Instagram fosse un portfolio ambulante delle mie attività per qualcuno.
Non tutto quello che realmente mi coinvolge finisce sul mio profilo. Non necessariamente e non sempre in tempo reale: perché mi dimentico, oppure ho la batteria scarica, perché non ho voglia di far diventare una cena in un ristorante filippino un progetto creativo. Probabilmente perché mentre si travasa un momento reale in uno virtuale, si cessa di essere lì per essere altrove, si cessa di essere con qualcuno in virtù di una moltitudine (spesso indefinita), perché le possibili interazioni e le domande in reazione alla foto degli Yaki Udon portano via tempo ed energie.
L’eccessiva esposizione ai social può portare a sentimenti di invidia, tristezza o impotenza, o portare a improvvise valutazioni della propria vita (perché non so suonare uno strumento, dovrei imparare a surfare, esco abbastanza, prendo abbastanza like?)
La società della performance è figlia della società dell’immagine di Guy Debord. Dall’omonimo saggio sono passati molti anni ma il nucleo principale resta valido:
«Lo spettacolo, compreso nella sua totalità, è allo stesso tempo il risultato e il progetto del modo di produzione esistente. Non è un supplemento del mondo reale, la sua decorazione aggiunta in più. È il cuore dell’irrealismo della società reale. In tutte le sue forme particolari, informazione o propaganda, pubblicità o consumo diretto di divertimenti, lo spettacolo costituisce il modello presente della vita socialmente dominante».
La società dell’immagine è una visione del mondo che si è oggettivata, in pratica una Weltanschauung concreta e operante, materialmente tradotta.
Similmente Byung-Chul Han in Psicopolitica parla dell’«io come progetto, che crede di essersi liberato da obblighi esterni e costrizioni imposte da altri, si sottomette ora a obblighi interiori e a costrizioni autoimposte, forzandosi alla prestazione e all’ottimizzazione».
Per il filosofo il sistema neoliberista è efficace nello sfruttare la libertà: tutto ciò che rientra nelle forme espressive pratiche della essa, come l’emozione, il gioco e la comunicazione sono impiegate per raggiungere il massimo rendimento, e non contro la volontà ma sfruttando l’investimento volontario del soggetto.
Già American Psycho di Bret Easton Ellis ci aveva fornito un assaggio dell’impatto del capitalismo sulla società. In una frenetica Wall street degli anni 80′ dietro Patrick Bateman, un giovane di successo a cui in apparenza non manca nulla, si cela uno psicotico.
Alla fine del film (spoiler) non sappiamo se realmente il protagonista ha compiuto tutti quegli omicidi, o se li è immaginati, quel che è certo è che né lui né gli altri hanno una reale percezione del suo disagio.
A peggiorare la situazione il fatto che tutti diventano confondibili in quanto troppo simili, con lo stesso taglio di capelli, i vestiti identici, gli stessi ristoranti, insomma dei replicanti piuttosto assoggettati al sistema.
I social non hanno fatto che aumentare i modelli di competitività già insiti in natura. Un esempio lampante sono le app di dating: è molto facile abbandonare una conversazione se c’è qualcun altro più simpatico o coinvolgente, o non dare una spiegazione e fare ghosting
Nelle perfette sembianze cinematografiche di Christian Bale, Bateman fin dalle prime immagini si dimostra ossessionato dal culto del corpo con un rituale che metterebbe in crisi anche le tiktoker più esperte. Quando la sua segretaria sottolinea quanto sia già magro e possa quindi accettare del sorbetto, lui le risponde: «si può essere sempre più magri».
Siamo agli albori della società dell’immagine e infatti non avere il biglietto da visita considerato migliore scatena in lui una follia omicida.
Nell’era del tardo capitalismo la competitività è ancora la parola chiave più calzante, siamo gladiatori in un’arena virtuale che devono acquisire nuove skill per (ri)lanciarsi sul mercato del lavoro, curare la propria immagine per essere più appetibili sui social media, riuscire ad essere più accattivanti (di qualcun altro, ça va sans dire) quando si tratta di dating.
Negli ultimi vent’anni sono cambiati i modelli e le modalità attraverso cui si esprime la competizione ma non gli effetti sulle persone.
Stando agli studi questo può scatenare sentimenti contrastanti, specialmente di invidia, tristezza o impotenza, o portare a improvvise valutazioni della propria vita (perché non so suonare uno strumento, dovrei imparare a surfare, esco abbastanza, prendo abbastanza like?).
Se il tuo lavoro non ti piace e la tua carriera non sta progredendo aprire LinkedIn può essere davvero frustrante, perché quasi tutti sono lì per mettere in vetrina i loro successi.
A colpi di upgrade di carriera, badge per le nuove competenze acquisite, nuove posizioni lavorative, titoli altisonanti, LinkedIn sa essere uno spazio ospitale solo per ego gonfiati.
I social non hanno fatto che aumentare i modelli di competitività già insiti in natura. Un esempio lampante sono le app di dating: è molto facile abbandonare una conversazione se c’è qualcun altro più simpatico o coinvolgente, o non dare una spiegazione e fare ghosting, quando qualcosa di potenzialmente più allettante è alla portata di uno swipe.
La competitività assume varie forme, uno dei format più di successo di TikTok sono proprio le “challenge”. Sull’app cinese è palpabile la necessità di seguire i trend, fosse anche solo per utilizzare un effetto che può mandare il tuo profilo virale.
Rispetto alle generazioni passate gli zoomer sono più inclini a comunicare e condividere pensieri e sensazioni, grazie alle tecnologie virtuali vissute come un’estensione naturale.
Di fronte a foto e video che testimoniano e raccontano la vita delle persone nei più intimi dettagli viene da chiedersi se qualcuno un giorno non si pentirà di avere così tanto materiale privato facilmente accessibile da chiunque.
Debord aveva osservato come lo spettacolo sia in grado di alterare le interazioni e le relazioni umane. Le immagini influenzano quotidianamente le nostre vite e le nostre convinzioni, come la pubblicità produce nuovi desideri.
Le sue nozioni possono essere estese alla nostra attuale dipendenza dalla tecnologia, Debord, quasi certamente criticherebbe i social che riducono le nostre vite a una serie di scambi di materie prime, inorridito soprattutto dalle società proprietarie, come Meta, che monetizzano le nostre amicizie, opinioni ed emozioni.
Ogni volta che identifichiamo noi stessi con ciò che facciamo, o che applichiamo una strategia produttiva ad ambiti più esistenziali “stiamo performando”.
La meditazione che diventa mindfulness, ad esempio, risponde pienamente a questa dialettica.
C’è chi ha parlato anche di “McMindfulness”, termine coniato dall’insegnante buddista e psicoterapeuta Miles Neale per descrivere «una frenesia alimentare di pratiche spirituali che forniscono un’alimentazione immediata ma nessun sostentamento a lungo termine».
Anche per il filosofo Slavoj Žižek l’obiettivo della mindfulness è «aiutare le persone a partecipare pienamente alla dinamica capitalista mantenendo l’apparenza della sanità mentale».
Una sorta di palliativo per ridurre gli effetti devastanti di una vita accelerata e stressante, anziché eliminare ciò che ci porta ad essere saturi.
La mindfulness è un’ennesima forma individualismo che si concentra sulla persona dimenticando l’importanza della collettività, contrariamente alla meditazione buddista che si focalizza sull’equilibrio e il bene di tutti gli esseri.
L’idea che tutto migliorerà senza che nulla debba cambiare realmente, a partire da noi stessi, resta uno dei maggiori problemi correlati.
Sembra che la realtà sia diventata una rappresentazione e che ogni ambito delle nostre vite sia soggetto a una sfida, in una ricerca infinita di realizzazione.
In uno scenario del genere l’identità reale finisce per essere funzionale a quella virtuale ed è la vita a servire come narrazione utile alla meta-vita.