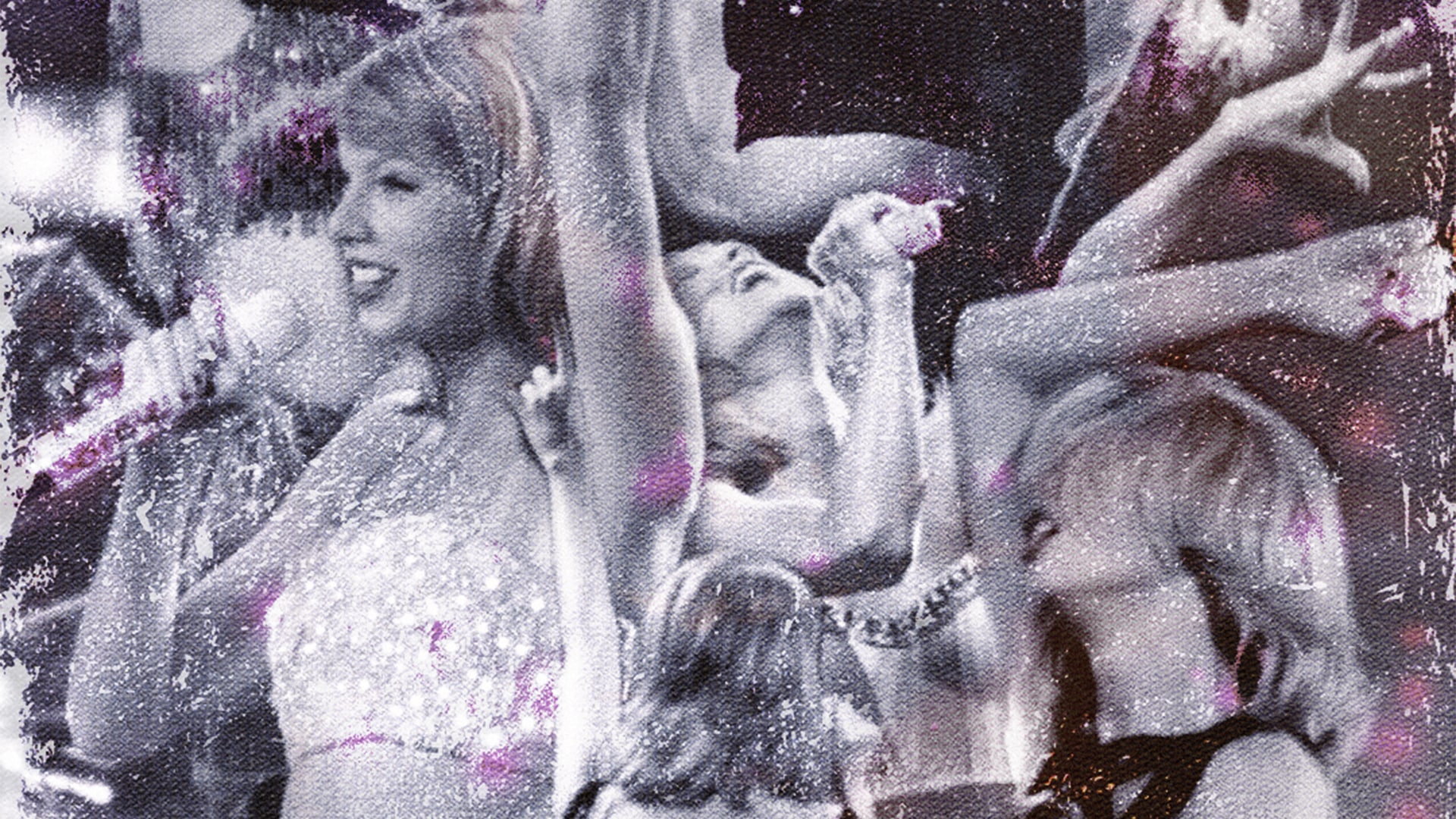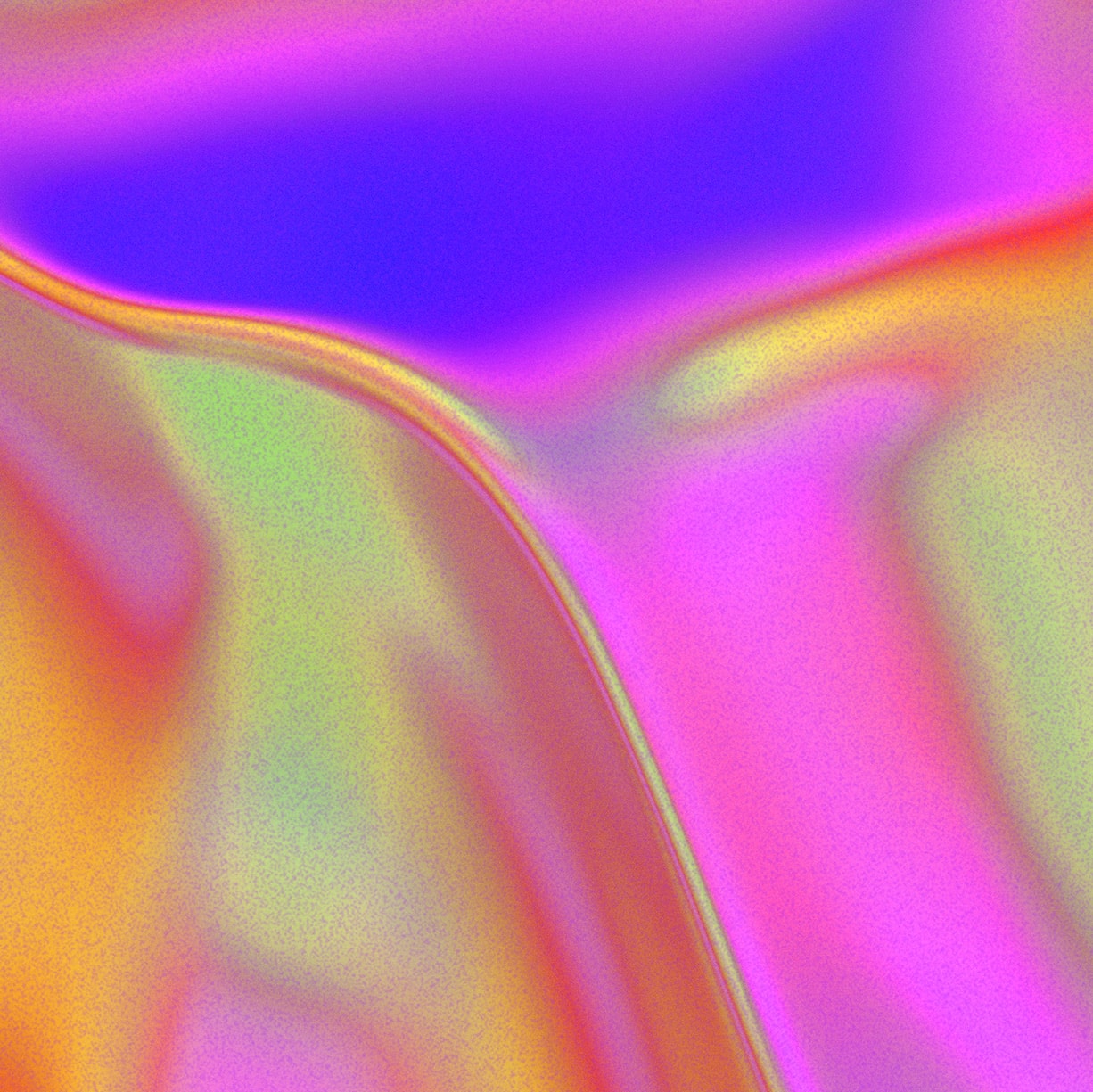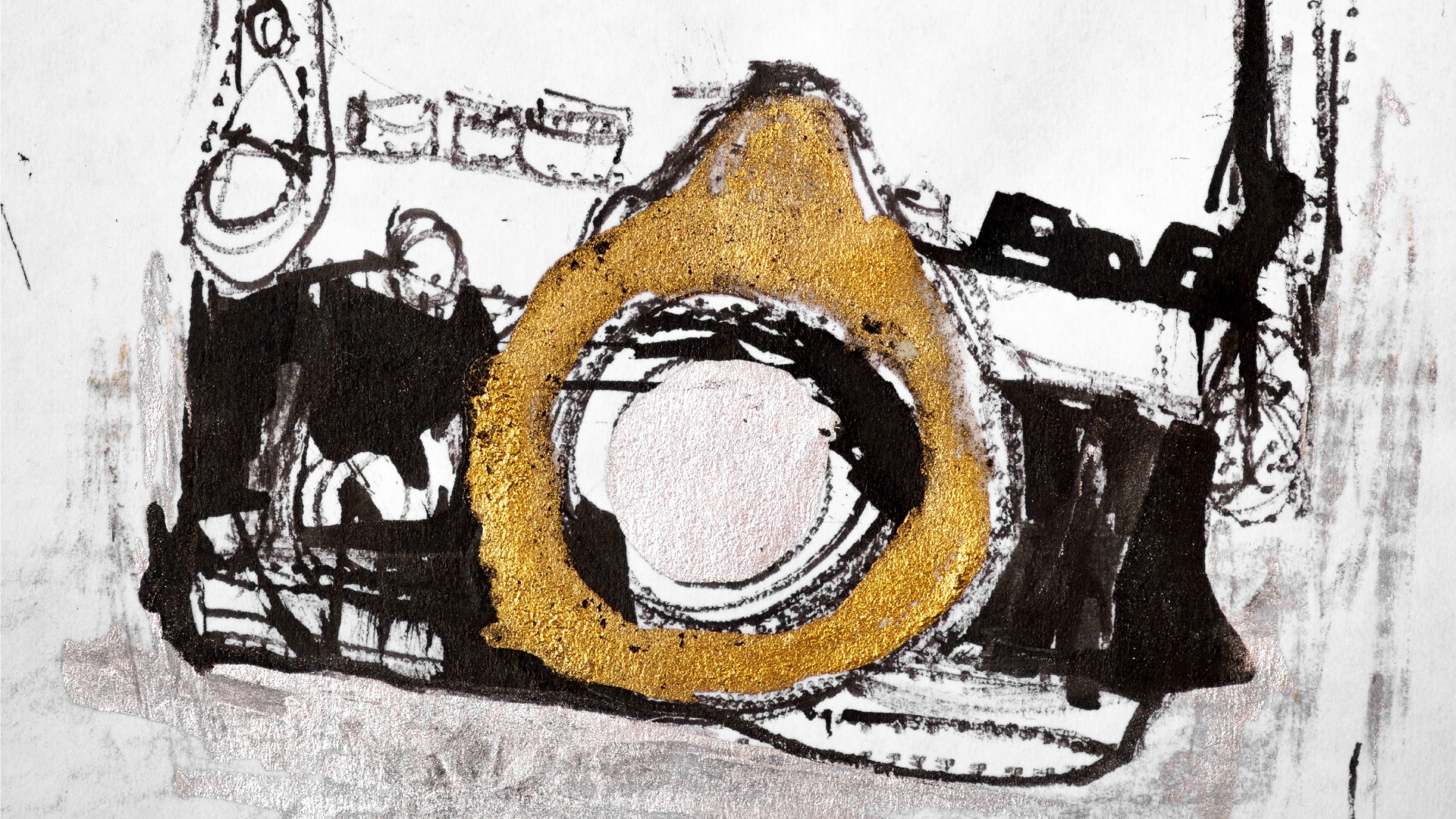
Che diritto ha il fotografo di turbare l’universo?14 min read
Che diritto ha il fotografo di turbare l’universo?
La messa in posa come inganno, necessità ed evocazione di fantasmi
A un primo sguardo, nella realtà, nel suo accadere naturale, c’è tutto ciò che serve per poterla raccontare. Ogni avvenimento trova il suo svolgersi perfetto e senza sforzo, ogni individuo è il personaggio di una sceneggiatura pressoché definitiva. Gli eventi si compiono con la partecipazione a un tempo conscia e inconscia di tutti gli elementi, animati e inanimati, i sogni della gente e le architetture che attraversa, i gesti, i cambi di programma, cento indecisioni, e cento visioni e revisioni. Tutto, a ben guardare, possiede una propria intima e inviolabile giustificazione per il solo fatto di accadere, come per lo scacchista esperto per cui ci sarà sempre e solo quell’unica mossa veramente giusta e necessaria per portare avanti la partita. Che bisogno c’è, allora, di forzare un equilibrio tale, assoggettarlo alla volontà di un uomo solo? Perché, per arrivare al punto della questione, il fotografo ha sentito fin dagli esordi l’impulso di orchestrare il reale, per trovare quale significato aggiuntivo, in ciò che vedeva?
Che bisogno c’è, allora, di forzare un equilibrio tale, assoggettarlo alla volontà di un uomo solo? Perché, per arrivare al punto della questione, il fotografo ha sentito fin dagli esordi l’impulso di orchestrare il reale, per trovare quale significato aggiuntivo, in ciò che vedeva?
La messa in posa è un espediente narrativo molto usato in fotografia e su cui però ci si sofferma poco: comunemente oggi viene associato alla staged photography, scuola fotografica molto diffusa soprattutto tra autori statunitensi e olandesi e che vede in Gregory Crewdson uno dei suoi maggiori rappresentanti.
Allo stesso tempo il tema della messa in posa ha generato storicamente delle vere spaccature nelle correnti di pensiero che volevano una registrazione del reale attraverso uno sguardo puro e senza interventi rispetto a chi vedeva quelle forzature legittime per raccontare al meglio la propria visione del mondo.
Se per rappresentare un sermone in chiesa – scena reale e quotidiana – decido di chiedere ai presenti di stare fermi per alcuni secondi e di mettersi in modo da poterli vedere tutti nell’inquadratura, o di assumere un’espressione assorta e immobile perché non vengano mossi sulla lastra, quanto sto distorcendo il fluire degli eventi? Totalmente nello specifico, quasi per nulla in generale, verrebbe da dire. Introdurre la verosimiglianza in fotografia ha da subito avuto un significato radicale, perché significa introdurre nel suo spazio discorsivo, oltre alla presunta verità assoluta che si è sempre proposta di registrare e restituire, una verità simbolica che riesca a trascendere la legge del qui e ora cui il documentarismo ha da sempre accondisceso.
Introdurre la verosimiglianza in fotografia ha da subito avuto un significato radicale, perché significa introdurre nel suo spazio discorsivo, oltre alla presunta verità assoluta che si è sempre proposta di registrare e restituire, una verità simbolica che riesca a trascendere la legge del qui e ora cui il documentarismo ha da sempre accondisceso.
L’immagine descritta poco sopra esiste – Sermon en la aldea è il suo titolo, realizzata nel 1903 mettendo in posa 29 soggetti – e va contestualizzata per aggiungere qualche elemento al discorso: l’autore è il pressoché sconosciuto José Ortiz Echagüe, 1886-1980, spagnolo, presidente della Seat, esperto in aviazione, esponente di quella corrente fotografica controversa definita pittorialismo. Nel consegnarci la propria idea di Spagna, quella Spagna fervente nella fede e nelle tradizioni, nei rapporti e nella terra, Echagüe compone, razionalizza, mette in posa i propri soggetti in veri e propri “quadri”, come anch’egli definì i suoi lavori, per raccontare quella vera Spagna in cui tutti i suoi connazionali hanno potuto riconoscersi. Resta da chiarire dove possa trovarsi il vero limite, allora, tra la finzione pittorialista e la documentazione (forse impropriamente) definita pura; e dove fra i tre sacerdoti immortalati dal fotografo spagnolo e le tre Spigolatrici di Millet.

“Avrò il coraggio di turbare l’universo?” si chiedeva Alfred Prufrock con le parole di T.S.Eliot.
Il fotografo può trovare quel coraggio che invece manca all’antieroe letterario del primo Novecento: chiuso in un immobilismo paradossale, quasi ridicolo, il nuovo prototipo del protagonista letterario europeo – non soltanto Prufrock, ma anche Augusto Pérez di Miguel de Unamuno (Nebbia) o Zeno Cosini di Italo Svevo (La coscienza di Zeno) – supera le soglie del secolo privo di ogni volontà effettiva, incapace di concepire un solo gesto che possa affermare la propria identità nel mondo. È un protagonista in parte figlio del capolavoro-manifesto decadente di Joris-Karl Huysmans Controcorrente (À Rebours, 1884), in cui si riscontra l’apice del solipsismo a cui possono giungere le passioni e l’intelletto dell’uomo, come la sua incapacità di creare un qualunque rapporto col reale, svuotato di ogni attrattiva. È l’inetto per definizione, sprofondato senza rimedio nell’incertezza solitaria su come e dove condurre la propria esistenza. Il fotografo entra nel secolo in un modo molto diverso, scoprendo di poter incidere la propria visione del mondo chiedendo alle persone di stare ferme per lui.
Il genere del reportage, in fotografia, dichiara che il reale può assumere autonomamente la forma perfetta per essere colto e raccontato; e si basa sulla alquanto dilagante certezza che, come secondo l’”effetto farfalla”, nulla debba essere disturbato nel proprio svolgersi per non alterare le conseguenze, né l’intenzione autentica che genera ogni momento, pur sapendo che solo per il fatto di starlo a guardare, come gli elettroni nell’orbitale, qualcosa di quel flusso perfetto e continuo verrà interrotto.
Il fotografo per antonomasia ruba e cerca, trova e cattura. Che diritto ha il fotografo, in fondo, di turbare l’universo? In sintesi, la questione è da sempre solo questa.
Il fotografo entra nel secolo in un modo molto diverso, scoprendo di poter incidere la propria visione del mondo chiedendo alle persone di stare ferme per lui.
Proprio lui che all’universo è legato a doppia mandata per poter esistere, e senza il quale non potrebbe raccontare nulla, si è inserito come un virus nel sistema degli accadimenti per poterli manovrare e riconsegnare secondo una lettura propria e a volte, paradossalmente, più efficace di quanto potesse essere registrato senza alcun intervento, in grado di dar forma a una precisa visione di un mondo e di un popolo. Si pensi a Robert Doisneau, per esempio, al nitido immaginario della Parigi del secondo dopoguerra cui spesso si torna mentalmente pensando alla Francia di quegli anni: non solo per i limiti critici dello spettatore straniero, ma per evidente limpidezza argomentativa ci si trova imbrigliati in quelle immagini per trovare un significato di un’epoca e di un luogo. Molto spesso tutto costruito, però. Attori e amici guidati perfettamente per inscenare il teatro umano che Doisneau sicuramente sentiva vero e vivido nel proprio percepire il mondo che lo circondava, senza dover per questo rinunciare a imbastirne la riproduzione che, a sua volta, non può che finire per diventarne il simbolo permettendo di costruire una personale, e ancor più generale idea.
Il tema soggiacente, allora, allo scontro ideologico tra i fotografi, sembra appartenere al regno della fedeltà, alla parola d’onore che si è data al mondo nel momento in cui ci si è proposti di raccontarlo attraverso i propri occhi.
Questo fu il motivo di rottura definitiva tra il fotografo francese e il suo allora assistente Gianni Berengo Gardin, insofferente di fronte a tanta artificiosa falsità, alla bugia – effettivamente – su cui si fondava l’affabulazione visiva di Doisneau. Il tema soggiacente, allora, allo scontro ideologico tra i fotografi, sembra appartenere al regno della fedeltà, alla parola d’onore che si è data al mondo nel momento in cui ci si è proposti di raccontarlo attraverso i propri occhi; e allo stesso tempo sembra voler confermare una sorta di inconscia fede nei confronti di quanto nel mondo possa essere fotografato senza imporre il volere di nessuno. E così, nel momento in cui qualcuno devia da questa strada, certi fotografi si sentono di fronte alla rottura di un patto sacro che altri non hanno avuto la tenacia di mantenere saldo, facendo prevalere una volontà totalmente innecessaria – e nociva, anche – per rivelare il senso del vivere degli uomini. Quanti dibattiti intorno all’immagine del Miliziano morente di Robert Capa, scattata nel 1936, su cui ancora oggi persistono i dubbi di chi ci vede, insoddisfatto e deluso, una messa in posa, da un lato, e la testimonianza che addirittura Capa scattò quella foto senza guardare, alzando la macchina fotografica sopra di sé tenendosi il più possibile nascosto dai proiettili. Al di là della verità rispetto alla genesi di questa immagine, sapere che proprio quella più controversa dell’archivio del reporter è diventata l’icona esemplare della guerra civile spagnola porta a riflettere sul sentimento che suscita saperla colta all’improvviso o studiata a tavolino: sembra che certe verità debbano nascere da sole per trovare dignità, come Gesù in una nube luminosa, e il fotografo essere una puerpera senza doglie. Allo stesso tempo in un caso o nell’altro viene decentrato il concetto stesso di memoria, termine che giustifica moltissima produzione fotografica. Che tipo di ricordo può generare una scena costruita a tavolino, non essendo legata a un discorso storico, a un prima e a un dopo, e non essendo più causa di nessun effetto, effetto di nessuna causa?

“La fotografia è una realtà nuova, non è la realtà. È la realtà dell’immagine. La realtà esiste nel vivere, nella sua temperatura, nella percorrenza” mi disse Italo Zannier al telefono qualche tempo fa, giungendo alla mirabile conclusione secondo cui la fotografia, più che documentare, trovi il proprio più alto fine nel segnalare, ovvero nel sollevare dalla superficie del reale quello strato – o, come lo definì Honoré de Balzac, quello “spettro” – che più di altri può arrivare a rivelare qualcosa, per darlo a chi vorrà guardare. Così, tutta la dignità di una fotografia parrebbe risiedere nel suo restituire in ogni caso un’idea di mondo reinventato, e va forse individuata in questo senso la sua più riuscita forma di realismo; nel soccombere sempre a una realtà più grande, estesa oltre i confini dell’inquadratura e della semplice comprensione dell’uomo. In questo senso anche il più fedele documento fotografico potrà apparire l’illusione di un mondo che, qualora sia davvero avvenuto, vederlo nel ritaglio squadrato di un’immagine non può che darci il barlume di quanto di ben più complesso non è stato possibile rinchiudervi. Gli occhi devono accontentarsi. Per questo, forse, alcuni fotoreporter contemporanei (penso a Massimo Berruti, Massimo Mastrorillo, per esempio) parlano sempre più di “metafora” e di “significati simbolici” come meta del proprio sguardo e del proprio lavoro, come cercando varchi inesplorati là dove anche il dato evidente può fallire nel soddisfare la voglia di conoscenza. Come se, depositata oltre la superficie delle cose, possa trovarsi la possibilità di evocare i fantasmi al di là dei volti degli uomini – e penso anche a Paolo Pellegrin. Il fotografo tende ora a una nuova forma di coraggio, quella che gli permetta di oltrepassare un nuovo confine per raccontare il mondo, e prima ancora per dargli “un senso e una forma” (Pellegrin). La realtà, allora, più che mentre avviene andrà colta mentre appare; e rappresentarla sarà sempre un validissimo artificio.