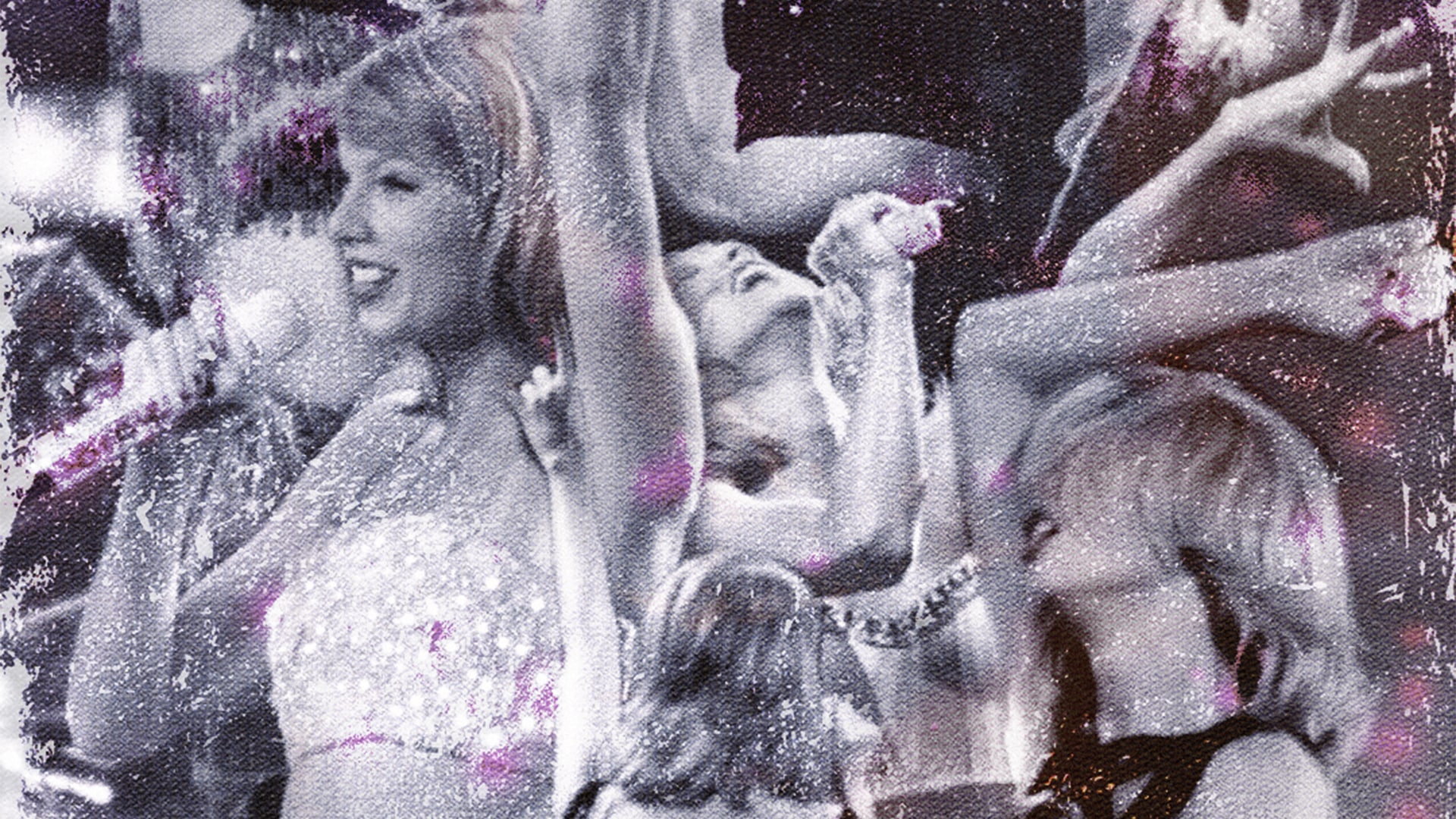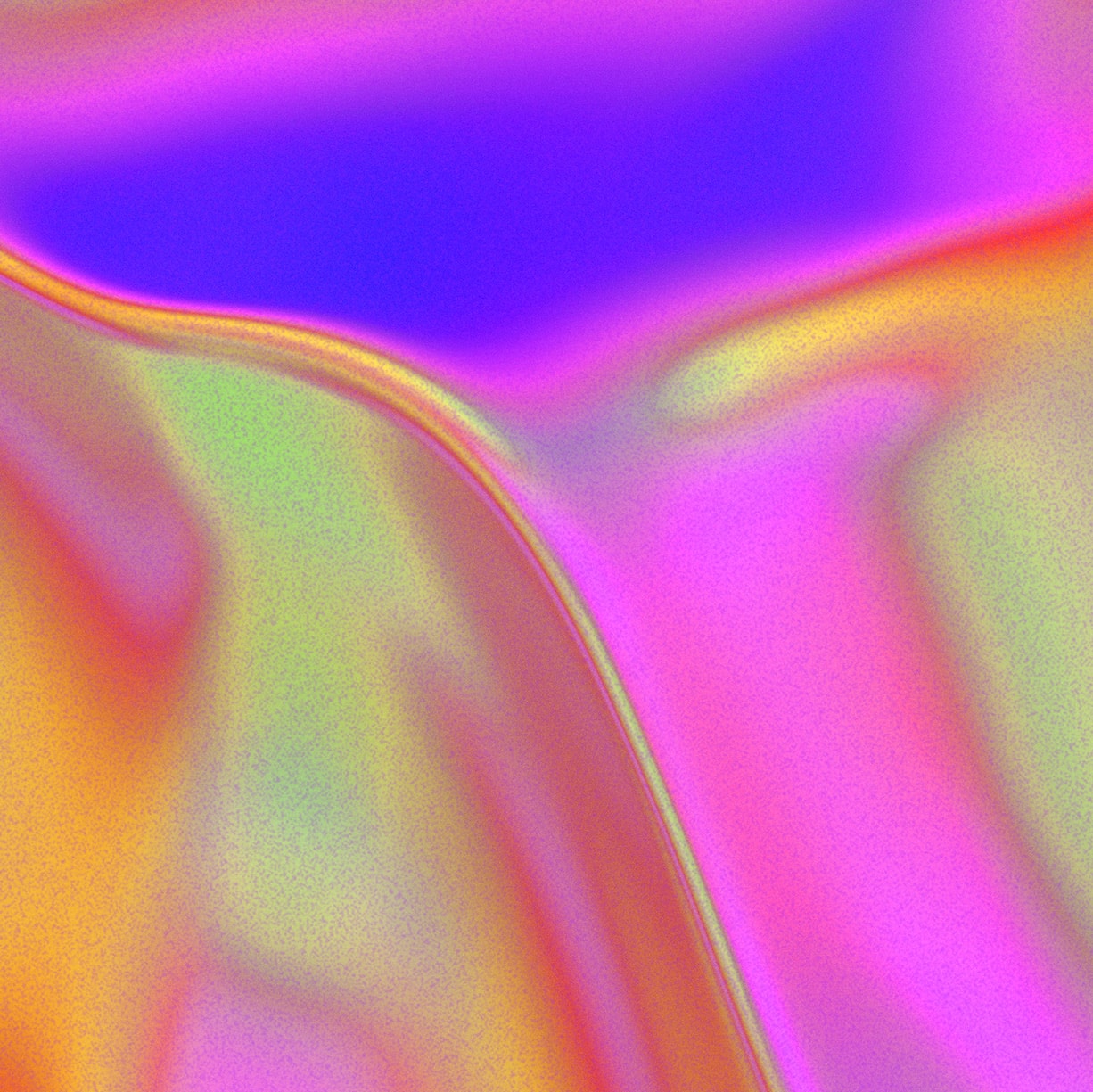Grandi Dimissioni Italiane?16 min read
Siamomine x Smart
Grandi Dimissioni Italiane?
Intervista a Francesca Coin sul nuovo rifiuto del lavoro, sulle contraddizioni, sulla narrazione e sul dibattito italiano del fenomeno mondiale
Intervistato da Bloomberg nel 2021, Anthony Klotz, psicologo del Lavoro allo University College di Londra, conia il termine Great resignation per indicare la tendenza che in quella fase di piena pandemia stava prendendo piede negli Stati Uniti. Secondo lo studioso le ragioni che spingevano le persone a dimettersi volontariamente erano molteplici, dall’esaurimento dilagante nei luoghi di lavoro all’emergere di “domande esistenziali” che molti statunitensi si stavano ponendo rispetto alla qualità del proprio tempo e al valore dato alla propria esistenza. In quell’anno 48 milioni di persone nel paese hanno lasciato il proprio lavoro (su un totale di 166 milioni di persone occupate, secondo le statistiche governative). L’anno successivo le grandi dimissioni hanno interessato più di 50 milioni di lavoratori.
Capire le ragioni dei quitters aiuta a riflettere sui mutamenti che interessano la percezione del lavoro. “Con la forza del proprio gesto di sottrazione”, scrive la sociologa Francesca Coin, “sono riusciti ad accendere i riflettori sul mondo del lavoro e a porre all’ordine del giorno una discussione che è stata per lungo tempo rimandata”. Coin, prima professoressa associata nel dipartimento di Sociologia all’Università di Lancaster, nel Regno Unito, e ora al Centro di competenze lavoro e welfare, società della SUPSI, in Svizzera, analizza il fenomeno nel suo libro “Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita”, pubblicato da Einaudi nel 2023.
L’autrice non si limita ad ammettere che “il nuovo rifiuto del lavoro è un fenomeno ambivalente e contraddittorio”, ma tenta di analizzare le motivazioni che inducono una certa stampa a interpretare la tendenza unicamente come la scelta privilegiata di chi può permettersi di mollare tutto per inseguire i propri sogni, se non quando una chiara dimostrazione della svogliatezza dilagante tra le nuove generazioni.
Un processo di disaffezione al lavoro
Le tendenze attuali non possono essere comprese senza fare un passo indietro, all’inizio del XX secolo: per contrastare alti tassi di turnover e assenteismo si mette a punto un regime salariale fondato sulla grande fabbrica, prendendo a esempio le innovazioni introdotte nel 1914 da Henry Ford nella sua fabbrica automobilistica, in primis il raddoppiamento dei salari e la riduzione dell’orario di lavoro a otto ore al giorno.
Un sistema che entrerà in crisi negli anni Settanta e Ottanta, in cui sarà inaugurata quella che nel libro viene descritta come l’epoca dell’infedeltà, caratterizzata da un’economia terziarizzata basata su rapporti di lavoro individuali e precari. La fedeltà in realtà persiste, ma è unilaterale: “I dipendenti devono dimostrare devozione al lavoro, mentre le aziende possono assumerli per licenziarli quando vogliono, in una relazione usa e getta”, scrive Coin.
Ma quali sono le peculiarità del caso italiano, che si piazza al primo posto in Europa per numero di lavoratori autonomi? Qual è la narrativa che domina nel nostro paese, alla luce di una diffusa erosione delle tutele e dell’alto tasso di disoccupazione?
Indagando il caso italiano, l’autrice raccoglie una lunga serie di dati che riguardano i settori a saldo negativo, dove le ricollocazioni verso altri settori superano quelle in entrata: commercio e ristorazione, ma anche sanità e lavoro di cura. Ma il libro si arricchisce anche di testimonianze dirette che offrono un quadro ampio e variegato sulla precarizzazione che interessa il nostro paese. Oltre a dimostrare come il fenomeno sia trasversale, le dimissioni volontarie si configurano come l’atto conclusivo di un processo di disaffezione al lavoro su cui la crisi pandemica ha esercitato un influsso determinante.
Come si legge nel capitolo sesto, tra le cause di questa disaffezione figura il cosiddetto “grande disallineamento”, tra “ciò che i leader aziendali considerano importante e ciò che invece è importante per chi lavora”. Malgrado sia difficile fare un discorso unitario sulle grandi dimissioni, è chiaro che il fenomeno è il sintomo collettivo di una crisi del modello produttivo attuale.
Ma quali sono le peculiarità del caso italiano, che si piazza al primo posto in Europa per numero di lavoratori autonomi? Qual è la narrativa che domina nel nostro paese, alla luce di una diffusa erosione delle tutele e dell’alto tasso di disoccupazione? Abbiamo rivolto alcune domande all’autrice.
Nel capitolo tre, dedicato all’Italia, scrivi che nel nostro paese il discorso sulle grandi dimissioni è stato per lungo tempo “incentrato sulle tonalità emotive dell’incredulità” delle aziende, incapaci di comprendere il perché le persone si licenzino. In generale, la mia personale percezione è che la narrativa in Italia rispetto alle relazioni di lavoro sia imbevuta di una sorta di paternalismo. Di fronte all’emergere di un “disallineamento valoriale”, come scrivi citando un articolo del Financial Times, le vecchie generazioni tentano di imporre ai più giovani un pacchetto di regole, impulsi e suggerimenti che si basano sulle loro esperienze pregresse, ad oggi non replicabili nelle stesse forme.
Il dibattito su questo tema in Italia è stato a lungo incentrato sulle tonalità emotive dell’incredulità. L’idea di fondo è che avere un lavoro è un privilegio e per questo privilegio bisogna dire grazie, indipendentemente dalle condizioni effettive in cui ci si trova a lavorare. C’è una sostanziale differenza tra il lavoro cui è stata educata la generazione cresciuta nel boom economico e quello odierno. Un tempo il lavoro di una sola persona poteva provvedere alle esigenze riproduttive di un intero nucleo familiare. In molte famiglie il lavoro retribuito del solo breadwinner consentiva di comprare casa e di mantenere la famiglia.
La situazione attuale è contraddistinta dalla riduzione dei redditi, dalla precarizzazione e dal deterioramento della qualità del lavoro. In questa situazione, si fatica a far fronte al costo della vita anche quando all’interno dello stesso nucleo familiare lavorano più persone. Eppure, nel nostro immaginario il lavoro è lo stesso dell’epoca fordista. In questo senso, l’incredulità nasce dall’idea errata che il lavoro sia ancora ben retribuito e tutelato e che lasciarlo sia un grosso rischio.
Questo anche perché, in molti casi, gli editorialisti sono uomini della vecchia generazione il cui immaginario è fortemente segnato da ciò che il lavoro era in epoca fordista. In realtà, oggi, anche lavorare è rischioso, perché il lavoro povero rende così poco che, spesso, impedisce anche a chi ha un impiego di far fronte al costo della vita, di pagare le bollette e l’affitto. Non a caso tra i percettori di reddito di cittadinanza c’erano anche persone con una posizione lavorativa attiva il cui salario era così basso da costringerle a rimanere sotto la soglia della povertà nonostante il lavoro. In questo contesto, il tema delle grandi dimissioni non dovrebbe generare sorpresa né incredulità: quando il lavoro rende poco, chi lo lascia avrà poco da perdere.
L’anomalia italiana
Si potrebbe dire che il dibattito paternalistico presente in Italia sia legato a doppio filo al fatto che il nostro è un paese di paesi, e conta una fitta rete di “fabbrichette”, di micro imprese quindi, in cui sfuma il conflitto tra domanda e offerta? Le relazioni informali che questi luoghi offrono, in cui si intrecciano legami lavorativi e familiari, pesano sulle condizioni interne?
Credo che sia un dato significativo soprattutto per quanto riguarda la cultura del lavoro. Se andiamo a guardare le piccole e micro imprese italiane, molto spesso l’approccio si struttura attorno al “qui è mio e si fa come dico io”, che è in tutto e per tutto rappresentazione di una cultura padronale. È interessante notare anche come il termine “padrone” sia scomparso dal dibattito pubblico da diverso tempo. Eppure, dal portato lavorativo che molte persone hanno condiviso è emerso che non è affatto infrequente che il problema principale sia proprio questa figura. Che secondo il mio parere ricorda molto quel libro di Goffredo Parise, Il padrone, in cui il protagonista è di fatto il proprietario della vita del dipendente, che sarà tenuto a seguirne gli ordini nella vita lavorativa e privata sino a sposare la donna che il padrone gli chiede di sposare, per ripagarlo della sua grande generosità. È un libro fortemente respingente, quello di Parise, e al contempo illuminante, proprio perché si ravvisano analogie con la cultura del lavoro che si respira in alcune aziende, in cui l’unica regola è l’autorità datoriale.
In generale, nei luoghi di lavoro in cui si registra molto lavoro nero, come la ristorazione e il commercio, dove ci sono esternalizzazioni e appalti, non è raro che la democrazia sia assente. Non è raro nemmeno che la cultura padronale si innesti sullo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori che non vengono riconosciuti a pieno titolo come soggetti di diritto. La discriminazione delle donne, delle persone razzializzate e LGBTQ+ è uno degli esiti piu frequenti di tutto questo.
Si potrebbe dire che è più difficile dimettersi dai luoghi di lavoro interessati da questa sovrapposizione di problematiche e discriminazioni?
Non ne sono sicura. Il ventaglio di cause che portano le persone ad andarsene è molto variegato ed è difficile generalizzare. Prendiamo il caso di un’attività del commercio o della ristorazione e di persone per cui il proprio lavoro rappresenta l’unica fonte di reddito per un’intera famiglia: queste persone tenteranno di resistere il più possibile, prima di decidere di andarsene. Nello stesso tempo, un o una trentenne che non ha famiglia a carico potrebbe decidere di mollare dopo poche settimane, se si trova nella stessa condizione. Le situazioni sono così diverse che spesso è difficile generalizzare.
Nei mesi in cui ho raccolto interviste per il libro mi sono imbattuta in storie di persone impossibilitate a mollare il lavoro perché la loro condizione personale in quel momento non lo consentiva e altre che l’hanno fatto lo stesso. Dipende. Di sicuro un lavoro a basso reddito al cui interno vi sono chiare condizioni di sfruttamento faticherà a trattenere i lavoratori e ad attrarne di nuovi, esattamente per quello che dicevamo prima: perché la contropartita che il lavoro offre è insufficiente. Credo che dovremmo guardare alle dimissioni come al sintomo di un modello produttivo in cui le condizioni di lavoro si sono deteriorate a tal punto da essere usuranti: sono queste condizioni che vanno cambiate.
Il titolo del capitolo 3, “L’anomalia italiana”, fa riferimento al fatto che le dimissioni volontarie aumentano malgrado l’elevato tasso di disoccupazione. Un’altra eccezione è che l’Italia è al primo posto tra i paesi europei per numero di lavoratori autonomi: secondo i dati OECD sono oltre 5 milioni, più del 20% delle persone occupate. La media europea è del 14,5%. Come interpretare questi numeri? Indicano una consequenzialità dell’elevato tasso di dimissioni volontarie o sono una caratteristica della stessa tendenza di erosione delle tutele, esternalizzazione dei servizi eccetera?
Non so se c’è una consequenzialità: ci sono sicuramente persone attratte dal lavoro autonomo perché pensano che questo consenta maggiori libertà, esattamente come ci sono persone che decidono di lasciare un lavoro autonomo per il lavoro dipendente perché credono che quello sia più tutelato. L’associazione dei freelance Acta e il gruppo di loro soci legati al settore dell’editoria libraria RedActa fa un lavoro prezioso che consente di comprendere proprio le esigenze e gli immaginari del lavoro autonomo, in una fase in cui anche questo è spesso povero. Purtroppo, spesso nei luoghi di lavoro la crescita del lavoro autonomo è anche un esito del disimpegno aziendale, che fa sì che diverse aziende si servano di finte partite Iva che svolgono ruoli subordinati a tutti gli effetti eterodiretti e in forma di monocommittenza pur senza godere di alcuna delle tutele del lavoro dipendente.
Al di là dalle scelte individuali, il problema di fondo è che nel mercato del lavoro i diritti sono stati presi d’assalto e il rischio d’impresa è stato trasferito dalle aziende ai lavoratori e alle lavoratrici, in un processo che ha reso il lavoro stesso insostenibile.
Nel libro citi alcuni dei neologismi che negli ultimi anni in Cina hanno raccontato la crescente disaffezione dei giovani nei confronti del lavoro, nati anche come una reazione alle chiamate fatte dal Partito comunista nei confronti delle nuove generazioni, a cui viene chiesto di mobilitarsi per la ripresa nazionale. Ma come riflettono Diego Gullotta e Lin Lili in un saggio uscito anche nella rivista Made in China Journal, questi movimenti di opinione non sono riusciti a raggiungere una profondità tale da disarticolare il discorso dominante orientato al mercato. Secondo te il fenomeno delle grandi dimissioni, in Italia perlomeno, può avere la capacità di disarticolare le dinamiche attuali e porre le basi per una risposta collettiva?
Il dibattito sulle grandi dimissioni conduce spesso a reazioni di diffidenza, ma se lo guardiamo con attenzione, si configura come uno dei sintomi più importanti della crisi del modello produttivo post-fordista: quello che per quarant’anni ha puntato a spremere le risorse, tagliare all’osso gli organici, aumentare i turni di lavoro e assaltare i diritti, sotto l’egida della precarizzazione e della esternalizzazione.
La globalizzazione ci aveva assicurato che i nostri sacrifici sarebbero stati ricompensati e che tutti avremmo sperimentato un certo miglioramento nelle condizioni di vita. Invece la globalizzazione ha portato a enormi diseguaglianze sociali, dentro e tra i paesi, una qualità del lavoro deteriorata, burnout e insoddisfazione.
Persino in Cina, il rallentamento della crescita economica ha portato a crescenti critiche al modello produttivo esistente. Che senso ha investire negli studi e fare tanti sacrifici se poi il mercato ti premia con la disoccupazione e la povertà, si chiedono i neolaureati?
Le promesse neoliberali sono in crisi in luoghi diversi del mondo, dove non a caso le dimissioni volontarie si accompagnano a una critica sempre più aspra al modello produttivo e alla ripresa dei processi di organizzazione autonoma del lavoro. È questa l’unica vera uscita collettiva dal contesto di crisi in cui ci troviamo.