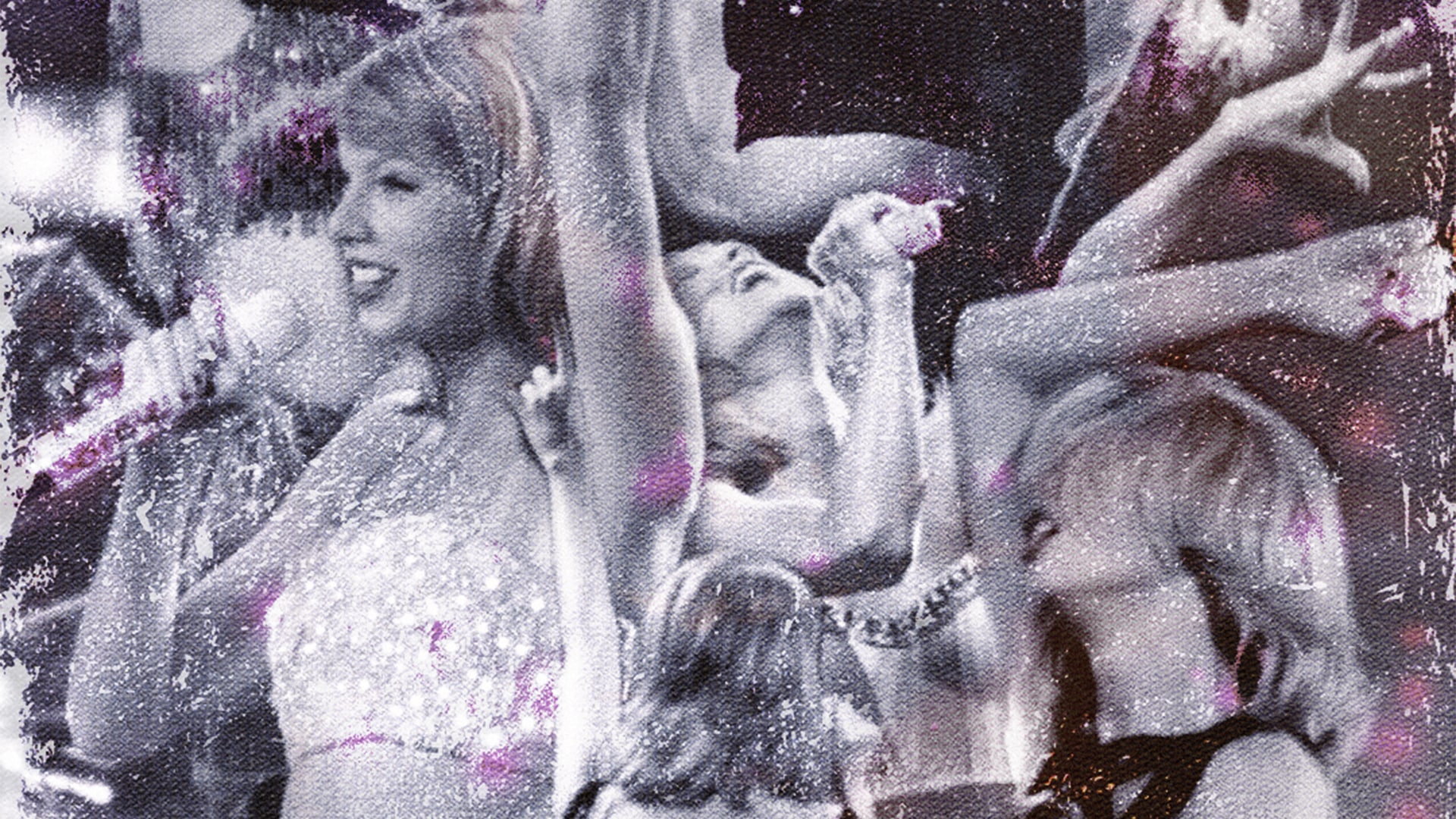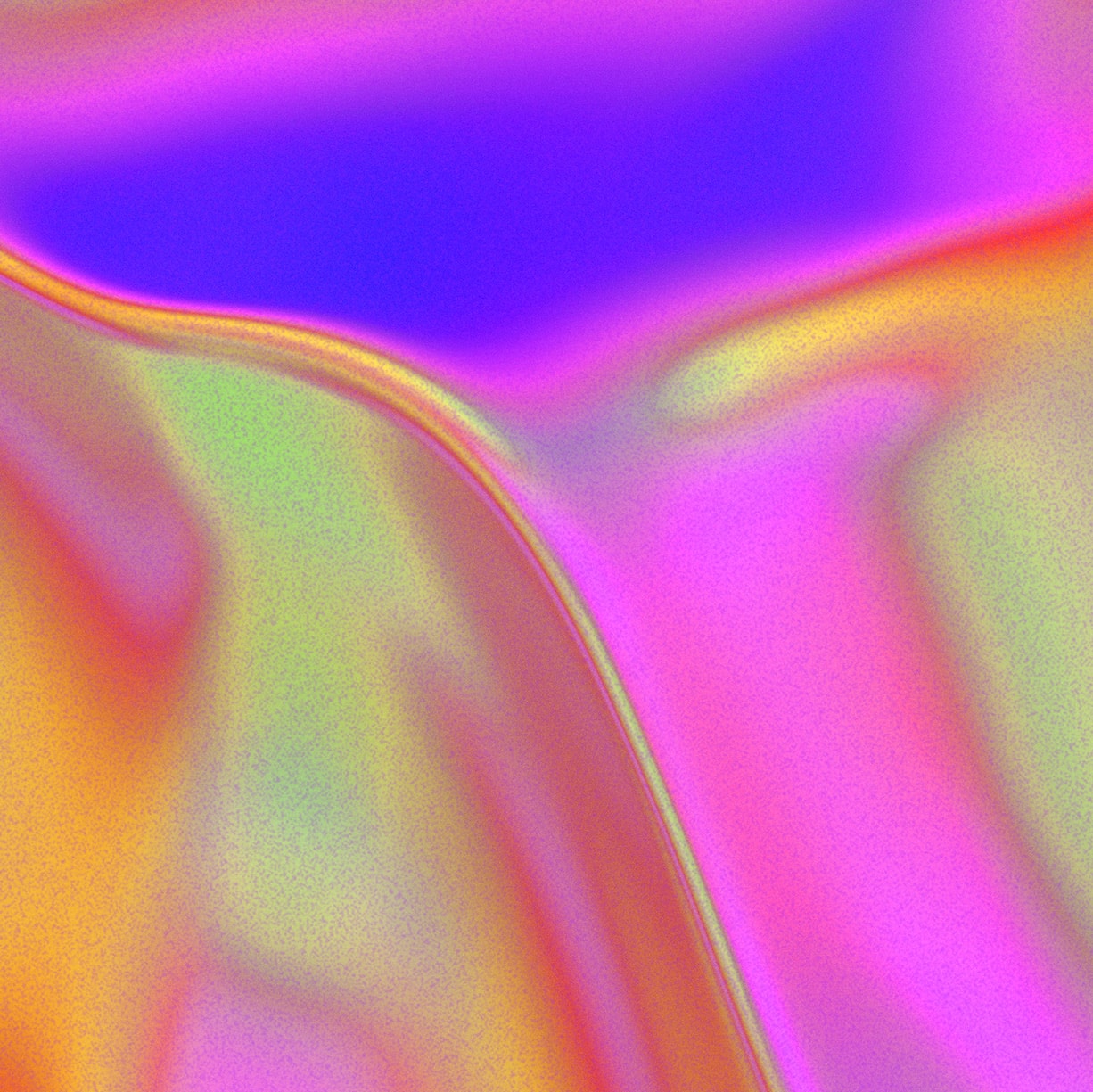Come si racconta la fine del mondo?18 min read
Come si racconta la fine del mondo?
Una conversazione con Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi, autori della newsletter Medusa e dell’omonimo libro che racconta l’antropocene, la pandemia, il capitalismo e le storie che germogliano tra gli interstizi della catastrofe ambientale.
Vivo in prossimità del quartiere di Roma che incarna al meglio l’idea di scenario post-apocalittico che riesco a immaginare. Non a caso è stato scelto per ambientare L’ultimo uomo della terra, film fantascientifico del 1964 diretto da Ubaldo Ragona, tornato in auge durante il periodo di lockdown rigido della pandemia, quando internet esplodeva di liste di cose da guardare in streaming.
Sto parlando dell’EUR, un’area pressoché paludosa a sud della Capitale scelta durante il ventennio fascista per ospitare l’Esposizione universale del 1942, che per ovvie ragioni non si è tenuta. Il progetto EUR è rimasto incompiuto e abbandonato per vari decenni nel bel mezzo del Novecento, come lo scheletro di una città del futuro abbandonata nel deserto. Oggi è uno dei poli dell’opulenza romana – uffici privati, grattacieli, sale congressi, SUV in doppia fila, immensi centri commerciali, superattici di calciatori dell’AS Roma – ma mantiene vivida l’atmosfera da luogo artificiale, di civiltà trapiantata su un pianeta alieno.
Se penso alla catastrofe ambientale, penso ai grattacieli dell’EUR, penso ai campi da padel che sbucano come funghi e agli yuppies romani che giocano sotto a un cielo infuocato, nei rari momenti di tregua tra un cataclisma e l’altro, penso alla fetta di popolazione ricca del pianeta che cerca di mantenere privilegi come l’aria condizionata, cibo geneticamente modificato o acqua piovana depurata, mentre tutto il resto dell’umanità costretto a sopravvivere nelle fogne.
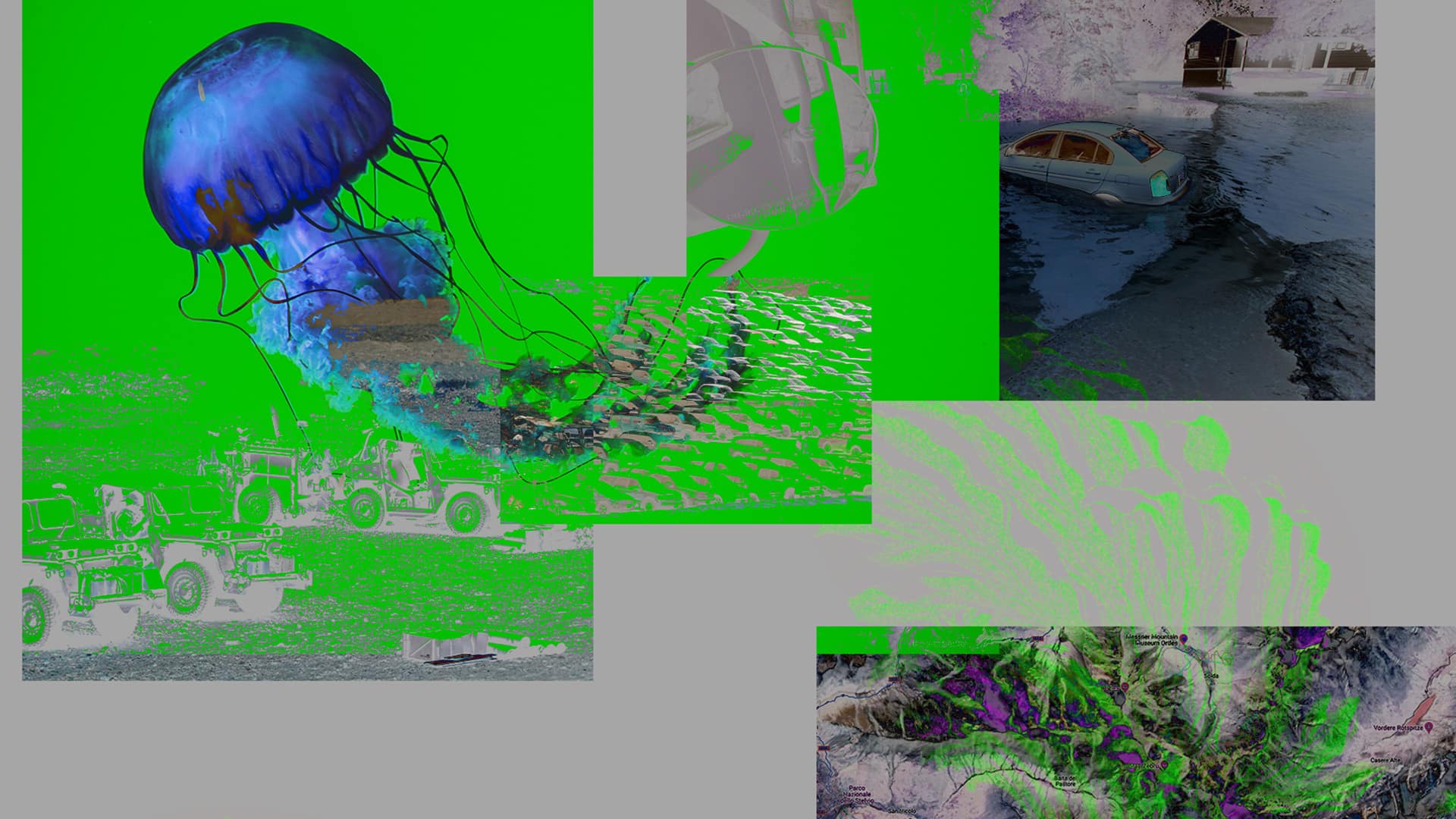
Medusa è una newsletter che parla di antropocene, racconta le “storie dalla fine del mondo”, è curata da Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi ed è nata quattro anni fa, quindi un lasso di tempo che sembra un’eternità prima della pandemia. È un progetto che in questi anni è cresciuto insieme all’interesse di una generazione di lettrici e di lettori per l’ecologia e l’ambiente, più in generale per nuove forme di attivismo politico che convergono su questi temi, ha intercettato in pieno il successo delle newsletter come strumento di informazione ed è costruita su un linguaggio e una cura dei contenuti che la rendono un caso unico, con un piglio che mescola la divulgazione scientifica e il reportage, a uno storytelling da personal essays ad alto contenuto culturale, letterario, cinematografico.
È appena uscito un libro per NERO Editions in cui il format di Medusa vive sulla carta con nuovi contenuti inediti e paralleli a quelli che arrivano nella casella di posta. È fatto di storie e analisi che a mio modo di vedere tirano le somme del lavoro fatto questi anni e fotografano questo periodo di quasi-post-pandemia, mettendo in ordine quello che è successo mentre si tenta di chiedersi cosa succederà a stretto giro o più in là. Abbiamo fatto qualche domanda ai due autori.
Partivamo da letture come Timothy Morton o Donna Haraway, che nel tempo abbiamo imparato a mettere in prospettiva, problematizzare, mentre prima magari li citavamo in maniera troppo reverenziale. Ci siamo un po’ anche radicalizzati con il tempo, perché quando parli di cambiamenti climatici non puoi non parlare dei modi in cui i sistemi economici e politici hanno portato alla crisi ambientale.
Il primo numero di Medusa è uscito quattro anni fa. Quanto vi siete allontanati oggi dalle intenzioni che vi hanno spinto a iniziare, o meglio, quanto è cambiata attorno la realtà e il modo di raccontare l’antropocene?
NP: Se quattro anni fa mi avessero detto che nel 2021 le nuove generazioni avrebbero dimostrato questa consapevolezza intorno all’emergenza climatica, sarei rimasto sorpreso. Ovviamente avendo vissuto questi passaggi su scala quotidiana, gradualmente, oggi mi sembra tutto nella norma; si è trattato soprattutto di adeguarsi e recuperare quello che già si diceva e faceva in altri Paesi.
Una parte del nostro lavoro, quattro anni fa, era puramente divulgativa: molti lettori sentivano parlare di Antropocene per la prima volta, si sentivano dire finalmente quanto i dati sul riscaldamento globale fossero fondati, insomma, che c’era da preoccuparsi e da informarsi. Negli ultimi due anni circa lo scenario si è trasformato, oggi parliamo a persone che spesso frequentano già questi argomenti, e con un’opinione formata. È cambiato il mondo, insomma. Abbiamo sempre mescolato la divulgazione classica alle meta-riflessioni sulla nostra materia, ma forse negli ultimi tempi ci stiamo permettendo qualche libertà in più. In fondo MEDUSA, per noi, è un laboratorio di scrittura, un’officina… Oggi, come quattro anni fa, divulgazione e scrittura – come ricerca stilistica, d’arte – non sono scindibili dal nostro punto di vista.
MDG: È vero, all’inizio una delle spinte che ci ha portato ad aprire la newsletter è stato il fatto che, da lettori, soffrivamo la mancanza in Italia di un discorso culturale attorno alla crisi climatica, al rapporto e il conflitto tra esseri umani e natura, all’antropocene e così via… C’era molta buona divulgazione scientifica, ma era spesso didascalica, didattica. Utile, ma non il tipo di cosa che avremmo voluto leggere. Ora non è più così, è cambiato tutto in pochissimo tempo, c’è molto più interesse e va dal mainstream alle controculture, e credo sia in gran parte merito dei nuovi movimenti ambientalisti. Oggi finalmente anche i grandi giornali hanno iniziato a parlare di crisi climatica, dopo decenni di enorme distrazione, e ci sono libri di tutti i tipi sul tema, riflessioni e approcci diversi. Il rovescio della medaglia è ovviamente che l’ambientalismo è ormai un tema di cui non si può più non parlare, e così in varie sue forme e sottoprodotti è diventato anche una veste per riempire contenuti, una scusa, una moda.
Per quanto riguarda noi, abbiamo aperto la newsletter proprio per darci il tempo di capire come e cosa scrivere in un libro. Se avessimo pubblicato un libro subito, quattro anni fa, sarebbe stato completamente diverso, e lo vedi forse anche dai primi numeri della newsletter, sarebbe stato molto più ricco di spiegazioni scientifiche e pagine divulgative, come diceva Nicolò, perché in quel momento ci sentivamo quasi in obbligo di dover scrivere quelle cose per introdurre i temi, e sono pagine che oggi possono essere date quasi per scontate perché molte di quelle cose sono entrate, appunto, nella vita e nella consapevolezza di tutti.
Far decantare le cose che scrivevamo è stato importante, comunque, anche perché negli anni abbiamo cambiato riferimenti e punti di vista… Partivamo da letture come Timothy Morton o Donna Haraway, che nel tempo abbiamo imparato a mettere in prospettiva, problematizzare, mentre prima magari li citavamo in maniera troppo reverenziale. Ci siamo un po’ anche radicalizzati con il tempo, perché quando parli di cambiamenti climatici non puoi non parlare dei modi in cui i sistemi economici e politici hanno portato alla crisi ambientale. Tutte queste cose hanno lasciato una traccia, il libro che alla fine abbiamo scritto è una sorta di intricata bava di lumaca lasciata lungo questo percorso. In Medusa partiamo dalla pandemia, che ci ha ricordato in maniera brutale quanto siamo connessi con il mondo naturale, il non umano, e poi raccontiamo i limiti cognitivi che ci impediscono di recepire un messaggio di allarme così imponente come quello della crisi ambientale, cerchiamo di capire se c’è una narrazione politica e divulgativa che può funzionare meglio delle altre, perché l’allarmismo – dicono gli scienziati – non funziona più, non ha mai funzionato. C’è un capitolo in cui parliamo esplicitamente di letteratura ed ecologia, anche se letteratura e romanzi scorrono sottotraccia per tutto il libro. E poi cerchiamo di raccontare le questioni politiche, i negazionismi, e anche le questioni di salute mentale, legate sempre alla crisi climatica, la depressione da fine del mondo. Sono tutte riflessioni, storie, modi di scrivere che abbiamo accumulato in questi quattro anni durante i quali, appunto, nel frattempo la realtà attorno a noi cambiava in maniera molto veloce.
NP: Sì, oggi non sentiamo più l’esigenza di ripetere basi già ben piantate (un esempio a caso: cinquemila battute sulla storia dell’effetto serra), sentirci come un vecchio crooner che fa, non so, il pezzo sui ghiacciai… Ribadire ogni volta gli stessi concetti rischia di logorare sia noi che chi ci ascolta. Siamo arrivati a un punto in cui possiamo declinare il discorso in diverse forme.
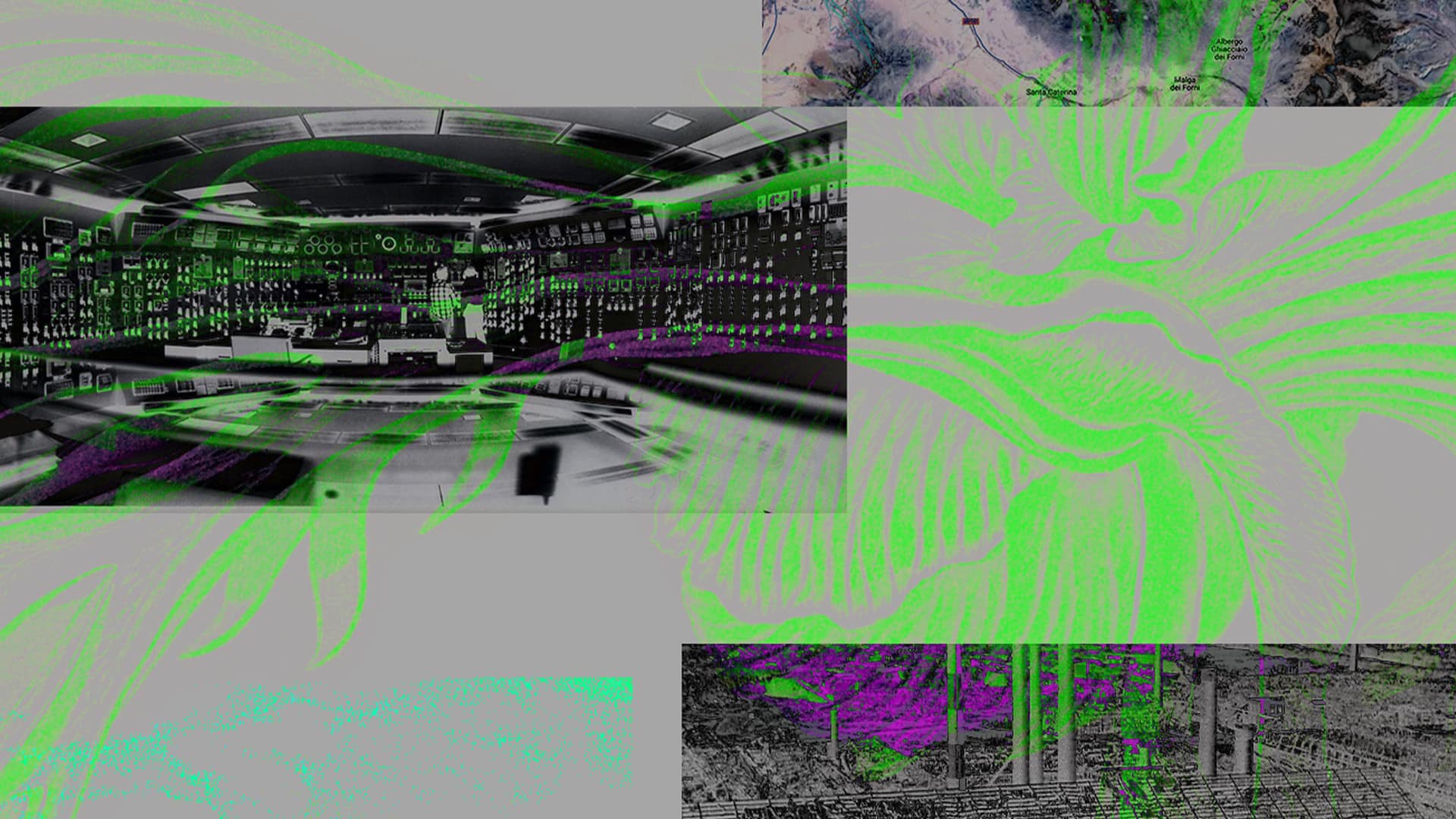
Il vostro sforzo culturale e intellettuale rende il vostro lavoro secondo me peculiare e molto diverso dallo standard con cui si parla di crisi climatica. Questa cosa come viene recepita? Viene sempre compresa dal pubblico?
MDG: Non abbiamo scritto questo libro come un manifesto politico, non avevamo nessun fine o intento programmatico. Al tempo stesso è chiaro che scrivere di crisi climatica, come ti dicevo, ti avvicina all’attivismo. È inevitabile forse. A questo punto però la domanda diventa: se ti consideri uno scrittore, ti puoi davvero avvicinare a temi “impegnati” e rimanere uno scrittore, senza diventare altro, senza fare la predica? Questa è una delle domande che ci facciamo nel libro, soprattutto quando parliamo di letteratura e crisi climatica, perché solitamente diffidiamo dei romanzi che voglio essere “romanzi buoni”, che vogliono occuparsi di temi “sensibili” con slancio civico, perché finiscono spesso per essere cattiva letteratura. Questo non vuol dire, ovviamente, che la letteratura non possa avere un rapporto etico con la realtà, ma solo che quello non deve essere l’unico ruolo che le si dà. Poi il nostro libro a conti fatti è un saggio narrativo, non un romanzo, e quindi ha codici e linguaggi diversi rispetto alla pura letteratura. Ma anche così non volevamo comunque scrivere un libro “apostolico”. Mi sembra che alla fine il modo che abbiamo trovato, inconsciamente, sia quello coltivare il dubbio. Medusa è un libro pieno di domande e di dubbi. Non abbiamo nessuna sicurezza da vendere, davanti a delle questioni così complesse.
NP: È vero che coltiviamo il dubbio a ogni pagina, ma non ci tiriamo indietro quando c’è da mettere il punto su qualche certezza. La scienza è una macchina di conoscenza che ha dei limiti umani, perché l’hanno costruita gli esseri umani; i fenomeni fisici però restano reali, le leggi della termodinamica non sono materia d’opinione.
Su Siamomine ma anche sul Tascabile abbiamo parlato di come vive sui social l’attivismo, che negli ultimi anni ha preso uno spazio molto rilevante e se ne sta dibattendo molto, si discute degli eventuali limiti o contraddizioni. L’attivismo ambientale è ovviamente tra questi e riguarda soprattutto la Gen Z, avete un’opinione al riguardo?
MDG: Noi siamo “millennials” e forse quindi paradossalmente già troppo vecchi, in più abbiamo questa polvere novecentesca addosso per cui se potessimo chiudere qualsiasi canale social lo faremmo immediatamente. Al tempo stesso però seguiamo con interesse questo tipo di dinamiche dall’esterno. Quindi anche se non è il mio campo, provo a risponderti: devo dire che in generale mi trovo istintivamente d’accordo con quelle critiche all’attivismo social che lo dipingono come un detonatore di meccanismi narcisistici e individualistici, perché tutto è incentrato sulla definizione del sé, si finisce per curare la propria pagina Facebook, Twitter o Instagram come una vetrina per mostrare al mondo chi siamo davvero o almeno chi vorremmo essere. Ed è un meccanismo che paradossalmente, nonostante nasca nelle reti sociali, invece di portare alla costruzione di comunità (cosa che comunque spesso fa) può portare a microbattaglie identitarie all’interno di quelle che invece potrebbero essere comunità più ampie…
Spesso però chi fa questo tipo di discorsi aggiunge a questo punto che l’attivismo social è da condannare anche perché semplifica troppo i messaggi, che poi è la stessa accusa che viene lanciata contro le ragazze e i ragazzi che scendono in piazza per il clima, a cui si rimprovera di essere troppo utopistici o banali o sempliciotti. E qui non sono più d’accordo. Perché non credo che la semplificazione sia necessariamente un male, nella comunicazione politica. La semplificazione nel messaggio è sempre esistita, e risponde alle caratteristiche del nostro cervello, al modo in cui elaboriamo la realtà, abbiamo bisogno di un messaggio che sia semplice. C’è un libro che racconta molto bene tutto questo e si chiama Maghi, guerrieri e guaritori di Fabrizio Luisi. Analizza le narrazioni politiche contemporanee e passate, e spiega come la sinistra europea negli ultimi decenni abbia sbagliato, tra le tante cose, a rinunciare a proporre agli elettori racconti semplici, visioni chiare su lavoro, reddito, diritti. Ha deciso di abbracciare invece la complessità, e quindi visioni tecniche, a volte quasi burocratiche, spesso elettoralmente inintelligibili. Ma la complessità non è per forza un valore, e non è neanche per forza neutra, anzi, nasce sempre all’interno di un frame ideologico, pensa appunto ai governi tecnici: in realtà hanno una visione politica forte, nascono da scuole di pensiero e think tank, che possa davvero esistere un mondo politico “tecnico” e non-ideologico è un’illusione.
NP: Anch’io non sono molto interno al dibattito, e ai social, mi sembra abbia già detto tutto Matteo. Se per attivismo politico si intende quello spinto ogni giorno da organizzazioni di varia natura che curano i diversi aspetti della loro missione, mi sembra ovvio che non possa esistere attivismo senza comunicazione. Quindi non riesco a capire quale sia il punto, il problema, se gruppi o attivisti di spicco comunicano via social network, visto che è parte del loro obbligo morale, del sacrificio del loro tempo…. Il mondo dei media negli ultimi anni è cambiato per sempre e queste sono solo le naturali conseguenze, si sono aggiornati i linguaggi, anche quelli rivoluzionari, o che ci provano.
I social network sono diventati anche un serbatoio di notizie per i media mainstream e laboratorio per le strategie di marketing delle aziende o delle piattaforme di streaming. Negli ultimi anni c’è stata una specie di appropriazione del discorso con tutte le incoerenze del caso.
MDG: Sono dinamiche che esistevano anche prima dei social, ma è vero che uno dei rischi maggiori, ora che il nuovo ambientalismo è entrato nel discorso pubblico, mi sembra proprio quello di lasciarlo in mano alle aziende o al cattivo lavoro dei media. Non parlo tanto di disinformazione pura, che forse è paradossalmente più facile da rintracciare e contenere. Penso più all’approssimazione e al sensazionalismo di quella che vuole essere “buona” informazione. I media che credono che il modo migliore per aumentare la “notiziabilità” della crisi climatica sia aumentare e distorcere alcuni elementi di verità perché risuonino di più. Ma se i giornali arrivano a dire, per esempio, che anche il più prevedibile degli acquazzoni è colpa della crisi climatica, allora invece che aumentare la consapevolezza del problema si finisce per dare un’arma in più ai negazionisti, che ci mettono un attimo a smentire le esagerazioni dei media e finiscono così per convincersi e convincere gli altri che l’intera narrazione climatica sia una balla. Un discorso simile vale per il greenwashing: se le parole d’ordine del nuovo ambientalismo vengono lasciate in mano alle aziende che le usano per farsi una nuova verginità, una nuova campagna di comunicazione per vendere di più magari senza neanche cambiare una virgola delle loro politiche, è ovvio che ci saranno sempre più persone disposte a pensare che l’intera faccenda climatica sia una macchinazione delle “lobby green”, una mera questione di interessi economici.
NP: Non mi sento titolato a parlare dei media mainstream perché li frequento poco, posso soltanto dire che questi media sono formati da persone con un’età media molto alta: per ovvie ragioni manca la grammatica base per comprendere la realtà che raccontano.
Se quattro anni fa mi avessero detto che nel 2021 le nuove generazioni avrebbero dimostrato questa consapevolezza intorno all’emergenza climatica, sarei rimasto sorpreso. Molti lettori sentivano parlare di Antropocene per la prima volta, si sentivano dire finalmente quanto i dati sul riscaldamento globale fossero fondati, insomma, che c’era da preoccuparsi e da informarsi.
Parliamo di “appeal dell’apocalisse”. Nel capitolo “Cervello” parlate dei limiti cognitivi che ci impediscono di recepire un pericolo così grande e di come le nostre compulsioni psichiche arrivino a preferire l’attrazione per l’apocalisse. È affascinante osservare come la nostra specie abbia imparato a convivere con il concetto di catastrofe e in qualche modo a raccontarlo in presa diretta.
NP: Se consideriamo il racconto un mezzo tecnologico, uno strumento di sopravvivenza, ci accorgiamo che è stato inventato molti anni fa, insieme al linguaggio simbolico. Oggi siamo circondati di simboli che spesso non rimandano a nient’altro che alla loro identità di prodotto; ci circondano su internet, nelle pubblicità, nei manifesti, e possono confondere, disorientare… Anche in questo smarrimento (non soltanto negli studi dell’IPCC, o leggendo il Guardian…), mi sembra, si alimenta il feticcio dell’apocalisse, della fine del mondo. Da qui nascono estetiche che diventano etiche, è un discorso lungo e complesso, cerco di semplificarlo citandoti la figura pop cruciale dell’ultimo decennio, il Joker: “c’è chi vuole vedere il mondo bruciare” e tutte quelle fesserie. In una figura pop si è incarnata tutta la paura (della classe media impoverita? spunti per un’altra intervista…) e il suo rovescio, il feticcio del caos, dello spariglio. Il Joker di Phillips ha superato un miliardo di dollari di incassi, sta lì, tra le saghe Young Adult e i Marvel (“Endgame…”). Sto divagando, cerco di chiudere: quello che ci distingue da altri mammiferi è un lobo frontale molto sviluppato, lì dentro cerchiamo di prevedere il futuro, di prepararci alle botte, ai problemi immaginati; raccontare la catastrofe è una tecnica di difesa che nella nostra epoca è stata assorbita dalla macchina dell’intrattenimento: la stessa storia però, raccontata migliaia di volte, rischia di raccontare un bel niente.